L'ECONOMIA
L'uomo per procurarsi le risorse utili alla sua sopravvivenza, ha sempre sfruttato quelle provenienti dal mondo animale e da quello vegetale. Nel compiere ciò egli assume due atteggiamenti ben precisi secondo il grado di civiltà che ha raggiunto. Le popolazioni che cercano di reintegrare ciò che consumano con il loro lavoro e con la continuità della produzione, migliorano le condizioni naturali dell'ambiente e lo sfruttano senza impoverirlo (economia produttiva); ci sono invece popolazioni che consumano le risorse del proprio ambiente senza curarsi di riprodurle (economia distruttiva). Questi due tipi di economia, nel nostro territorio si sono interrotti gradualmente a partire dagli anni sessanta, con l'avvento dell'industrializzazione (in particolare la Cartiera di Arbatax e poi l'Intermare) che hanno spostato verso questo settore buona parte della popolazione rurale, sia all'interno della stessa regione, che all'estero (emigrazione). Un'altra parte di quella popolazione rurale si è riversata in vari settori dell'artigianato. Noi abbiamo cercato di fare un elenco delle attività economiche di oggi, paragonandole a quelle di una volta.
ECONOMIA DISTRUTTIVA
LA RACCOLTA SPONTANEA
In autunno e talvolta in primavera le nostre campagne sono vivacizzate dalla presenza di numerose specie di funghi, che oltre a contribuire alla formazione dell'humus e alla vita di alcune specie boschive in cui vivono o in simbiosi, o da parassiti, o da decompositori, costituiscono motivo di raccolta per cercatori appassionati. Nel nostro territorio sono presenti numerose specie: "Cardulinu e pessa" (Cardarelli) perché vivono sfruttando le radici del cardo e della ferula; sa "Tuvaredda" (Porcini del cisto), del leccio, più ricercati; "Cardulinu bulletto", (i comuni prataioli); "Su capeddu de predi" (bubbole o ombrelli). Tuttavia l'aumento degli appassionati ricercatori e la raccolta indiscriminata che in Sardegna non è tutelata, sta causando lentamente la scomparsa di questi corpi fruttiferi.
Un particolare tipo di raccolta da parte di buongustai, è quella delle chiocciole "sissigoroso". Subito dopo i primi acquazzoni estivi, infatti questi molluschi escono alla ricerca di vegetali freschi e diventano preda di numerosi raccoglitori. Rappresentano un piatto prelibato, ma necessitano prima di essere cucinate, di una particolare preparazione: dopo la raccolta, devono essere messe a spurgare in un retino e tenute per alcuni giorni, poi lavate accuratamente e cucinate in una salsa piccante. Sempre nel periodo estivo avveniva negli anni passati, la raccolta dei fichi: messi in un cesto erano fatti seccare al sole, stesi sopra le "solette" delle case per alcuni giorni e poi conservati nelle cassapanche per l'inverno. Oggi quest'attività è in disuso, infatti vengono raccolti solo i fichi per essere consumati freschi.
Un'altra necessità della popolazione degli anni passati è stata la ricerca di asparagi, "arbarau" e cicoria oltre la raccolta di erbe medicinali (malva, semi di finocchio, menta e altre). Nelle prime giornate tiepide della primavera si raccoglievano questi vegetali per preparare gustosi piatti: i primi li si poteva trovare nel sottobosco e lungo le siepi, e poi stretti in mazzetti e legati con la foglia dell'asfodelo. La cicoria invece la si raccoglieva nei terreni umidi dei prati. Oggi al contrario di ieri, la raccolta è motivo per passeggiate rilassanti all'aperto. Un'altra attività che sta emergendo in questi ultimi anni, è legata alla raccolta delle bacche del mirto, che cresce in territori soleggiati verso la pianura e che vengono utilizzate per preparare un buon liquore digestivo.
Un tempo invece si utilizzavano le bacche del lentisco per ricavare un olio commestibile (ollu e stincu) fortemente aromatico. Castagne e noci, un tempo, come pure oggi, hanno costituito una risorsa importante per Ilbono. La zona di "Praidas" e su "Tumbarinu" in autunno si rivestiva di colori caldi e del vocio delle donne e bambini che si dedicavano alla raccolta e le trasportavano in paese in ceste sopra il capo.
LA CACCIA
 Per l'alimentazione degli ilbonesi la caccia ha avuto in passato tanta importanza, mentre oggi è semplicemente una pratica sportiva, non legata a necessità alimentari. Il territorio era ricco di lepri, cinghiali, pernici, astori, avvoltoi, gipeto, aquile, colombacci, merli e tortore che la caccia indiscriminata e incendi hanno ridotto notevolmente. Fino a sessant'anni fa, bastava, infatti, spingersi fino all'altra sponda della strada di circonvallazione per poter prendere con fucili o lacci pernici e lepri. Proprio servendosi di lacci e trappole era molto diffusa la caccia di frodo che durante la raccolta delle olive, era una norma. Infatti, per evitare che i volatili le mangiassero, i contadini attorno agli alberi sistemavano numerosi lacci (lensiasa) e catturavano tanti uccelli.
Per l'alimentazione degli ilbonesi la caccia ha avuto in passato tanta importanza, mentre oggi è semplicemente una pratica sportiva, non legata a necessità alimentari. Il territorio era ricco di lepri, cinghiali, pernici, astori, avvoltoi, gipeto, aquile, colombacci, merli e tortore che la caccia indiscriminata e incendi hanno ridotto notevolmente. Fino a sessant'anni fa, bastava, infatti, spingersi fino all'altra sponda della strada di circonvallazione per poter prendere con fucili o lacci pernici e lepri. Proprio servendosi di lacci e trappole era molto diffusa la caccia di frodo che durante la raccolta delle olive, era una norma. Infatti, per evitare che i volatili le mangiassero, i contadini attorno agli alberi sistemavano numerosi lacci (lensiasa) e catturavano tanti uccelli.
 Attualmente l'attività venatoria è regolata per legge ed è possibile in determinati periodi dell'anno. La caccia grossa al cinghiale tra l'autunno e l'inverno è l'appuntamento venatorio più importante per i cacciatori del territorio. Si svolge con il sistema della battuta e con la collaborazione di cani appositamente addestrati; il rituale è chiassoso ed animato e coinvolge gran parte degli abitanti del paese. La battuta è diretta dal capocaccia che nella settimana prima del giorno stabilito, effettua con attenzione la perlustrazione della campagna per cercare le tracce (su manigiu) che i cinghiali lasciano nel suolo, smuovendo col muso prolungato la terra alla ricerca di ghiande, bulbi, lombrichi e funghi. La squadra, poco prima dell'alba si incontra e giunti nella zona stabilita, il capocaccia distribuisce le postazioni (sa posta) e assegna la posizione ai battitori (is canargius). Una volta che i cani scovano il cinghiale, abbaiano e corrono e favoriscono, assieme ai battitori, la fuga del cinghiale verso i passaggi obbligati, dove i cacciatori alla posta, attendono nascosti. Il cinghiale ferito a morte, è catturato e portato come un trofeo per le strade del paese. Al tiratore fortunato spettano la testa e la pelle e la "caccia grossa" si conclude con un animato spuntino.
Attualmente l'attività venatoria è regolata per legge ed è possibile in determinati periodi dell'anno. La caccia grossa al cinghiale tra l'autunno e l'inverno è l'appuntamento venatorio più importante per i cacciatori del territorio. Si svolge con il sistema della battuta e con la collaborazione di cani appositamente addestrati; il rituale è chiassoso ed animato e coinvolge gran parte degli abitanti del paese. La battuta è diretta dal capocaccia che nella settimana prima del giorno stabilito, effettua con attenzione la perlustrazione della campagna per cercare le tracce (su manigiu) che i cinghiali lasciano nel suolo, smuovendo col muso prolungato la terra alla ricerca di ghiande, bulbi, lombrichi e funghi. La squadra, poco prima dell'alba si incontra e giunti nella zona stabilita, il capocaccia distribuisce le postazioni (sa posta) e assegna la posizione ai battitori (is canargius). Una volta che i cani scovano il cinghiale, abbaiano e corrono e favoriscono, assieme ai battitori, la fuga del cinghiale verso i passaggi obbligati, dove i cacciatori alla posta, attendono nascosti. Il cinghiale ferito a morte, è catturato e portato come un trofeo per le strade del paese. Al tiratore fortunato spettano la testa e la pelle e la "caccia grossa" si conclude con un animato spuntino.
Nell'ambito dell'attività venatoria vigono alcune regole fra cui le fondamentali sono: il rispetto dell'ambiente ed il rispetto delle proprietà private.
LA PESCA NEI FIUMI
Anni fa a Ilbono, nei fiumi che attraversano il territorio, la popolazione praticava spesso il bracconaggio, perché con la pesca di frodo si riusciva ad integrare l'alimentazione, soprattutto vegetariana, di intere famiglie. Grandi quantità di trote e soprattutto di anguille venivano pescate con metodi irregolari che danneggiavano l'ambiente. Infatti, si raccoglievano ramoscelli di euforbia (lua) e di gnidio (truiscu), li si batteva con un sasso per far fuoriuscire un liquido lattiginoso e velenoso e li si immergeva nel fiume. Più a valle altri bracconieri tendevano una rete da una riva all'altra con il compito di fermare le trote e le anguille ormai stordite, che venivano poi raccolte.
A risentirne erano, indirettamente, i pastori, il cui gregge abbeverandosi a quel ruscello, veniva talvolta decimato dal veleno. Anche la vita stessa del ruscello stesso ne risentiva nella sua flora e nella sua fauna, come pure nelle sue sponde. Un altro metodo consisteva nel creare un ostacolo con fascine fatte di tralci di vite che, poste trasversalmente al corso del fiume, consentivano il fluire dell'acqua, ma ostacolavano e bloccavano il passaggio delle anguille.
GLI INCENDI
 Ogni anno diverse centinaia di ettari di macchia mediterranea e boschi vengono percorsi dagli incendi ed il fenomeno, pur non avendo un andamento regolare e variando di anno in anno, in funzione di diversi fattori, ha fatto registrare, negli ultimi periodi, un considerevole preoccupante aumento in tutta l'area della Comunità Economica Europea, ma soprattutto nelle regioni a clima caldo - arido.
Ogni anno diverse centinaia di ettari di macchia mediterranea e boschi vengono percorsi dagli incendi ed il fenomeno, pur non avendo un andamento regolare e variando di anno in anno, in funzione di diversi fattori, ha fatto registrare, negli ultimi periodi, un considerevole preoccupante aumento in tutta l'area della Comunità Economica Europea, ma soprattutto nelle regioni a clima caldo - arido.
 Nel nostro territorio, ove notoriamente gli incendi costituiscono una sorta di male endemico con radici profonde, il numero degli eventi è alquanto elevato. Le superfici ricoperte da oliveti, mandorleti e frutteti, annualmente percorse dal fuoco, sono piuttosto consistenti, sia in assoluto, sia in relazione al già ridotto patrimonio forestale della Sardegna. Le cause che determinano l'insorgenza della combustione, vengono distinte in cause naturali, accidentali, cause colpose, dolose e cause sconosciute. Va detto subito che le cause naturali, come fulmini, rappresentano nel nostro ambiente una percentuale del tutto trascurabile tra i fattori che determinano gli incendi boschivi. Anche l'autocombustione, alla quale taluni vorrebbero attribuire una certa incidenza, non ha fondate ragioni d'essere, se non in particolari condizioni, che molto difficilmente possono verificarsi nel bosco. Vero è invece che la stragrande maggioranza d'incendi è riconducibile, direttamente o indirettamente, alle attività dell'uomo. Le cause accidentali, tra le quali si annoverano le scintille provocate dai treni, quelli che si sprigionano da macchine operatrici, i cortocircuiti ecc., rappresentano non più del 2% degli eventi. Quelle colpose risultano provocate da mozziconi di sigaretta, da cerini, da discariche incontrollate e irrazionali ed infine dallo abbruciamento delle stoppie e dei pascoli. Nel nostro territorio queste ultime hanno un'indubbia rilevanza: è dall'uso del fuoco, impiegato quale strumento colturale arcaico, a basso costo e di efficacia massima, che hanno origine gran parte degli incendi che annualmente devastano il nostro territorio.
Nel nostro territorio, ove notoriamente gli incendi costituiscono una sorta di male endemico con radici profonde, il numero degli eventi è alquanto elevato. Le superfici ricoperte da oliveti, mandorleti e frutteti, annualmente percorse dal fuoco, sono piuttosto consistenti, sia in assoluto, sia in relazione al già ridotto patrimonio forestale della Sardegna. Le cause che determinano l'insorgenza della combustione, vengono distinte in cause naturali, accidentali, cause colpose, dolose e cause sconosciute. Va detto subito che le cause naturali, come fulmini, rappresentano nel nostro ambiente una percentuale del tutto trascurabile tra i fattori che determinano gli incendi boschivi. Anche l'autocombustione, alla quale taluni vorrebbero attribuire una certa incidenza, non ha fondate ragioni d'essere, se non in particolari condizioni, che molto difficilmente possono verificarsi nel bosco. Vero è invece che la stragrande maggioranza d'incendi è riconducibile, direttamente o indirettamente, alle attività dell'uomo. Le cause accidentali, tra le quali si annoverano le scintille provocate dai treni, quelli che si sprigionano da macchine operatrici, i cortocircuiti ecc., rappresentano non più del 2% degli eventi. Quelle colpose risultano provocate da mozziconi di sigaretta, da cerini, da discariche incontrollate e irrazionali ed infine dallo abbruciamento delle stoppie e dei pascoli. Nel nostro territorio queste ultime hanno un'indubbia rilevanza: è dall'uso del fuoco, impiegato quale strumento colturale arcaico, a basso costo e di efficacia massima, che hanno origine gran parte degli incendi che annualmente devastano il nostro territorio.
Comunemente si è portati ad identificare il danno prodotto dal fuoco con la perdita di massa legnosa, che va distrutta e con le ferite inferte al paesaggio. Oltre ai danni provocati alla copertura vegetale, il forte calore sprigionato dagli incendi provoca delle alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno, conseguenti alla distruzione della sostanza organica, della flora microbica e della fauna che si trova negli strati più superficiali del suolo. Gli effetti indotti sulla vegetazione dalla accresciuta disponibilità di elementi minerali contenuti nelle ceneri e dallo stimolo al ricaccio esercitato sulle piante pollonifere, sembrano esaltare nell'immediato la benefica azione del fuoco e quindi contrastano con le affermazioni appena fatte: è questo fattore che induce alcuni utilizzatori del territorio a ritenere positiva in assoluto l'azione del fuoco e a persistere nel suo impiego come strumento colturale. In un territorio danneggiato da un incendio cominciano subito a manifestarsi gli effetti negativi prodotti dal dilavamento e dall'erosione, con una conseguente perdita del suolo e della fertilità, che però si avverte solo dopo qualche anno.
Dopo il primo incendio, la natura va ricomponendo il suo equilibrio, anche se molto lentamente. Quando invece gli incendi si ripetono a breve intervallo di tempo, la natura subisce delle modificazioni nella sua struttura floristica: la vegetazione diviene sempre più rada, al posto degli alberi compaiono gli arbusti e al posto di questi i cespugli, al posto dei cespugli compaiono lande spoglie che preludono ad un terreno spoglio e desertico.
Venendo a mancare la funzione protettiva della natura si determina un aumento del ruscellamento e dell'erosione, un maggior trasporto solido a valle e crescono i rischi d'inondazioni in pianura. Infatti, proprio alcuni anni fa, esattamente nel novembre del 1994, poche ore di pioggia torrenziale hanno dilavato il terreno in collina, trascinando a valle i detriti che hanno ostruito il letto del fiume, ostacolando e impedendo il defluire dell'acqua verso il mare. Il paesaggio circostante, terminata la pioggia, appariva completamente stravolto e modificato. Infatti, numerosi alberi e canneti erano stati addirittura sradicati e occupavano il letto del fiume che si era allargato di parecchi metri. A risentirne furono soprattutto i proprietari di orti e campagne circostanti, che si ritrovarono davanti spiazzi sabbiosi e pianeggianti, che difficilmente sarebbero ridiventati coltivabili. Ci sembra che da allora nella cultura degli ilbonesi, qualcosa sia cambiato: c'è più attenzione per l'ambiente, sono diminuiti gli incendi e si opta per una piantumazione più estesa nel territorio (ulivi, eucalipti).
LA PASTORIZIA
La pastorizia in passato era assieme all'agricoltura, l'attività principale svolta dagli abitanti di Ilbono. Dall'allevamento delle pecore, meno da quello delle capre, traevano tanti prodotti che erano alla base della loro alimentazione e che costituivano spesso baratto con prodotti dell'agricoltura e del commercio in genere. I pastori producevano oltre la carne, la lana e le pelli, formaggi freschi e secchi, ricotta e naturalmente latte. Inoltre, a differenza dell'agricoltore, il pastore trascorreva appresso al gregge giornate intere, per cui diventava indispensabile disporre di un rifugio per sé e per gli animali. L'abitazione del pastore, "su coili ", era una recinzione circolare in pietra, alta circa un metro, su cui poggiavano dei pali in legno disposti a forma conica, ricoperti di frasche. All'interno, in posizione centrale c'era "su foxili ", il fuoco sempre acceso, il cui fumo insaporiva e asciugava il formaggio, disposto su mensole di canne che pendevano dalla struttura di legno.
In altre mensole erano disposti altri attrezzi per fare il formaggio, "su caddargiu", in rame stagnato all'interno, "su pilisi", frusta di legno costruita artigianalmente, "is siccias" i secchi per il latte, "is aiscus" (forme bucherellate in alluminio), "is tullasa" le schiumarole. Non mancava il fucile, una sicurezza contro volpi e cani randagi. Non mancavano naturalmente le derrate alimentari, di lunga durata come il pistoccu, l'olio, il lardo, il prosciutto, la salsiccia, i legumi secchi e le patate: il tutto naturalmente prodotto da loro stessi. Infatti, attorno a "su coili", spesso il pastore coltivava le patate, i piselli, le fave e altri ortaggi.
Tanta importanza era riservata al rifugio degli animali:
"su passiali", piccolo appezzamento di terreno recintato dove il bestiame trascorreva la notte o le ore di riposo pomeridiane, durante l'estate ("su meriagu"). "Sa corte", era un piccolo recinto dove il gregge veniva raccolto per la mungitura perché non si potesse muovere troppo. "S'eili" un altro recinto in cui si richiudevano i capretti dopo l'allattamento e fino al giorno dopo.
LA LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO
Il latte appena munto, veniva versato in "su caddargiu", messo sul fuoco, e raggiunta una certa temperatura, vi si versava "su cagiu", il latte quagliato contenuto nello stomaco del capretto o dell'agnello. Dopo con "su pilisi", il latte già quagliato veniva sminuzzato e lasciato riposare per dieci minuti. A questo punto il pastore, con le sue mani esperte, separava i fiocchi di formaggio dal siero, li metteva in "s'aiscu", contenitore bucherellato per consentire al residuo siero di fuoriuscire; dove il formaggio doveva essere continuamente pressato per assumere la forma; infine dal siero dolce, di nuovo riscaldato ad alta temperatura, veniva estratta con le schiumarole la ricotta.
LA TOSATURA
La tosatura costituiva un forte momento di aggregazione sociale e di reciproco aiuto sia per i pastori del paese che per parenti e amici. Oltre l'aspetto faticoso, c'era il momento di festa e baldoria atteso dopo le fatiche dell'inverno.
I pastori durante le prime settimane di maggio (molto dipendeva dal clima) si preparavano per la tosatura delle pecore, portandole in appositi recinti volta per volta e legandole per le zampe. Ad uno ad uno entravano i tosatori, che muniti di forbici apposite procedevano al taglio della lana, partendo dal capo e proseguendo per il collo fino alle zampe. Infine veniva tosata la pancia e la schiena. La lana si raccoglieva in sacchi e le pecore finalmente erano libere di tornare al pascolo. Il lavoro terminava con l'immancabile arrosto, vino e dolci tipici. All'occorrenza la lana veniva lavata, dipanata e fatta asciugare; se poi serviva, le donne la filavano e la tessevano.
Annualmente un altro impegno del pastore era legato alla transumanza. Alla ricerca di pascoli più ricchi e abbondanza d'acqua, lasciava la collina o la pianura e raggiungeva la montagna nel periodo estivo, da dove discendeva all'inizio dell'autunno, lungo percorsi naturali, vecchi di secoli. Oggi la pastorizia, così come veniva praticata non esiste più. Infatti, oggi i pastori di Ilbono quotidianamente raggiungono gli ovili con l'automobile, rientrando a casa per le necessità eventuali. Anche all'ovile inospitale di un tempo si è sostituita la casa in muratura con le comodità moderne. Ci sembra opportuno precisare che anche ad Ilbono, come in altre parti della Sardegna, negli anni cinquanta, alcune famiglie di pastori si sono trasferite definitivamente nelle campagne del Lazio e della Toscana.
ECONOMIA PRODUTTIVA
 La conformità del terreno di Ilbono, particolarmente ricca di pendenze, ha condizionato non poco l'esercizio dell'attività agricola, che tuttavia è stata, fino a pochi decenni fa, assieme a quella pastorale, l'attività prevalente. Ma la laboriosità delle persone, unita alla necessità di procurarsi da mangiare, ha spinto le stesse ad industriarsi al massimo per rendere fertili e produttivi i terreni. I contadini soprattutto, servendosi di attrezzature semplici e quindi con immensa fatica, hanno terrazzato e poi dissodato costoni ripidi e impervi, li hanno piantumati per impedire che piogge torrentizie li dilavassero e poi li hanno fittamente irrigati, compiendo talvolta vere operazioni di ingegneria, tramite canali e tubature che dal fiume consentivano il passaggio dell'acqua alle varie terrazze.
La conformità del terreno di Ilbono, particolarmente ricca di pendenze, ha condizionato non poco l'esercizio dell'attività agricola, che tuttavia è stata, fino a pochi decenni fa, assieme a quella pastorale, l'attività prevalente. Ma la laboriosità delle persone, unita alla necessità di procurarsi da mangiare, ha spinto le stesse ad industriarsi al massimo per rendere fertili e produttivi i terreni. I contadini soprattutto, servendosi di attrezzature semplici e quindi con immensa fatica, hanno terrazzato e poi dissodato costoni ripidi e impervi, li hanno piantumati per impedire che piogge torrentizie li dilavassero e poi li hanno fittamente irrigati, compiendo talvolta vere operazioni di ingegneria, tramite canali e tubature che dal fiume consentivano il passaggio dell'acqua alle varie terrazze.
L'AGRICOLTURA
 Accanto alla pastorizia, gli Ilbonesi hanno sempre praticato un'agricoltura molto attiva, anche se condizionata dall'aspetto del territorio. Già il canonico Cocco fornisce dati precisi: nel secolo scorso si seminavano oltre 200 starelli di grano, 150 di orzo, 500 di fave, mentre per il clima favorevole, cresceva e si sviluppava la vite. Proprio quest'ultima coltivazione, grazie a innesti di altre varietà, consente oggi di ottenere diversi tipi di vino: soprattutto cannonau, ma anche girò, vernaccia, moscato e vermentino, che per bontà e qualità hanno trovato smercio fra le popolazioni della Barbagia. Strettamente legata alla produzione vinicola, è stata sempre la distillazione artigianale dell'acquavite, che non consentita legalmente, è sempre avvenuta quasi clandestinamente. Grande importanza nell'economia ilbonese ha avuto, oggi un po' meno, la produzione di frutta: albicocche, arance, limoni, mandarini, pere, mele, che a partire dai primi decenni del secolo hanno trovato smercio nei mercati generali di Cagliari tramite la stazione ferroviaria di Elini. In anni più recenti la frutta viene acquistata da negozianti per i grossisti che quotidianamente raggiungono i mercati generali con i loro camion.
Tuttavia nell'attività agricola, il comparto olivicolo è quello che ha rivestito nell'economia ilbonese un posto di rilievo, coinvolgendo per mesi intere famiglie.
Accanto alla pastorizia, gli Ilbonesi hanno sempre praticato un'agricoltura molto attiva, anche se condizionata dall'aspetto del territorio. Già il canonico Cocco fornisce dati precisi: nel secolo scorso si seminavano oltre 200 starelli di grano, 150 di orzo, 500 di fave, mentre per il clima favorevole, cresceva e si sviluppava la vite. Proprio quest'ultima coltivazione, grazie a innesti di altre varietà, consente oggi di ottenere diversi tipi di vino: soprattutto cannonau, ma anche girò, vernaccia, moscato e vermentino, che per bontà e qualità hanno trovato smercio fra le popolazioni della Barbagia. Strettamente legata alla produzione vinicola, è stata sempre la distillazione artigianale dell'acquavite, che non consentita legalmente, è sempre avvenuta quasi clandestinamente. Grande importanza nell'economia ilbonese ha avuto, oggi un po' meno, la produzione di frutta: albicocche, arance, limoni, mandarini, pere, mele, che a partire dai primi decenni del secolo hanno trovato smercio nei mercati generali di Cagliari tramite la stazione ferroviaria di Elini. In anni più recenti la frutta viene acquistata da negozianti per i grossisti che quotidianamente raggiungono i mercati generali con i loro camion.
Tuttavia nell'attività agricola, il comparto olivicolo è quello che ha rivestito nell'economia ilbonese un posto di rilievo, coinvolgendo per mesi intere famiglie.
LA RACCOLTA E LA LAVORAZIONE DELLE OLIVE
La raccolta delle olive è un'attività antichissima ed oggi non è molto differente da com'era praticata una volta. Era ed è, infatti, un'attività molto impegnativa, perché molto tempo prima della raccolta, era opportuno dedicare giorni alla preparazione de "is prassasa", lo spiazzo attorno alle piante che veniva pulito dalle erbacce, per rendere più facile la raccolta; da questa, più o meno abbondante dipendeva lo stato economico della famiglia. L'olio, infatti, serviva per gli usi principali della famiglia stessa, oppure venduto o scambiato con altri prodotti. Quando le olive erano mature, o si aspettava che venissero buttate giù dall'albero dal vento, oppure gli uomini, con delle lunghissime canne, scuotevano l'albero e le donne le raccoglievano.
Solitamente per gli uomini che abbattevano le olive, la paga era di 1 litro e ½ di olio al giorno, mentre per le donne era di ½ litro: questo perché il lavoro maschile era ritenuto più rischioso. I sacchi delle olive venivano trasportati in paese da muli e cavalli, oppure da carri, per i più "ricchi". Una volta in casa esse dovevano essere sparse in un luogo ben pulito e asciutto e lasciate lì per alcuni giorni in modo che perdessero un po' dell'acqua che contenevano e poi portate al mulino o frantoio. Esistevano due tipi di frantoi, quello ad acqua e quello azionato da cavalli. Quello ad acqua era costruito in prossimità dei fiumi e messo in funzione dallo scorrere dell'acqua che faceva girare un'enorme ruota in legno che a sua volta muoveva gli ingranaggi.
Questo tipo di frantoio non esisteva nel paese ma fuori presso i ruscelli. Quello azionato dai cavalli era costituito invece da una grande ruota di granito che girava su un ripiano di pietra dove venivano depositate le olive. Il ripiano era rialzato da un bordo alto circa 50 cm che aveva una doppia funzione: evitare la fuoriuscita delle olive e mantenere la direzione al cavallo bendato. La ruota, del diametro di 160 cm circa era collegata al cavallo tramite un asse. Il cavallo, girando, faceva girare anche la ruota, che però non macinava le olive, ma le schiacciava soltanto, trasformandole in una pasta omogenea. Questa veniva raccolta in un tino e da questo in cestini rotondi bassi, chiusi, in giunco, con un foro centrale atto a riempirli di pasta d'olive. Poi i cestini venivano sistemati sotto un ripiano di granito e pressati con una pressa che secoli fa era di legno, poi venne sostituita con una metallica. La pressa veniva abbassata da un perno (una vite senza fine) che in alto aveva un cubo di legno con quattro fori. In uno di questi veniva inserito un bastone che girato con la forza delle braccia, faceva girare il perno e quindi abbassava la pressa sui cestelli della pasta d'oliva. Il ripiano, su cui erano poggiati i cestelli, era aperto da un lato, per permettere la raccolta dell'olio e acqua, che usciva dai cesti schiacciati. Il liquido suddetto era raccolto in un tino sistemato in un incavo del pavimento. Il tino (detto "su ghirrotti") aveva la capacità di circa 100 litri, il tanto di una macinata d'olive. Questo tino con dentro il liquido veniva tirato su e lasciato riposare per qualche ora, in modo che l'olio affiorasse e l'acqua si depositasse sul fondo. Per mezzo di particolari raccoglitori (is lappiasa), l'olio veniva raccolto e immesso in recipienti di latta, per essere portati via o col cavallo, oppure a spalla inseriti a due a due in una bisaccia tenuta su un bastone. L'acqua veniva messa in un grande tino per vari giorni sino a quando in superficie non affiorava il rimanente olio, che veniva raccolto dal frantoiano. L'ultima acqua, residua, scorreva nelle vie perché non esisteva fogna, colorandole di scuro. La pasta d'olive, tolta dai cestelli, veniva lavorata una seconda volta per un periodo inferiore: un'ora circa.
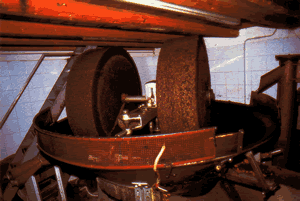 Per una macinata erano necessarie sette misure, ciascuna misura (sa carra) aveva la capacità di 25 litri. Si ottenevano all'incirca dai 18 ai 30 litri: ciò dipendeva dalla qualità della maturazione e dall'esposizione a sud degli alberi. Il compenso per il frantoiano, per ogni macinata era di 3 litri d'olio. Negli anni 20' i frantoi ad Ilbono erano 19. Nell'intera giornata un frantoio poteva lavorare ininterrottamente cinque macinate, cambiando naturalmente il cavallo. Per ogni macinata il cavallo doveva girare tre ore per la prima spremitura, un'ora per la seconda. Il frantoio era costruito artigianalmente, quindi non molto costoso, ma era necessario l'intervento di molta manodopera, pagata in natura. La qualità dell'olio era strettamente legata alle modalità di conservazione delle olive prima della macinazione; se erano marce la qualità e il gusto dell'olio ne risentiva.
Per una macinata erano necessarie sette misure, ciascuna misura (sa carra) aveva la capacità di 25 litri. Si ottenevano all'incirca dai 18 ai 30 litri: ciò dipendeva dalla qualità della maturazione e dall'esposizione a sud degli alberi. Il compenso per il frantoiano, per ogni macinata era di 3 litri d'olio. Negli anni 20' i frantoi ad Ilbono erano 19. Nell'intera giornata un frantoio poteva lavorare ininterrottamente cinque macinate, cambiando naturalmente il cavallo. Per ogni macinata il cavallo doveva girare tre ore per la prima spremitura, un'ora per la seconda. Il frantoio era costruito artigianalmente, quindi non molto costoso, ma era necessario l'intervento di molta manodopera, pagata in natura. La qualità dell'olio era strettamente legata alle modalità di conservazione delle olive prima della macinazione; se erano marce la qualità e il gusto dell'olio ne risentiva.
 Ma se le olive erano buone, l'olio era ottimo e migliore di quello attuale. L'olio veniva conservato dentro orci (su giru) di terracotta, rivestiti internamente di una vernice isolante che rendeva gli stessi all'interno lucidi e non porosi: questa vernice era naturale.
Ma se le olive erano buone, l'olio era ottimo e migliore di quello attuale. L'olio veniva conservato dentro orci (su giru) di terracotta, rivestiti internamente di una vernice isolante che rendeva gli stessi all'interno lucidi e non porosi: questa vernice era naturale.
LA SAPONIFICAZIONE
Dalle indagini che abbiamo fatto fra i nostri concittadini e dalle notizie raccolte, ci ha sorpreso che a Ilbono, dopo la I° Guerra mondiale, fosse entrato in funzione un saponificio, legato all'attività olearia del frantoio di un certo Eugenio Sanguinetti in località "Bau e Porcos".
In questo frantoio lavoravano numerosi ilbonesi alla produzione di olio di oliva e di sansa. Proprio dalla raffinazione di quest'ultima si otteneva la materia grassa indispensabile per la preparazione del sapone che fatto asciugare per alcuni giorni in appositi contenitori in legno, veniva poi tagliato in piccoli pani sui quali veniva apposto il timbro del produttore e commerciato nel resto dell'isola. E' opportuno però ricordare che anche le famiglie ilbonesi solitamente si preparavano il sapone in casa, seguendo una tecnica abbastanza semplice. Infatti, partendo dal grasso animale o vegetale e sciogliendolo in acqua e soda si otteneva un composto che doveva amalgamarsi completamente a una certa temperatura. Le dosi erano: 1Kg. di materia grassa, un litro di acqua e 100 grammi di soda caustica. Poiché questo composto era poco gradevole all'odorato, venivano aggiunte erbe aromatiche per dargli una certa profumazione. In tempi più recenti si aggiungerà invece un detersivo in polvere profumato, prodotto industrialmente.
LA COLTIVAZIONE DEL GRANO
 Ad Ilbono, per la localizzazione collinoso-montana, veniva coltivato poco grano, quindi i contadini erano costretti ad affittare i terreni pianeggianti vicini al mare, dove si spostavano per un determinato periodo. Infatti, era necessaria una preliminare attività di preparazione del terreno stesso: venivano tagliati i cespugli e bruciati alla fine dell'estate e la cenere concimava il terreno. Quindi veniva dissodato, arato, sarchiato e preparato per la semina, che avveniva fra ottobre e novembre. Gli attrezzi usati erano gli stessi usati da secoli: aratri in legno ai quali verrà poi applicato un vomere in acciaio, naturalmente trainato da buoi. Dopo la germinazione, il terreno veniva zappato per estirpare le erbacce: si trattava di un'attività alquanto delicata, riservata soprattutto alle donne, più attente e precise e talvolta doveva essere ripetuta. Quando il grano era maturo, veniva falciato a mano dai mietitori, raccolto in piccoli fascetti (mannugru) e accatastato a formare i covoni (su muntone). Questi poi venivano portati nelle aie (orgiolas) lì trebbiati: un sasso attaccato al giogo dei buoi era trascinato sull'aia con la funzione di staccare il chicco dalla pula. Poi col tridente (su trubussu) si sollevava il tutto verso l'alto e la ventilazione adeguata portava la pula lontano, mentre i chicchi, più pesanti, cadevano vicino. Un'ulteriore pulitura avveniva con le pale, per cui il grano, cadendo formava dei mucchi di forma particolare, e veniva poi raccolto in sacchi di iuta e all'occorrenza portato al mulino.
Ad Ilbono, per la localizzazione collinoso-montana, veniva coltivato poco grano, quindi i contadini erano costretti ad affittare i terreni pianeggianti vicini al mare, dove si spostavano per un determinato periodo. Infatti, era necessaria una preliminare attività di preparazione del terreno stesso: venivano tagliati i cespugli e bruciati alla fine dell'estate e la cenere concimava il terreno. Quindi veniva dissodato, arato, sarchiato e preparato per la semina, che avveniva fra ottobre e novembre. Gli attrezzi usati erano gli stessi usati da secoli: aratri in legno ai quali verrà poi applicato un vomere in acciaio, naturalmente trainato da buoi. Dopo la germinazione, il terreno veniva zappato per estirpare le erbacce: si trattava di un'attività alquanto delicata, riservata soprattutto alle donne, più attente e precise e talvolta doveva essere ripetuta. Quando il grano era maturo, veniva falciato a mano dai mietitori, raccolto in piccoli fascetti (mannugru) e accatastato a formare i covoni (su muntone). Questi poi venivano portati nelle aie (orgiolas) lì trebbiati: un sasso attaccato al giogo dei buoi era trascinato sull'aia con la funzione di staccare il chicco dalla pula. Poi col tridente (su trubussu) si sollevava il tutto verso l'alto e la ventilazione adeguata portava la pula lontano, mentre i chicchi, più pesanti, cadevano vicino. Un'ulteriore pulitura avveniva con le pale, per cui il grano, cadendo formava dei mucchi di forma particolare, e veniva poi raccolto in sacchi di iuta e all'occorrenza portato al mulino.
I MULINI
Il mulino antico era il "centimulo", costituito da un tino in legno, dentro cui stavano due coni di pietra vulcanica, inseriti uno dentro l'altro, in modo tale che tra i due coni restasse uno spessore di larghezza decrescente verso la base. La sommità del cono superiore era forata per l'introduzione del grano, tramite un imbuto regolatore. Mentre il cono inferiore era fisso, quello superiore era collegato, mediante un perno, al giogo di un asinello e vi ruotava sopra, schiacciando il grano. La farina ottenuta si depositava sul fondo del tino di legno e raccolta con una pala da uno sportello laterale. Con questa farina, che com'è facilmente comprensibile, non era lavorata finemente, si preparava un pane particolarmente saporito. Solo poche famiglie possedevano il "centimulo", ma lo affittavano ad altre, dietro un compenso adeguato. Per macinare 10 Kg. di grano si impiegava un'intera giornata lavorativa (otto ore) eppure fino al 1925 questo mulino era ancora funzionante. Dopo, infatti, comparve il mulino "a palmenti": costituito da due ruote spesse 25 cm. e con un diametro di 100-120 cm, in un particolare tipo di pietra (la fertè), importata dalla Francia. Le due ruote, sistemate una sopra l'altra, erano fissa quella inferiore, mobile l'altra e azionata inizialmente da un meccanismo idraulico sostituito poi da un motore a scoppio, alimentato da carbone vegetale. Il grano veniva versato tramite un imbuto in un foro centrale della ruota superiore che girando lo trasformava in farina; questa veniva raccolta da un canaletto applicato al grande contenitore di ferro o legno che conteneva i palmenti. Sotto il contenitore erano poi sistemate due ruote dentate, una di ferro con la dentatura in legno, che riceveva il movimento; l'altra in ferro e collegata al motore imprimeva il movimento. Per macinare un quintale di grano occorreva un'ora, di più se il movimento era idraulico. Inizialmente a Ilbono erano presenti due mulini ad acqua: uno a "Samunadorgiu", l'altro a "Mamutera", mulini che poi saranno alimentati dal motore a scoppio ed elettricamente.
PREPARAZIONE PISTOCCU
Ingredienti: farina di grano duro; sale; patate; acqua; lievito sardo (su framentu) ora di birra.
Anticamente non si trovava la farina pronta come oggi, ma la si doveva preparare a casa. Pertanto si prendeva il grano che veniva prima lavato e poi messo ad asciugare. Dopo veniva portato al mulino per essere macinato e pesato. Dalla macinatura si otteneva una farina integrale che a casa veniva setacciata per separare la semola dalla crusca e farne l'uso dovuto. Poiché prima non esisteva il lievito di birra, era norma conservare e prestare a chi lo richiedeva "su framentu" perché se ne servisse e ne preparasse un altro pezzo fresco perché non doveva guastarsi, conservandolo in un grosso cucchiaio di legno. Le massaie che dovevano fare su "pistoccu", si alzavano la mattina presto e in un ambiente abbastanza tiepido che favorisse la lievitazione, iniziavano i lavori. Versavano la farina in un grosso contenitore di terracotta, "s'impastera", vi aggiungevano le patate lessate e passate, il sale, l'acqua e su framentu. Impastavano con le mani a pugno perché il tutto si amalgamasse bene e lasciavano poi l'impasto a lievitare, coperto e al caldo. Nel frattempo si accendeva il fuoco nel forno, aggiungendo legna ogni tanto perché doveva raggiungere una certa temperatura. Costantemente era opportuno controllare la lievitazione e ciascuna massaia con la sua esperienza capiva quando era giunto il momento di passare alla seconda fase di lavoro. A quel punto si sistemava "sa mesa de fai pani", un tavolo lungo, non altrettanto largo, e lo si cospargeva di semola. Dall'impastiera si prendeva un pezzo di pasta lievitata di circa tre kg. che sul tavolo veniva allungato, poi schiacciato e con il mattarello, "su tutturu", gli si dava la forma di un rettangolo alto pochi centimetri, dal quale si ottenevano col taglio del coltello, quadrati di pasta "Is pigiusu". Questi pezzi di pasta fresca venivano poi sistemati, a strati perché non si attaccassero, sopra strisce di tessuto in lino "is tiagiasa" dentro un contenitore rotondo in asfodelo "su cranisteddu" e lasciati riposare perché si ultimasse la lievitazione. Quando quest'ultima era al punto ideale, si procedeva a liberare il forno dalle brace ardenti con scope di arbusti freschi, solitamente sambuco, che a contatto col caldo crepitava allegramente. Spazzata la sua base il forno era pronto a cuocere il pistoccu. Con mani abili, pezzo per pezzo, venivano sistemati su una pala in legno "sa palia" e tenuti in forno fino a che non si gonfiavano come delle bolle, segno dell'avvenuta cottura. A questo punto con una pala più sottile, solitamente in ferro, il pistoccu veniva tolto dal forno e sistemato un pezzo sull'altro perché stemperasse un po'. Quando tutto era stato ben cotto iniziava un'altra operazione: ciascun pezzo di pistoccu, "su pistoccu modde", veniva aperto diventando automaticamente due pezzi di pistoccu e così aperto rimesso in forno per renderlo croccante: "a inforrai". Qualche minuto al caldo e subito prelevato e rimesso nei contenitori di asfodelo. Naturalmente queste operazioni richiedevano una certa abilità consentendo di definire brava massaia chi indovinava i tempi di lavorazione. Solitamente quando si faceva il pistoccu si facevano anche altre specialità soprattutto dolciarie. Oggi solo poche persone continuano questa tradizione, infatti, molti per comodità preferiscono acquistare il prodotto già confezionato. Ma il sapore del pistoccu fatto a casa è tutt'altra cosa e ha un altro gusto!
IL LINO
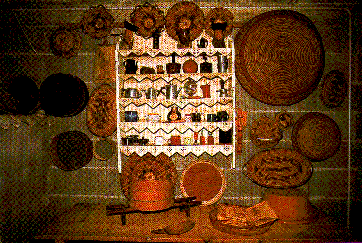 Un’altra attività agricola, diffusa e impegnativa per gli abitanti era la coltivazione del lino e la lavorazione della fibra che si otteneva. La pianta del lino veniva seminata in autunno, come il grano, su un terreno arato e raccolto a fine primavera, dopo la formazione del seme. Ma non veniva falciato come il grano, bensì estirpato con le radici. Dopo aver ridotto in fascetti le piantine, le si scuoteva per favorire la caduta dei semi, che sarebbero serviti per l’anno successivo, si depositavano quindi sulle rive del ruscello, generalmente a Sammunadorgiu, oppure nelle vasche per circa due settimane. Così le piantine ammorbidite e avendo perso le parti non utili, venivano portate a casa e messe a seccare nelle terrazze. A questo punto, iniziava il lavoro di sbattitura. Sempre riunite a fascetti, le piantine essiccate venivano inserite in uno strumento di legno detto “s’arganu” e pestate con forza, perché cadesse la parte inutilizzabile “s’ossu”. Il lavoro era pesante ed eseguito da persone esperte, che si recavano nelle case per “arganai”. A fine giornata venivano ricompensate con un fascetto di piantine. Dopo la battitura gli steli venivano pettinati con una spazzola in ferro, provvista di manico, detta “su scardu”: si ottenevano fibre sottili, di un giallo dorato, che si disponevano nell’arcolaio, pronte ad essere filate, a seconda dell’uso che se ne faceva. Era comunque un filo pregiato e resistente, col quale si preparava il corredo.
Un’altra attività agricola, diffusa e impegnativa per gli abitanti era la coltivazione del lino e la lavorazione della fibra che si otteneva. La pianta del lino veniva seminata in autunno, come il grano, su un terreno arato e raccolto a fine primavera, dopo la formazione del seme. Ma non veniva falciato come il grano, bensì estirpato con le radici. Dopo aver ridotto in fascetti le piantine, le si scuoteva per favorire la caduta dei semi, che sarebbero serviti per l’anno successivo, si depositavano quindi sulle rive del ruscello, generalmente a Sammunadorgiu, oppure nelle vasche per circa due settimane. Così le piantine ammorbidite e avendo perso le parti non utili, venivano portate a casa e messe a seccare nelle terrazze. A questo punto, iniziava il lavoro di sbattitura. Sempre riunite a fascetti, le piantine essiccate venivano inserite in uno strumento di legno detto “s’arganu” e pestate con forza, perché cadesse la parte inutilizzabile “s’ossu”. Il lavoro era pesante ed eseguito da persone esperte, che si recavano nelle case per “arganai”. A fine giornata venivano ricompensate con un fascetto di piantine. Dopo la battitura gli steli venivano pettinati con una spazzola in ferro, provvista di manico, detta “su scardu”: si ottenevano fibre sottili, di un giallo dorato, che si disponevano nell’arcolaio, pronte ad essere filate, a seconda dell’uso che se ne faceva. Era comunque un filo pregiato e resistente, col quale si preparava il corredo.
ALLEVAMENTO
Tanti animali, venivano un tempo allevati con lo scopo di contribuire al fabbisogno familiare; tra questi il maiale, le capre, le pecore e alcuni animali da cortile. Altri animali come il cavallo, l’asino e i buoi, venivano allevati per aiutare l’uomo nei lavori agricoli e come mezzo di trasporto per spostarsi dalla campagna al paese con le rispettive provviste. D’estate, il carro a buoi era un vero e proprio mezzo di trasporto dal paese al mare: vi si caricavano viveri, figli e quanto poteva servire al soggiorno. Prima, gli animali venivano allevati per la maggior parte a casa. Di giorno, soprattutto durante la stagione estiva, venivano portati nell’orto più vicino all’abitazione e di notte venivano rinchiusi dentro un ambiente apposito oppure in una stalla; insomma vivevano insieme alle famiglie, anche perché non venissero rubati. Mentre pascolavano nei prati, negli orti o in aperta campagna, non avendo un ricovero sicuro, gli animali erano esposti ai pericoli, perché la volpe e i cani randagi erano sempre in agguato e facevano delle vere e proprie stragi. Gli animali erano nutriti con tutto ciò che offriva la campagna e con quanto l’uomo scartava dalla sua alimentazione. Poiché oggi disposizioni legislative vietano di tenere animali all’interno del centro abitato, nessuno più può allevarli a parte quelle persone che, vivendo in periferia, non trasgrediscono le norme, ma che tuttavia praticano l’allevamento come attività secondaria.
Tutta la gastronomia sarda e quindi anche quella di Ilbono è stata tradizionalmente caratterizzata dalla specifica economia agropastorale.Questo perché l’alimentazione si basava su prodotti della agricoltura e della pastorizia, cosicché il contadino consumava soprattutto i prodotti della terra e il pastore il latte e i suoi derivati. Naturalmente accadeva che l’agricoltore scambiasse col pastore i propri prodotti e viceversa; infatti il pascolo dei terreni veniva talvolta pagato con prodotti caseari che il pastore scambiava con frumento) Ma mentre il formaggio ha costituito sempre dopo il pane la parte più importante della gastronomia della Sardegna e anche di quella del nostro paese, è il consumo della carne che è stato sempre più modesto. Infatti, mentre il pastore la poteva consumare con maggiore frequenza, le famiglie contadine facevano affidamento soprattutto sul maiale allevato in casa (su mannali).A Ilbono questa usanza era diffusissima sino a non molti anni fa quando, per i motivi elencati precedentemente, si è interrotta. Il maiale lo si nutriva oltre che con i rifiuti dell’alimentazione familiare, anche con frutta, con le ghiande che andava a raccogliere nelle campagne vicine al paese o con impasti di acqua, crusca e zucche (su coginau).
La macellazione avveniva solitamente a dicembre in giornate di luna calante, fredde e secche per permettere una migliore conservazione della carne. Preliminare alla macellazione era il preparare fascine di Stachis glutinosa L. (su scovissi) che incendiate servivano per bruciacchiare le setole del maiale. Proprio questa operazione richiamava frotte di bambini festanti in attesa di rimediare o un pezzo d’orecchio, di coda o addirittura le unghie (is ungreddas). Del maiale casalingo non si sprecava niente, tuttavia l’utilizzazione delle varie parti veniva dilazionata nel tempo così da averne a disposizione tutto l’anno. Immediatamente si consumava ciò che era più facilmente deperibile come le interiora che sminuzzate e aromatizzate con aglio e prezzemolo e infilate in un budello servivano per preparare “s’ortau” che veniva cucinato in umido e una volta raffreddato affettato come un salame. Una certa quantità di carne veniva poi distribuita in dono (sa parti) che veniva ricambiata aumentando così per ciascuna famiglia la possibilità di disporre di carne fresca in tempi diversi. Particolare cura si dedicava alla preparazione della salsiccia, pezzetti di carne aromatizzati con finocchi selvatici, aceto, aglio, messa in un budello e fatta asciugare all’aperto. Addirittura dal maiale si poteva preparare il dolce: era questo fatto col sangue, lo zucchero, uva passa e aromi e messo anche questo in un budello e poi cotto in acqua. Il grasso dell’animale serviva per preparare lo strutto (ollu’e porcu) che sostituiva l’olio d’oliva nella preparazione di particolari piatti. Lo si preparava facendo sciogliere in un po’ d’acqua i pezzi di carne grassa non utilizzati per la salsiccia e il lardo dentro un contenitore abbastanza capiente. Con una schiumarola si raccoglievano i residui “sa erda” che venivano conservati e riutilizzati come companatico oppure per farcire la pasta fresca del pistoccu da infornare con l’aggiunta di olive (“sa panada”). Questa specialità veniva preparata proprio quando si faceva su pistoccu. Molto laboriosa era la preparazione dei prosciutti inizialmente pressati, salati e pepati e poi appesi in un sito ventoso a conciare. A Pasqua finalmente si potevano gustare.
L’ARTIGIANATO
 Il settore trainante dell’economia ilbonese, soprattutto negli ultimi anni è quello artigianale, cui si dedicano, con buoni risultati, molti giovani. Lo sviluppo di quest’attività ha dovuto affrontare tempi difficili, in relazione alla crisi generale nel mondo del lavoro, ma si è ripresa. Il 1980 è stato l’anno della svolta. Gli artigiani di Ilbono sono usciti dal loro guscio e hanno preso in mano le redini dell’edilizia in tutta la zona. L’agricoltura, da sempre il settore trainante dell’economia del paese, si è così un po’ spenta. Il boom dell’artigianato ha, infatti, portato ad un progressivo spopolamento della campagna.
E’ singolare il fatto che, in questa svolta, la donna è stata protagonista. Si è creata nuove prospettive ritagliandosi spazi occupazionali tradizionalmente maschili. La donna è entrata, infatti, nelle falegnamerie; ha contribuito alla rinascita di Ilbono recuperando tradizioni ormai agonizzanti come il ricamo e la tessitura, reinterpretandole con una mentalità imprenditoriale.
Il settore trainante dell’economia ilbonese, soprattutto negli ultimi anni è quello artigianale, cui si dedicano, con buoni risultati, molti giovani. Lo sviluppo di quest’attività ha dovuto affrontare tempi difficili, in relazione alla crisi generale nel mondo del lavoro, ma si è ripresa. Il 1980 è stato l’anno della svolta. Gli artigiani di Ilbono sono usciti dal loro guscio e hanno preso in mano le redini dell’edilizia in tutta la zona. L’agricoltura, da sempre il settore trainante dell’economia del paese, si è così un po’ spenta. Il boom dell’artigianato ha, infatti, portato ad un progressivo spopolamento della campagna.
E’ singolare il fatto che, in questa svolta, la donna è stata protagonista. Si è creata nuove prospettive ritagliandosi spazi occupazionali tradizionalmente maschili. La donna è entrata, infatti, nelle falegnamerie; ha contribuito alla rinascita di Ilbono recuperando tradizioni ormai agonizzanti come il ricamo e la tessitura, reinterpretandole con una mentalità imprenditoriale.
L’edilizia
Un comparto importante, in cui sono impiegate molte persone è quello dell’edilizia: i muratori di Ilbono per la loro perizia ed operosità sono conosciuti in tutta la Sardegna. Le imprese edili, infatti, contano più di 200 lavoratori, sono in genere a conduzione singola con un esiguo numero di lavoratori, per questo, difficilmente possono partecipare ad appalti pubblici. Esiste attualmente una cooperativa muratori a responsabilità limitata, di un gruppo societario collettivo e numerosi lavoratori autonomi.
La lavorazione del legno
Importantissima e apprezzata nei dintorni è la lavorazione artigianale del legno, che produce in diversi laboratori infissi, pezzi d’arredamento e addirittura ambienti in misura. Col tempo questa attività è, per certi versi, diventata una vera e propria arte. Oltre che mobili, infatti, un valente artigiano produce cassapanche, sedie, poltrone finemente intagliate e rifinite che trovano smercio anche fuori. Nel suo laboratorio egli si serve di pochi attrezzi fondamentali come: scalpelli, lime, spatole, con i quali intaglia, scolpisce, leviga con molta pazienza il legno, creando decorazioni su richiesta.
La ceramica
Non meno importante è la lavorazione della ceramica, che per parecchi anni ha prodotto pezzi finemente lavorati contribuendo a far conoscere la laboriosità di ragazze anche fuori Ilbono.
La lavorazione dei cestini
 In diretto collegamento con l’attività agricola del nostro paese, diverse persone hanno imparato a costruire cestini e contenitori in giunco, vimini o canna che li hanno accompagnati nelle fatiche dei campi, e soprattutto nella raccolta delle olive e nella vendemmia
In diretto collegamento con l’attività agricola del nostro paese, diverse persone hanno imparato a costruire cestini e contenitori in giunco, vimini o canna che li hanno accompagnati nelle fatiche dei campi, e soprattutto nella raccolta delle olive e nella vendemmia
Oggi, questa attività è ancora praticata da abili artigiani che seguono degli accorgimenti sia nel preparare l’occorrente, sia nel fare il cestino. Noi, perché quest’abilità non venga dimenticata, l’abbiamo seguita con interesse, quando ci è stata proposta da alcuni anziani del paese che, grazie al “Progetto di sviluppo locale della montagna italiana” hanno potuto mostrarci praticamente le varie fasi e il materiale usato per fare il cestino. Anticamente questi ultimi non erano preparati solo dagli anziani, ma anche dai giovani, che li vendevano per guadagnare qualche soldo. Il materiale usato è di due tipi, a seconda dell’uso cui il contenitore è destinato: germogli di olivastro e canna per i cestini più grandi (“cadinusu e cadineddas”); rametti di salice rosso (“pertia de sarpa”), raccolto lungo le sponde dei fiumi, per i cestini più delicati, destinati a contenere dolci tradizionali. Per i primi la canna veniva tagliata in 16 strisce uguali e lunghe con un coltello affilatissimo: s’iniziava col fondo di olivastro, detto “pertia de rugi” e su di esso si infilavano altre quattro strisce di olivastro, numero che poteva aumentare a seconda della grandezza desiderata per il cestino. Dopo, per tenerle ferme le si incrociava con una striscia di olivastro più tenero. A questo punto si procedeva a creare la struttura laterale: con le strisce di canna incrociate e sostenute da tre rametti di olivastro, procedendo sempre con un movimento circolare ad intreccio. Ultimata la struttura era possibile rifinire il cestino in maniera più particolareggiata. Per il tipo più ricercato, la lavorazione è all’incirca la stessa, cambiava il materiale usato che richiedeva una preparazione particolare. Infatti, la “pertia de sarpa”, raccolta nel periodo giusto, veniva scortecciata facendola scorrere in una fessura ricavata in un rametto di olivastro per ricavarne una pertica pulita, chiara e lucida.
Settore tessile e metallico
 Un altro settore artigianale è quello tessile. A Ilbono è tradizione antichissima che le ragazze imparino a ricamarsi il corredo, e da grandi, a tessere, mentre le donne anziane oggi come allora continuano a farlo nel tempo libero. Man mano che viene tramandata, questa attività va sempre più perfezionandosi, anche se l’uso dell’antico telaio è fondamentale per la creazione di capi artigianali e pregiati. Infatti, con esso si fanno coperte, tappeti e arazzi abbelliti da particolari decori e ricami che evidenziano doti di pazienza e di maestria.
Un altro settore artigianale è quello tessile. A Ilbono è tradizione antichissima che le ragazze imparino a ricamarsi il corredo, e da grandi, a tessere, mentre le donne anziane oggi come allora continuano a farlo nel tempo libero. Man mano che viene tramandata, questa attività va sempre più perfezionandosi, anche se l’uso dell’antico telaio è fondamentale per la creazione di capi artigianali e pregiati. Infatti, con esso si fanno coperte, tappeti e arazzi abbelliti da particolari decori e ricami che evidenziano doti di pazienza e di maestria.

 Una minima parte della popolazione ilbonese (maschile) si dedica alla lavorazione del ferro e delle diverse leghe: ghisa e alluminio. I luoghi ove vengono svolti i lavori sono in genere officine o appositi locali con attrezzature avanzate. I prodotti più richiesti di questo lavoro sono quelli in ferro battuto (letti, grate, ringhiere…). Ultimamente si lavora anche l’alluminio per infissi. In passato i fabbri erano quelle persone che rifacevano i ferri per gli zoccoli dei cavalli e preparavano la copertura per le ruote dei carri a buoi.
Una minima parte della popolazione ilbonese (maschile) si dedica alla lavorazione del ferro e delle diverse leghe: ghisa e alluminio. I luoghi ove vengono svolti i lavori sono in genere officine o appositi locali con attrezzature avanzate. I prodotti più richiesti di questo lavoro sono quelli in ferro battuto (letti, grate, ringhiere…). Ultimamente si lavora anche l’alluminio per infissi. In passato i fabbri erano quelle persone che rifacevano i ferri per gli zoccoli dei cavalli e preparavano la copertura per le ruote dei carri a buoi.
Meccanici e carrozzieri
A Ilbono sono presenti numerose officine, carrozzerie ed elettrauto. Anche le persone che lavorano in questo settore sono numerose. I nostri meccanici sono molto abili nel riparare le auto e i carrozzieri non sono da meno nel riverniciarle. Ci sono inoltre alcuni negozi che forniscono pezzi di ricambio per le autovetture.
Settore alimentare
Ilbono è attivo anche in altri settori dell’artigianato fra questi una realtà produttiva molto importante è la C.O.S.P.A.T; una piccola azienda che occupa circa una decina di persone, che si sono specializzate nella confezione di prodotti tipici del nostro paese: pistoccu, culurgioni, sebadas, ravioli. Il tutto viene distribuito non solo in Sardegna, ma anche nella penisola, perché per la genuinità e la squisitezza ha conquistato un buon mercato.
Le massaie ilbonesi, oltre a saper fare un ottimo pistoccu, sono anche delle ottime pasticciere; la loro bravura, unita alla bontà e naturalezza degli ingredienti usati, consente di preparare delle specialità frutto di antiche tradizioni e tramandata di madre in figlia. I più conosciuti sono gli amaretti, “su pani ’e congiu”, “is pistoccos”, che si sposano divinamente col caffè, “is pabassinas” e “su gatò”.