 Per
evidenti motivi di prestigio l'area presbiteriale intorno all'altare maggiore
fu prescelta per la collocazione dei monumenti sepolcrali della famiglia
reale angioina. Cominciandone l'esame dalla destra dell'altare maggiore,
incontriamo subito dopo la porta che immette all'atrio della sagrestia
un monumento sepolcrale anepigrafo che secondo un'opinione tradizionale
avrebbe accolto le spoglie di Giovanna I, regina di Napoli e nipote di
re Roberto, morta assassinata il 27 luglio 1382 su mandato di Carlo di
Durazzo che sarebbe salito poi al trono al suo posto con il nome di Carlo
III. In realtà l'esame delle insegne araldiche scolpite sul monumento
e delle sue caratteristiche stilistiche che ne consentono l'attribuzione
a Tino, confermano che il sepolcro deve essere identificato con quello
destinato a Maria di Valois, seconda moglie di Carlo di Calabria e madre
di Giovanna I, morta il 23 ottobre 1331 a Bari, ove si era recata in pellegrinaggio
alla basilica di San Nicola. Un documento tratto dai registri angioini
del 1339 conferma che l'esecuzione del sepolcro di Maria in S. Chiara
era stata commissionata a Tino di Camaino.
Per
evidenti motivi di prestigio l'area presbiteriale intorno all'altare maggiore
fu prescelta per la collocazione dei monumenti sepolcrali della famiglia
reale angioina. Cominciandone l'esame dalla destra dell'altare maggiore,
incontriamo subito dopo la porta che immette all'atrio della sagrestia
un monumento sepolcrale anepigrafo che secondo un'opinione tradizionale
avrebbe accolto le spoglie di Giovanna I, regina di Napoli e nipote di
re Roberto, morta assassinata il 27 luglio 1382 su mandato di Carlo di
Durazzo che sarebbe salito poi al trono al suo posto con il nome di Carlo
III. In realtà l'esame delle insegne araldiche scolpite sul monumento
e delle sue caratteristiche stilistiche che ne consentono l'attribuzione
a Tino, confermano che il sepolcro deve essere identificato con quello
destinato a Maria di Valois, seconda moglie di Carlo di Calabria e madre
di Giovanna I, morta il 23 ottobre 1331 a Bari, ove si era recata in pellegrinaggio
alla basilica di San Nicola. Un documento tratto dai registri angioini
del 1339 conferma che l'esecuzione del sepolcro di Maria in S. Chiara
era stata commissionata a Tino di Camaino. 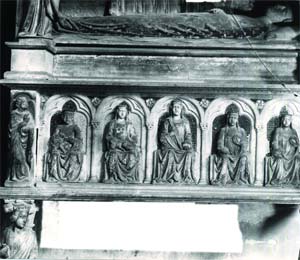 Con
ogni probabilità il monumento fu terminato entro il 1336, poiché
il 22 novembre di quell'anno si ha notizia della traslazione del corpo
della duchessa dal sepolcro provvisorio verosimilmente a quello definitivo.
Il disegno complessivo è come anticipato certamente riferibile
a Tino e riprende a modello quello del sepolcro di Maria d'Ungheria in
S. Maria Donnaregina Vecchia, ma il Maestro fu affiancato nell'esecuzione
delle parti plastiche del monumento di Santa Chiara da aiutanti di abilità
diversa. A Tino vengono pressoché concordemente riferiti i due
angeli reggicortina e la statua giacente della principessa. Le due cariatidi
tradizionalmente identificate con la Temperanza, con mazzolino di fiori
ed agnello, e la Carità, con cero e fiaccola stilizzata, hanno
invece suscitato un più acceso dibattito quanto alla loro paternità,
in effetti però entrambe vanno preferibilmente riferite al Maestro,
come pure l'Angelo e la Vergine Annunciata scolpiti alle due estremità
della faccia frontale del sarcofago. La presenza della scena dell'Annunciazione
qui come nel sepolcro di Carlo di Calabria può essere variamente
spiegata. Anzitutto è nota la particolare devozione di Carlo I
e Carlo II, nonno e padre di Roberto, per la Vergine Annunciata tanto
che entrambi vollero che il verso dei loro saluti aurei recasse appunto
la rappresentazione dell'Annuncio alla Vergine, con particolareggiata
raffigurazione del vaso con il giglio, evidente allusione anche all'insegna
araldica angioina. Quanto poi al generico significato simbolico, poiché
con l'Annunciazione si suole far coincidere l'Incarnazione di Cristo e
quindi l'inizio della Redenzione, il tema ricorre frequentemente in chiave
escatologica nell'arte funeraria medievale. Una terza cariatide della
Mansuetudine o Purezza smontata in occasione dei lavori di ripavimentazione
della chiesa nel 1705, è attualmente conservata nel coro e presenta
anch'essa i segni dell'intervento del maestro senese. Quanto poi al frontone
del sarcofago, esso è scandito da archetti al di sotto dei quali
sono raffigurati alcuni personaggi sedenti, identificati con Maria di
Valois al centro, a sinistra Giovanna I e Maria di Durazzo con le insegne
regali, e a destra Maria d'Angiò e Carlo Martello.
Con
ogni probabilità il monumento fu terminato entro il 1336, poiché
il 22 novembre di quell'anno si ha notizia della traslazione del corpo
della duchessa dal sepolcro provvisorio verosimilmente a quello definitivo.
Il disegno complessivo è come anticipato certamente riferibile
a Tino e riprende a modello quello del sepolcro di Maria d'Ungheria in
S. Maria Donnaregina Vecchia, ma il Maestro fu affiancato nell'esecuzione
delle parti plastiche del monumento di Santa Chiara da aiutanti di abilità
diversa. A Tino vengono pressoché concordemente riferiti i due
angeli reggicortina e la statua giacente della principessa. Le due cariatidi
tradizionalmente identificate con la Temperanza, con mazzolino di fiori
ed agnello, e la Carità, con cero e fiaccola stilizzata, hanno
invece suscitato un più acceso dibattito quanto alla loro paternità,
in effetti però entrambe vanno preferibilmente riferite al Maestro,
come pure l'Angelo e la Vergine Annunciata scolpiti alle due estremità
della faccia frontale del sarcofago. La presenza della scena dell'Annunciazione
qui come nel sepolcro di Carlo di Calabria può essere variamente
spiegata. Anzitutto è nota la particolare devozione di Carlo I
e Carlo II, nonno e padre di Roberto, per la Vergine Annunciata tanto
che entrambi vollero che il verso dei loro saluti aurei recasse appunto
la rappresentazione dell'Annuncio alla Vergine, con particolareggiata
raffigurazione del vaso con il giglio, evidente allusione anche all'insegna
araldica angioina. Quanto poi al generico significato simbolico, poiché
con l'Annunciazione si suole far coincidere l'Incarnazione di Cristo e
quindi l'inizio della Redenzione, il tema ricorre frequentemente in chiave
escatologica nell'arte funeraria medievale. Una terza cariatide della
Mansuetudine o Purezza smontata in occasione dei lavori di ripavimentazione
della chiesa nel 1705, è attualmente conservata nel coro e presenta
anch'essa i segni dell'intervento del maestro senese. Quanto poi al frontone
del sarcofago, esso è scandito da archetti al di sotto dei quali
sono raffigurati alcuni personaggi sedenti, identificati con Maria di
Valois al centro, a sinistra Giovanna I e Maria di Durazzo con le insegne
regali, e a destra Maria d'Angiò e Carlo Martello. 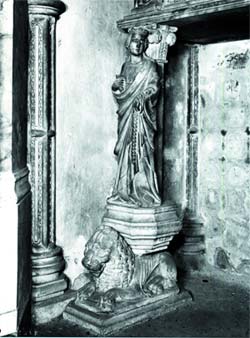 Questo
disegno complessivo segna l'abbandono da parte di Tino della impostazione
scenografica che aveva caratterizzato il frontone del sarcofago di Carlo
di Calabria precedente quello della moglie Maria ed il ritorno alla tradizionale
articolazione in nicchie ed alla rappresentazione tutta imperniata sulla
famiglia del defunto come appunto già nel monumento di Maria d'Ungheria.
In genere la critica ha respinto l'attribuzione dei bassorilievi delle
principesse al Maestro, mentre nelle figure delle facce laterali del sarcofago
ed in particolare nei bassorilievi delle Sante Chiara ed Elisabetta, è
stato sottolineato il palese intervento di Tino. Tutte le altre sculture
dovrebbero invece essere attribuite ad aiuti. Al sepolcro provvisorio
di Maria di Valois, appartengono probabilmente alcuni frammenti solo recentemente
identificati e cioè due stemmi personali della duchessa scolpiti
a bassorilievo e conservati attualmente nel coro di S. Chiara ed una pregevole
statua giacente frammentaria, esposta invece al Museo di S. Martino e
certamente proveniente dalla basilica. Di quest'ultima, rinvenuta nel
corso di lavori nell'area dell'altare maggiore di S. Chiara, condotti
intorno al 1913, comparve una riproduzione fotografica su Napoli nobilissima
nel 1921 e proprio in base alla stessa è stato possibile accertare
la provenienza, fino ad oggi ignota, del frammento. La statua in esame
fu sistemata nel 1927 circa nel cosiddetto Museo Lapidario di S. Chiara
come mostra la contemporanea documentazione fotografica. Non sono note
le circostanze nelle quali la scultura passò a S. Martino, ma può
supporsi che il trasferimento sia avvenuto nel periodo bellico o negli
anni immediatamente successivi, poichè il primo a segnalare l'opera
nel Museo fu Ottavio Morisani nel 1945.
Questo
disegno complessivo segna l'abbandono da parte di Tino della impostazione
scenografica che aveva caratterizzato il frontone del sarcofago di Carlo
di Calabria precedente quello della moglie Maria ed il ritorno alla tradizionale
articolazione in nicchie ed alla rappresentazione tutta imperniata sulla
famiglia del defunto come appunto già nel monumento di Maria d'Ungheria.
In genere la critica ha respinto l'attribuzione dei bassorilievi delle
principesse al Maestro, mentre nelle figure delle facce laterali del sarcofago
ed in particolare nei bassorilievi delle Sante Chiara ed Elisabetta, è
stato sottolineato il palese intervento di Tino. Tutte le altre sculture
dovrebbero invece essere attribuite ad aiuti. Al sepolcro provvisorio
di Maria di Valois, appartengono probabilmente alcuni frammenti solo recentemente
identificati e cioè due stemmi personali della duchessa scolpiti
a bassorilievo e conservati attualmente nel coro di S. Chiara ed una pregevole
statua giacente frammentaria, esposta invece al Museo di S. Martino e
certamente proveniente dalla basilica. Di quest'ultima, rinvenuta nel
corso di lavori nell'area dell'altare maggiore di S. Chiara, condotti
intorno al 1913, comparve una riproduzione fotografica su Napoli nobilissima
nel 1921 e proprio in base alla stessa è stato possibile accertare
la provenienza, fino ad oggi ignota, del frammento. La statua in esame
fu sistemata nel 1927 circa nel cosiddetto Museo Lapidario di S. Chiara
come mostra la contemporanea documentazione fotografica. Non sono note
le circostanze nelle quali la scultura passò a S. Martino, ma può
supporsi che il trasferimento sia avvenuto nel periodo bellico o negli
anni immediatamente successivi, poichè il primo a segnalare l'opera
nel Museo fu Ottavio Morisani nel 1945. 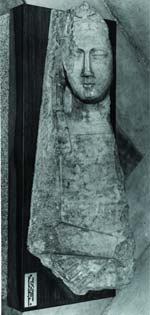 L'identificazione
della giacente con Maria di Valois può essere sostenuta in base
alla circostanza che tanto gli stemmi personali della duchessa che il
frammento di statua giacente furono rinvenuti nell'area del presbiterio
a seguito del loro reimpiego ed è obbiettivamente piuttosto improbabile
una provenienza dei tre frammenti da un monumento diverso da un sepolcro.
Inoltre la statua giacente mostra caratteri tipicamente tineschi ed è
secondo alcuni addirittura opera autografa del Maestro che, come precisato,
disegnò e parzialmente scolpì il mausoleo definitivo della
duchessa. Tuttavia al confronto con la giacente tinesca del sepolcro di
Maria d'Ungheria e con quella dello stesso sepolcro definitivo di Maria
di Valois, può rilevarsi come il frammento di San Martino presenti
orbite oculari dal taglio troppo secco, come per il naso e per le labbra
inserite in un ovale allungato e schiacciato, ben lontano dai corposi
volumi sferici delle statue di Tino e che ancora più netto e banalmente
geometrico risulti il disegno delle braccia incrociate, il che dimostra
genericamente il tentativo di imitare il maestro senese in mancanza però
di un suo diretto intervento. Comunque, se effettivamente il frammento
dovesse provenire dal sepolcro provvisorio di Maria, lo si potrebbe di
conseguenza datare a ca. il 1331-1332.
L'identificazione
della giacente con Maria di Valois può essere sostenuta in base
alla circostanza che tanto gli stemmi personali della duchessa che il
frammento di statua giacente furono rinvenuti nell'area del presbiterio
a seguito del loro reimpiego ed è obbiettivamente piuttosto improbabile
una provenienza dei tre frammenti da un monumento diverso da un sepolcro.
Inoltre la statua giacente mostra caratteri tipicamente tineschi ed è
secondo alcuni addirittura opera autografa del Maestro che, come precisato,
disegnò e parzialmente scolpì il mausoleo definitivo della
duchessa. Tuttavia al confronto con la giacente tinesca del sepolcro di
Maria d'Ungheria e con quella dello stesso sepolcro definitivo di Maria
di Valois, può rilevarsi come il frammento di San Martino presenti
orbite oculari dal taglio troppo secco, come per il naso e per le labbra
inserite in un ovale allungato e schiacciato, ben lontano dai corposi
volumi sferici delle statue di Tino e che ancora più netto e banalmente
geometrico risulti il disegno delle braccia incrociate, il che dimostra
genericamente il tentativo di imitare il maestro senese in mancanza però
di un suo diretto intervento. Comunque, se effettivamente il frammento
dovesse provenire dal sepolcro provvisorio di Maria, lo si potrebbe di
conseguenza datare a ca. il 1331-1332.