Sistema Visivo
definizione fisica
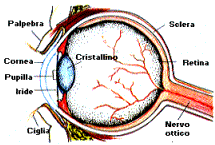
|
Sistema Visivo definizione fisica |
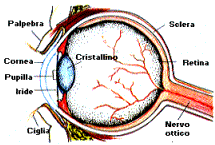 |
Apparato sensibile a quella porzione di energia
elettromagnetica che si trasmette attraverso lo spazio e che chiamiamo luce
visibile, compresa in un intervallo di lunghezza d'onda tra i 400 e i 700
nanometri. L'occhio reagisce a forme di stimolazione diversa dalle onde
luminose. Una pressione sul bulbo oculare o il passaggio di una corrente
elettrica attraverso la testa produce la sensazione della luce, che dunque è
una qualità che viene prodotta nell'occhio al momento della stimolazione.
1. L'OCCHIO UMANO. - La
luce entra nell'occhio attraverso la cornea, mentre la quantità di luce che
deve passare è regolata dalla pupilla la cui contrazione o dilatazione sono
sotto il controllo del sistema nervoso autonomo e, in particolare, del
parasimpatico che regola le variazioni di dimensione della pupilla in rapporto
alle variazioni di illuminazione. Il simpatico fa dilatare la pupilla anche
quando si verificano condizioni di forte tensione emotiva sia piacevole che
spiacevole. Il cristallino focalizza la luce sulla retina, una membrana nervosa
formata da tre strati principali: a) i coni e i bastoncelli che sono le cellule
sensitive che trasformano la luce in impulsi nervosi; b) le cellule bipolari che
stabiliscono connessioni sinaptiche con i coni e i bastoncelli; c) le cellule
gangliari che costituiscono il nervo ottico che decorre all'interno della
scatola cranica. Dopo breve percorso i nervi ottici dei due lati si incrociano
parzialmente nel chiasma ottico. In ciascuna retina si distinguono due metà,
dette nasale e temporale a seconda che siano prossime rispettivamente al naso e
alla tempia. Solo le fibre che provengono dalla metà nasale si incrociano nel
chiasma ottico per cui la metà retinica temporale di un occhio e la metà
retinica nasale dell'altro occhio ricevono gli stimoli provenienti da una stessa
metà del campo visivo. Ne consegue che una lesione del lobo occipitale di un
emisfero, dove giungono le fibre del nervo ottico per raggiungere le aree
corticali in cui avviene la rappresentazione visiva, produrrà zone cieche in
entrambi gli occhi. Questo fenomeno è spesso un indice per la localizzazione di
tumori o lesioni cerebrali. Le cellule retiniche che fungono da fotorecettori
sono i coni e i bastoncelli. I bastoncelli sono i principali responsabili della
visione a bassa intensità di luce, non segnalano i colori e danno una visione
solo in bianco e nero, i coni invece agiscono solo nella visione diurna dando
un'immagine a colori e dettagliata, permettendo di vedere sia i colori
acromatici come il bianco, il nero e i grigi intermedi, sia i colori cromatici
come il rosso, il verde, il giallo e il blu. La maggior parte dei coni si trova
nella fovea che è il centro del campo visivo e invia le sue fibre a entrambi i
tratti ottici, per cui la rappresentazione corticale di ciascuna fovea è
bilaterale. Non lontano dalla fovea vi è un'area sensibile, la macchia cieca,
dove le fibre nervose provenienti dalle cellule gangliari si raggruppano a
formare il nervo ottico.
2. LA LUMINOSITÀ - Le
singole cellule della retina codificano la luminosità attraverso la loro
attivazione: quanto più brillante è l'illuminazione, tanto più frequente è
l'attivazione delle cellule. Il passaggio dalla luce diurna a quella notturna si
verifica gradualmente. Al crepuscolo la visione dipende essenzialmente dai
bastoncelli. A un cambiamento improvviso di condizioni di luminosità l'occhio
ha bisogno di alcuni minuti per adattarsi, consentendo ai coni di diventare
gradualmente sensibili a una luce: più debole e ai bastoncelli di aumentare
progressivamente la loro sensibilità. Il meccanismo della visione dipende da
una serie di trasformazioni chimiche di una sostanza rossastra, detta rodopsina,
che scolora tendendo al giallo quando è esposta alla luce. La rodopsina è
l'intermediario tra la luce che entra nell'occhio e l'attivarsi dei nervi
sensoriali che producono la visione. La sostanza che interviene nel ciclo della
rodopsina è una forma modificata della vitamina A la cui carenza
nell'alimentazione impedisce ai bastoncelli di formare una quantità sufficiente
di rodopsina, producendo la cosiddetta cecità notturna.
3. IL COLORE. - Viene
modificato soltanto dai coni, alcuni dei quali sono sensibili al rosso, altri al
verde, altri al giallo, altri al blu. Ciascun tipo di coni possiede una distinta
sensibilità perché viene attivato da luce di una determina lunghezza d'onda.
qualsiasi colore colpisca la retina risulta composto da quantità diverse di
questi colori primari. Qui occorre distinguere la mescolanza delle luci, che è
additiva, dalla mescolanza dei pigmenti, che è sottrattiva. La luce è la
sorgente di tutti i colori e i pigmenti sono semplicemente i riflettori o
assorbitori dei colori che acquistano la loro colorazione assorbendo o
sottraendo alcune parti dello spettro e riflettendo le rimanenti. Per quanto
concerne gli attributi del colore (tonalità, chiarezza, saturazione), le teorie
sulla visione del colore (tricromatica e quadricromatica), i disturbi della
visione del colore nonché i significati emotivi e simbolici del colore,
4. LA PROFONDITÀ E LA
DISTANZA. - Il mondo reale, come il mondo percepito, ha tre dimensioni:altezza,
ampiezza e profondità. La retina dispone invece di due sole dimensioni, per cui
sorge il problema di come sia possibile codificare la distanza relativa degli
oggetti dall'osservatore. Oltre agli indizi contenuti nelle rappresentazioni
bidimensionali, come ad esempio la prospettiva, o il fatto che sulla retina gli
oggetti più lontani provocano immagini più piccole di quelle che
provocherebbero a una distanza più ravvicinata, il cervello utilizza la
convergenza degli occhi che si verifica man mano che l'oggetto si avvicina, e la
disparità retinica per cui ogni occhio riceve un'immagine leggermente diversa
dell'oggetto osservato se questo è vicino, mentre se è lontano la disparità
risulta molto minore. Combinando insieme le informazioni provenienti dalla
convergenza e dalla disparità retinica, il sistema visivo stabilisce che, se
l'indizio costituito dalla convergenza indica che l'oggetto è lontano, lievi
disparità riducono la distanza indicata dalla convergenza, ottenendo così una
corretta misura della distanza e della profondità.
5. IL MOVIMENTO.
A occhio fermo, l'immagine di un oggetto in movimento attraversa i campi
recettivi di molte cellule cerebrali. Il movimento può quindi essere codificato
tramite il passaggio dell'eccitazione da una cellula all'altra, o anche da
alcune cellule corticali che si attivano solo quando un oggetto attraversa in
una direzione particolare il suo campo recettivo. La registrazione del movimento
è tuttavia più complicata, poiché le immagini attraversano la retina anche
quando muoviamo l'occhio e, ciononostante, il movimento dell'occhio non fa si
che il mondo sembri muoversi davanti all'osservatore. La ragione sembra
risiedere nel fatto che gli impulsi nervosi, passando dal cervello ai muscoli
oculari, agiscono anche sul sistema di percezione del movimento, cosicché, se
all'occhio viene ordinato di muoversi, lo stesso ordine controbilancia l'effetto
delle immagini che attraversano i campi recettivi. Attraverso le registrazioni
elettrooculografiche sono stati individuati cinque tipi di movimenti oculari:
a)movimenti saccadici: servono a portare le fovee su un oggetto di
interesse come quando si legge o si esamina qualcosa;
b)movimenti lenti di inseguimento: servono a mantenere le fovee sull'oggetto
fissato che può essere fermo o in movimento.Si coordinano con i movimenti
della testa e determinano gli spostamenti dello sguardo;
c)nistagmo optocinetico: serie alternata di movimenti lenti di inseguimento e
di movimenti saccadici molto più veloci, come quando si fissa un punto del
paesaggio fino a che non esce dal campo visivo, dopodiché subentra una
saccade
che riporta la fissazione su un altro punto, e così via;
d)riflessi vestibolo-oculari: permettono di stabilizzare la posizione degli
occhi indipendentemente da quella della testa;
e)movimenti di vergenza: si verificano fissando un oggetto che si avvicina
(convergenza) o che si allontana (divergenza). Insieme alla disparità retinica,
la vergenza è un elemento per valutare la distanza.