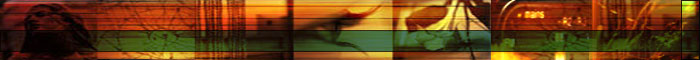| |
L¹ambiente "programmato"
e l¹attivazione dei processi di percezione e di coinvolgimento
Successivamente alla ricerca
di Fontana altri orientamenti gravitanti attorno all¹area
dell¹arte cinetica o "programmata"34,
sul finire degli anni Cinquanta, si muoveranno in direzione
di un sovvertimento della dimensione oggettuale dell¹opera,
come della plastica tradizionale, verso l¹espansione e l¹articolazione
di uno spazio fisico e percettivo più ampio e complesso,
sviluppando un nuovo, e per certi aspetti provocatorio,
rapporto con le tecnologie moderne35.
Tra il 1958 e 1965 sorgono
in Italia diversi gruppi tra cui il Gruppo T a Milano, il
Gruppo N a Padova, il Gruppo Uno e il Gruppo 63 a Roma,
il Gruppo MID nuovamente a Milano36.
Ciascuno di essi ha una formazione culturale diversa, per
cui anche i rispettivi metodi di ricerca sull¹arte cinetica
e visuale sono in parte differenti, sia nei contenuti che
negli obiettivi. Ma al di là delle differenze ciò
che interessa i programmati, come sottolinea Lea Vergine,
è: "agire all¹interno del processo operativo;
promuovere una metodologia interformativa; organizzare elementi
linguistici senz¹altro significato all¹infuori di quello
impiegato dalla propria struttura; rendere esplicite le
strutture percettive che sostengono le immagini e i messaggi
legati alle immagini stesse; l¹opera come campione tipologico
(nel senso cioè di modello); la lotta contro la mercificazione
dell¹arte, spostando la propria attività in una dimensione
didattica e in una direzione più responsabilmente
politicizzata"37.
Una tappa significativa
delle ricerche cinetiche e visuali è rappresentata
dall¹ambiente (o environment). Con esso ha inizio una fase
nuova della metodologia e della fenomenologia artistica,
che si qualifica ormai sempre più scientificamente,
tecnologicamente e sperimentalmente.
Le indicazioni di Fontana
e dei suoi manifesti si rivelano allora un punto di riferimento
importante per le pratiche di tipo ambientale e percettivo
dei gruppi cinetici in Italia, che tra l¹altro egli stesso
sosterrà direttamente38.
Con il suo Ambiente spaziale, del 1949, Fontana aveva
già sperimentato ed ottenuto una spazialità
infinita, priva di rimandi oggettuali, isolata ed isolante
nella proposizione di un ambiente nero illuminato dalla
sola luce nera di Wood. Negli ambienti (o environment) delle
proposizioni cinetiche e visuali l¹attenzione è ancora
posta sull¹attivazione delle facoltà percettive dello
spettatore il quale vive l¹opera nella sua dimensione totalizzante,
non più come oggetto, ma come un "evento continuo
che inestricabili mobilità spazio-temporali rendono
infinito"39. E continuando
con Italo Mussa: "L¹infinito è infatti il fenomeno
che più di ogni altro caratterizza la struttura spazio-visuale
dell¹ambiente programmato", quindi nell¹ambiente "Ciò
che viene sottoposto ad analisi precise sono i processi
formativi e di memorizzazione delle facoltà percettive.
L¹ambiente è uno spazio visuale (o "campo")
perfettamente progettato in cui lo spettatore, estraniato
dal mondo "esterno", si trova coinvolto in se
stesso e le sue facoltà psico-percettive vengono
sottoposte ad esercizi aventi comunque sempre funzioni estetiche"40.
Le ricerche dei "cinetici"
in Italia possono essere considerate fondamentali per l¹introduzione
della pratica "multimediale", ma soprattutto per
quella tensione verso una complementarietà estetica,
dove l¹azione del pubblico viene richiesta per compiere
e completare l¹accadimento estetico stesso, e quindi l¹introduzione
della dimensione dello spettatore-coautore. Elementi questi,
che già in parte anticipati da Fontana, diventeranno
determinanti nella pratica video degli anni Settanta, e
soprattutto nella dimensione videoinstallativa della fine
del decennio.
Interessanti per quanto
riguarda i rapporti con le future ricerche video risultano
il Gruppo MID e il Gruppo T, entrambi di Milano. Il Gruppo
MID, composto da Antonio Barrese, Alfonso Grassi, Gianfranco
Laminarca e Alberto Marangoni, nel marzo 1966 realizza il
suo primo "Ambiente stroboscopico programmato e sonorizzato"
nella Sala Espressioni Ideal Standard di Milano. In questo
environment programmato lo spettatore si trova immerso in
uno spazio totale, capace di sollecitare fino in fondo gli
stimoli ottici e psichici offerti dalla suggestiva ambientazione.
Ma più interessanti sono i tre "films di ricerca",
sempre del 1966, rivolti ad analizzare varianti ed elaborazioni
di strutture (geometriche) visuali: "Test di percezione
modale (strutturazione di forme visive semplici in successione);
Test di complessità ottimale-tempo (strutturazione
ottimale di livelli di complessità di variazioni
spazio-temporali); ed Esperimento di ripresa (serie
di riprese stroboscopiche con particolare riguardo al superamento
dell¹inconveniente delle figurazioni armoniche di luminosità)"41.
Il Gruppo T, composto da
Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele
De Vecchi e Grazia Varisco, si presenta per la prima volta
con la mostra Miriorama 1 presso la Galleria Pater di Milano
il 15 gennaio 1960. Più che una esposizione di opere
questa mostra si presenta come una sorta di happening, in
cui il "grande oggetto pneumatico", la "pittura
in fumo" e le "combustioni in superficie"
da essi presentati diventano degli elementi provocatori,
coinvolgenti ed effimeri al tempo stesso. Una delle problematiche
principali del gruppo è la relazione spazio-tempo
a cui si riferisce la loro prima "dichiarazione":
"Ogni aspetto della realtà, colore, forma, luce,
spazi geometrici e tempo astronomico è l¹aspetto
diverso del darsi dello SPAZIO-TEMPO o meglio: modi diversi
di percepire il relazionarsi fra SPAZIO-TEMPO. Consideriamo
quindi la realtà come continuo divenire di fenomeni
che noi percepiamo nella variazione"42.
L¹opera quindi cessa di avere un¹immagine unica e fissa,
tende a mutare percettivamente attraverso il movimento continuo,
programmato, e lo spettatore assume un ruolo attivo al suo
interno, per cui l¹opera da oggetto contemplativo diventa
un oggetto fruibile (e perché no manovrabile).
La cosa interessante è
che quasi tutti i membri del gruppo continueranno le loro
esplorazioni e sperimentazioni utilizzando proprio il mezzo
video e la sua particolare caratteristica di immagine elettronica,
a cominciare da Colombo che nel 1970 realizzerà delle
opere in video agendo direttamente sul dispositivo attraverso
la deformazione del segnale o programmando l¹autogenerarsi
di sequenze di immagini astratte, fino a De Vecchi che nel
segno di un diretto impegno politico utilizzerà il
medium video, come tutti gli altri media del resto, nell¹occasionalità
di una circostanziata esigenza esistenziale secondo una
pratica propriamente "extramediale"43.
Possiamo concludere quindi
affermando che le ricerche dell¹area dell¹arte cinetica
e programmata si sono rivelate determinanti per i futuri
sviluppi dell¹uso del video in arte, sia per l¹avere introdotto
in ambito estetico, e propriamente artistico, l¹uso di tecnologie
moderne e di metodologie derivate dalla ricerca scientifica,
sia per l¹avere indicato le potenzialità di "una
contaminazione visiva tra la realtà della macchina
e quella dell¹immagine"44.
Ma si riveleranno determinanti anche per quanto riguarda
alcuni aspetti linguistici, quali la strutturazione di forme
visive semplici e le loro variazioni spazio-temporali, oppure
le analisi della luce e delle sue proprietà, o ancora
l¹attenzione al movimento, elementi questi che saranno riproposti
nei decenni successivi attraverso apparecchiature elettroniche,
e trovando quindi nel mezzo video un adatto proseguimento
proprio per le sue caratteristiche linguistiche e morfologiche.

Note
- 34.
Il termine "arte programmata" viene coniato da Umberto
Eco nel 1962, in occasione della mostra Arte Programmata
organizzata dall'Olivetti di Milano: "Nelle vicende del
caso può essere individuato a posteriori una sorta di
programmaŠ e non sarà dunque impossibile programmare,
con la lineare purezza di un programma matematico, 'campi
di accadimenti' nei quali possano verificarsi dei processi
casuali. Avremo così una singolare dialettica tra caso
e programma, tra matematica e azzardo, tra concezione
pianificata e libera accettazione di quel che avverrà,
comunque avvenga, dato che in fondo avverrà pur tuttavia
secondo precise linee formative predisposte, che non negano
la spontaneità, ma le pongono degli argini o delle direzioni
possibili. Possiamo così parlare di arte programmata"
(in Introduzione al catalogo della mostra Arte programmata,
negozio Olivetti, Milano, 1962, in U. Eco, La definizione
dell'arte, Garzanti, 1978, p. 233).
- 35. Altrettanto importanti, anche se
non direttamente connesse alla ricerca video, risultano
alcune parallele proposte sviluppatesi in Italia nel corso
degli anni Cinquanta che in qualche modo porteranno a
maturazione quel clima di "smarginamento" e "partecipazione"
caratteristico dei decenni successivi. Mi riferisco alla
pubblicazione da parte di Munari, nel 1952, dei manifesti
sul Macchinismo, il Dis-int-egr-ismo, l'Arte totale, alle
ricerche sul movimento di Veronesi, o all'opera più provocatoria
del già citato Piero Manzoni, ma anche alla Grotta dell'Anti-Materia
di Pinot Gallizio (1959), oppure sempre con Gallizio all'esperienza
di Albisola Marina (1954) ed Alba (1955), dove si riunisce
il MIBI (Movimento Internazionale per una Bauhaus Immaginista)
e dove per iniziativa di questo avrà luogo il "Primo congresso
mondiale degli artisti liberi" (1956) da cui con la fusione
dell'Internazionale Lettrista prenderà avvio l'Internazionale
Situazionista (1957). Cfr. Stewart Home, Assalto alla
cultura, AAA Ed., 1996, cap. II-V.
- 36. Un aspetto interessante della situazione
italiana è che accanto ai gruppi lavorano artisti, per
così dire isolati, il cui apporto alle ricerche cinetiche
è stato grandissimo. Tra questi il già citato Veronesi,
o Fontana, ma anche Dorazio, Castellani, Munari, Mari,
Dadamaino e Nanda Vigo. Cfr. L. Vergine, Arte programmata
e cinetica, Mazzotta, Milano, 1984; E. Crispolti, Ricerche
dopo l'Informale, Officina, Roma, 1968, pp. 318-370.
- 37. Lea Vergine, L'arte cinetica in Italia,
conferenza tenuta l'11 marzo 1973, alla Galleria Nazionale
d'Arte Moderna, Roma, 1973, p. 3.
- 38. Fontana infatti scriverà la presentazione
per Miriorama 10, inaugurata il 14 aprile 1961 alla Galleria
La Salita di Roma.
- 39. Italo Mussa, Il gruppo enne. La situazione
dei gruppi in Europa negli anni 60, Bulzoni, Roma, 1976,
p. 12.
- 40. Il gruppo enne. La situazione dei
gruppi in Europa negli anni 60, op. cit., 1976, p. 12.
- 41. Il gruppo enne. La situazione dei
gruppi in Europa negli anni 60, op. cit., 1976, p. 70.
- 42. Il gruppo enne. La situazione dei
gruppi in Europa negli anni 60, op. cit., 1976, p. 57.
- 43. Tratterò più avanti il rapporto di
questi artisti con il video proprio perché rappresentano
ognuno un particolare approccio all'uso di questo mezzo
nella pratica artistica italiana degli anni Settanta.
- 44. Videoarte e arte. Tracce per una
storia, op. cit., 1995, p. 27.
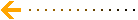

|
|