 Leopardi
tratta il tema della
morte in numerose “Operette Morali” e in particolare nel “Dialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie”, nel “Cantico
del gallo silvestre”, nel “Dialogo
di Tristano e di un amico”.
Leopardi
tratta il tema della
morte in numerose “Operette Morali” e in particolare nel “Dialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie”, nel “Cantico
del gallo silvestre”, nel “Dialogo
di Tristano e di un amico”.
 Leopardi
tratta il tema della
morte in numerose “Operette Morali” e in particolare nel “Dialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie”, nel “Cantico
del gallo silvestre”, nel “Dialogo
di Tristano e di un amico”.
Leopardi
tratta il tema della
morte in numerose “Operette Morali” e in particolare nel “Dialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie”, nel “Cantico
del gallo silvestre”, nel “Dialogo
di Tristano e di un amico”.
In queste opere la concezione della morte si specifica in forme assolutamente lontane da ogni tentazione mistico-romantica. La morte non è, infatti, il sipario che cela all’uomo il mistero profondo e ineffabile della verità e non rappresenta dunque una soglia metafisica. L’intero universo non è altro che il risibile perpetuo distruggersi e rinnovarsi delle specie e, alla lunga, anche dei mondi; la materia, con le sue eterne leggi è l’unica sostanza del reale. Al filosofo non resta che esplicitare questa verità contro ogni illusione, ribadendo la natura del tutto accessoria e decentrata dell’esistenza umana in questo universo acefalo. Una filosofia dolorosa, ma vera come la invocano Eleandro e Tristano, ritorna così necessariamente alla morte come condizione preferibile.
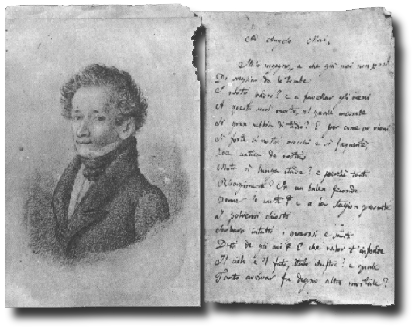
Nel “Cantico
del gallo silvestre”, la morte è intesa come “distruzione”:
l’essere delle cose ha come suo unico fine la morte, la natura intenta alla
morte in ogni sua opera, l’affrettarsi alla morte di ogni parte
dell’universo: “tanto in ogni opera sua la natura è intenta e indirizzata
alla morte” e “ogni parte dell’universo si affretta infaticabilmente alla
morte, con sollecitudine e celerità mirabile”. Il processo inarrestabile di
decadimento, la distruzione e la morte sono intese come leggi universali. La
morte è dunque “una quiete altissima” che riempie lo spazio immenso
dell’universo.

Il “Dialogo
di Federico Ruysch e delle sue mummie” è incentrato sul tema della morte.
Esso si apre con il “Coro dei morti”: i primi due versi riprendono il finale
del “Cantico”. Sola cosa eterna, reale è la morte, in questo mondo
destinato alla distruzione e che nella distruzione incessante trova il ritmo, la
condizione del proprio esistere, il cui movimento assorbe il nascere e il morire
come due aspetti complementari e reversibili. Nella morte dilegua in una pace
spenta, con un moto impercettibile, segno di una quasi sua non-presenza, la
“nostra ignuda natura” ossia il nostro immediato esistere come parte della
materia universale (distinto da Leopardi dalla “vita”, che è l’esistenza
cosciente), amorfo e indifferente. Così il defunto “consuma” non
“vive”, le “età vote e lente” d’un tempo senza tempo, senza rilievo
umano: quello dell’astratta durata cosmica. All’improvviso l’indifferenza
dei morti è scossa dal confuso aliare di un ricordo (“vivemmo”); ma è una
“confusa ricordanza”, simile a quella di altre vite precedenti che secondo
certi Sensisti, permaneva negli oggetti singoli, in quanto composti di
particelle di altri oggetti assunti, come essi, nella perpetua metamorfosi. Ma
più che una memoria, è questo il senso di un dileguare, il prolungarsi
dell’attimo della loro morte. In questa lirica Leopardi non
canta soltanto la morte che conclude il vivere, ma anche quella
consustanziata ad esso: continua la frustrazione e lo stato d’insensibilità
che consegue al tramonto delle illusioni.

Nel dialogo vero e proprio le mummie, destatesi allo scadere del “grande anno matematico”, hanno la possibilità di parlare con un vivo per un quarto d’ora. Il loro interlocutore Federico Ruysch sottopone ai morti gli interrogativi che tutti gli uomini si pongono riguardo al momento dell’addio alla vita. Egli chiede loro che sensazioni provarono nel punto della morte ed essi rispondono che non se ne accorsero come quando ci si addormenta. Al momento della morte si ha assenza di sensibilità e ciò è testimoniato anche dal fatto che chi muore per una dolorosissima malattia si acquieta poco prima della morte. Essendo la morte separazione di anima e corpo, Ruysch si chiede come ciò possa avvenire senza dolore. I morti rispondono che anima e corpo non sono legate da nessun nervo e nessuna membrana per cui la separazione avviene senza dolore e non è un male. Le mummie giungono a dire, secondo una prospettiva stoica che la morte è un piacere perché libera gli uomini dal patimento della vita e il momento proprio del trapasso è come un languore dei sensi simile al piacere.

Anche nel “Dialogo di Tristano e di un amico” la morte è vista come liberazione e viene addirittura invocata come tale. Tristano, identificabile con lo stesso Leopardi dice di invidiare soltanto i morti e qualora ottenesse la morte morirebbe così tranquillo e così contento come se mai null’altro avesse sperato né desiderato al mondo. Ed aggiunge: “Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall’altro di morire oggi, e che dovessi scegliere, io direi, morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi”.