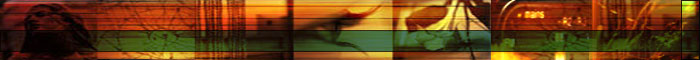| |
Sul contesto storico,
politico e culturale dell¹Italia degli anni Settanta
Uno spaccato sufficientemente chiaro della
situazione storica e culturale riferita agli anni di nascita
e sviluppo delle ricerche sul video in Italia (approssimativamente
gli anni Sessanta e Settanta) ci è offerto da Enrico
Crispolti (con l¹aiuto delle pagine della Storia d¹Italia
dal dopoguerra a oggi di P. Ginsborg) nel capitolo "Introduzione
agli anni Settanta (e oltre)" in La Pittura in Italia.
Il Novecento/3. Le ultime ricerche.
In esso, riconosciuta "una
autonomia critica dell¹artista", non più soltanto
implicito testimone, ma anche autorizzato teorico del proprio
lavoro1, e riconosciuta
una minore discontinuità fra gli anni ¹60 e i ¹70
rispetto a quella del decennio successivo, si sofferma sulla
constatazione di una diffusa volontà (negli anni
¹70 e in particolar modo in Italia) di rompere i tradizionali,
ed elitari, circuiti della fruizione dell¹opera d¹arte,
e di conseguenza le modalità operative connesse a
quei circuiti.
Se i segni di ciò
si possono rintracciare nelle proposizioni del decennio
precedente, è solo negli anni ¹70 che si manifestano
i frutti maturi nella forma di una "precisa consapevolezza
innovativa che tenta di infrangere distinzioni tradizionali,
allargando gli ambiti, i livelli e le modalità operative,
nel subentrare di nuove attenzioni e interessi antropologici
e sociologici, e di praticabilità persino politica"2.
Per cui gli anni Settanta possono essere definiti come "gli
anni dello smarginamento e della partecipazione", formula
che racchiude in sé la complessità di una
situazione culturale, nonché le problematiche specificatamente
artistiche connesse a questa situazione3.
Del resto le invitanti prospettive
di nuovi spazi e condizioni operative erano offerte agli
artisti proprio dalle molteplici tensioni e sollecitazioni
connesse alla situazione politico-sociale italiana, che
a partire dalla fine degli anni ¹60 così si delineava:
"Di fronte al fallimentare velleitarismo riformista
dei governi di centrosinistra fra il 1962 e il 1968, da
questo anno in avanti è infatti subentrata un¹intensa
attività di iniziative di base. E ne seguì
"un periodo di straordinario fermento sociale, la più
grande stagione di azione collettiva nella storia della
Repubblica", durante la quale "l¹organizzazione
della società italiana fu messa in discussione a
quasi tutti i livelli""4.
La rivolta studentesca,
a Parigi, a Roma, a Berlino, rappresentò d¹altra
parte una forte ventata di rinnovamento e di trasformazione
della consapevolezza dell¹azione culturale in senso antigerarchico,
che percorse l¹Europa nell¹intenzione di una critica radicale
alla società nei suoi fenomeni d¹egemonico espansionismo
industriale. Esprimendosi in un¹attenzione nuova portata
a modelli di operatività estremisticamente orientati
su valori emarginati e poveri, pertinenti una creatività
spontanea ed attenta ai sedimentati patrimoni antropologici
locali, particolarmente cospicui in Italia. In un¹opposizione
radicale alla mentalità Œconsumistica¹ degli anni
Sessanta, e in Italia in particolare all¹ideologia ottimistica
che aveva alimentato il mito del Œmiracolo economico¹, fu
una ventata innovatrice che trasformò effettivamente
la misura dei valori culturali, e specificamente dei valori
stessi della cultura artistica. Non tanto perché
vi furono implicati direttamente alcuni artisti postisi
al servizio del movimento (come a Parigi, così a
Torino, a Milano, a Roma). Ma in quanto aprì la prospettiva
di una liberazione sociale sul fondamento antropologico
esistenziale dei bisogni e del piacere, e dunque indicò
una possibile nuova base di motivazioni operative. Riportando
l¹attenzione su una nuova dimensione del presente, proponendo
una operatività sia intellettuale che manuale, e
rifiutando gerarchie del sistema tradizionale dell'arte
quanto delle sue tecniche e materiologie tradizionali o
moderne.
Lo stesso mito nordamericano
degli anni Cinquanta mutò alla luce degli scenari
della tragica guerra in Vietnam. E "la Œvera¹ America
divenne quella dei Œcampus¹ universitari in rivolta contro
la guerra, delle comuni californiane e della controcultura,
del Black Power"5.
A ciò si aggiungeva il fascino della Œrivoluzione
culturale¹ cinese degli anni 1966-1967, interpretata in
senso antiautoritario, non meno che il fascino delle rivolte
sudamericane (portate avanti da Che Guevara). Mentre una
forte influenza esercitava il Marcuse di L¹uomo a una
dimensione.
A questo punto si rendono
necessarie due parole riguardo alla polemica sulla cultura
di massa nel mondo industrializzato, polemica rappresentata
dalle posizioni ruotanti attorno alle figure di Marshall
McLuhan e Herbert Marcuse. Tale polemica approda in Italia
negli anni Sessanta come un blando riflesso della più
complessa situazione socio-culturale americana, la quale
già dagli anni ¹50 stava vivendo un veloce e generalizzato
processo di diffusione delle emittenti televisive, accompagnato
dal consenso di un pubblico di fruitori domestici, sempre
più bombardato dall¹accumulo di messaggi disparati6.
Prende corpo, così, "l¹ideologia dell¹ottimismo
consumista capace di unire in una ragnatela di onde o cordoni
psichici, al di là delle differenze sociali, economiche,
politiche, il pubblico sterminato e massificato dei fruitori"7.
Interrogandosi sul destino
di una tale società McLuhan arrivò alle conclusioni
che era inutile focalizzare l¹attenzione sui contenuti delle
comunicazioni di massa, sul messaggio, quando questi venivano
trasmessi attraverso i vari media, ma erano i media stessi
a determinare attraverso la loro specifica natura risposte
di comportamento che avrebbero favorito mutazioni complessive8;
mentre, dall¹altra posizione, le formulazioni più
politiche di Marcuse tendevano a evidenziare come attraverso
i media si sia attuata, da parte della società repressiva,
una grande e programmata aggressione con la creazione di
un "uomo unidimensionale", mutilato di quella
ambiguità che fa ricco il reale, problematica la
vita, attiva la partecipazione9.
Tornando alla situazione
politica italiana vediamo che lo scorcio degli anni Sessanta
era segnato in Italia anche dall¹acuirsi delle lotte operaie,
e dall¹organizzarsi di gruppi rivoluzionari, oltre che il
costituirsi dal 1968 stesso della Nuova Sinistra Italiana.
La risposta reazionaria fu lo svilupparsi di una insidiosa
e sanguinaria Œstrategia della tensione¹ che, assieme al
rischio terroristico incombente, frenò di fatto il
rinnovamento sociale e politico: "Tra il 1976 e il
1979 questo straordinario e composito movimento di protesta
fu distrutto. Il terrorismo porta con sé una gran
parte della responsabilità per l¹abbandono di traguardi
collettivi e per il trionfo del Œriflusso¹. Esso tolse qualsiasi
spazio politico alla protesta sociale, rendendo inevitabile
la sola scelta tra l¹accettazione dello status quo e le
bande armate. Una gran parte di responsabilità, su
di un piano diverso, risiede però anche nella mancanza
di mediazione politica offerta dai partiti di sinistra e
dai sindacati. Il nesso tra protesta e riforma, in questi
anni, non fu assolutamente compreso dalla sinistra"10.
Intorno alla metà
degli anni Settanta in Italia si assiste in effetti a una
crescita di peso politico della sinistra, i cui esiti però
non andarono oltre un cauteloso Œcompromesso storico¹. E
si è consumato così il grande sogno di un
mutamento sociale, politico ed esaurientemente riformistico
della società italiana (passato nel 1979 il PCI nuovamente
all¹opposizione). Né gli anni del Œcompromesso storico¹
riuscirono a impedire la crescente e progressivamente sempre
più degenerante invasione partitocratica nella società
civile e nel funzionamento dello Stato. Mentre una subentrata
crisi economica, di portata internazionale, strozzava d¹altra
parte il processo di modernizzazione11.
Tuttavia, anche se la reazione
restaurativa (politica quanto culturale) sviluppatasi dall'inizio
degli anni Ottanta sembrerà avere progressivamente
rimosse le possibilità di un dialogo con una vitalità
di base, in realtà tali semi opereranno nel tempo
una trasformazione profonda nei modi anche pubblici della
gestione culturale, sviluppando nuove attenzioni alla dimensione
partecipativa, così come "una sensibile trasformazione
d'orientamento nelle ulteriori istanze almeno della più
vigile progettualità creativa: ne è sensibile
persino un'istituzione come la Biennale veneziana nel suo
rinnovamento, anche statutario, già all'inizio degli
anni Settanta"12.
Da ciò si comprende
bene come la realtà sociale e politica dell¹Italia
degli anni settanta ha presentato caratteristiche del tutto
particolari, le quali inevitabilmente si sono ripercosse
su quelle che sono state le proposte artistico-culturali
del momento determinandone, per certi aspetti, gli orientamenti.
In una tale situazione matura
in ambito artistico una particolare attenzione, come ho
già detto, alla dimensione "partecipativa",
ma anche alla ricerca di una "energetica primaria",
trovando dunque nel "comportamento" un terreno
fertile di sviluppo, e al tempo stesso instaurando un rapporto
complesso e ambiguo con le "nuove" tecnologie.

Note
- 1. Situazione del resto
provocata dall'atteggiamento della critica che, quando
non ha ceduto alla tentazione del 'dirigismo critico',
ha eccessivamente teorizzato in astratto e poco compreso
in concreto, come ben spiega Crispolti in "Gli anni dello
smarginamento e della partecipazione", in La Pittura in
Italia. Il Novecento/3, a cura di C. Pirovano, Electa,
Milano 1994, pp. 17-22.
- 2. La Pittura in Italia. Il Novecento/3,
a cura di C. Pirovano, op. cit.,1994, p. 19.
- 3. Cfr. E. Crispolti, Gli anni dello
smarginamento e della partecipazione, in La Pittura in
Italia. Il novecento/3, a cura di C. Pirovano, op. cit.,1994,
pp. 17-157.
- 4. Tali osservazioni, come anche molte
di quelle che seguiranno, sono tratte da P. Ginsborg,
Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Società e politica
1943-1988, vol. II, Dal "miracolo economico" agli anni
'80, Einaudi, Torino, 1989, p. 404, in La Pittura in Italia.
Il Novecento/3, a cura di C. Pirovano, op. cit.,1994,
p. 19.
- 5. P. Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra
a oggi, Società e politica 1943-1988, op. cit., 1989,
p. 409.
- 6. A questo proposito, tanto per rendere
l'idea, offro alcune cifre estratte da AA.VV. L'altro
video. Incontro sul videotape, Quaderno informativo n.
44 della IX Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro,
1973, p. 5: "Lo sviluppo della televisione è stato fenomenale.
Nel 1948 circa 200.000 famiglie americane avevano un televisore
e 15 stazioni televisive facevano trasmissioni regolari.
Nel 1958 c'erano 520 stazioni che trasmettevano in 42
milioni di case. Oggi oltre 800 stazioni via aria e 2500
via cavo raggiungono i televisori di circa 60 milioni
di famiglie. Solo nel nostro paese esistono 25 milioni
di apparecchi a colori. Anzi, ci sono più televisori nelle
case americane che telefoni, vasche da bagno o frigoriferi.
Le antenne televisive spuntano perfino dai tetti dei ghetti,
dove le case non hanno neppure gli impianti igienico-sanitari".
- 7. S. Luginbuhl, P. Cardazzo, Videotapes:
arte, tecnica e storia, Mastrogiacomo, Padova, 1980, p.
6.
- 8. Cfr. M. McLuhan, Il medium è il massaggio,
Feltrinelli, Milano, 1968; M. McLuhan, Gli strumenti del
comunicare, Garzanti, Milano, 1986.
- 9. Cfr. H. Marcuse, L'uomo a una dimensione,
Einaudi, Torino, 1971.
- 10. Storia d'Italia dal dopoguerra a
oggi, vol. II, op. cit., 1989, p. 539.
- 11. "Nel 1969 la strage
di piazza Fontana a Milano avviava la 'strategia della
tensione', di gestione reazionaria, come in tutte le successive,
implicati i 'servizi segreti' già allora deviati. L'anno
seguente il tentato 'golpe' Borghese a Roma; e nel 1974
saranno la strage di piazza della Loggia a Brescia e l'attentato
al treno fra Bologna e Firenze. Nel 1970 tuttavia l'istituzione
delle Regioni (che apre la via a un decentramento che
avrà conseguenze anche culturali), l'istituto del referendum
(ambedue venticinque anni dopo la previsione costituzionale),
e il riconoscimento del divorzio (confermato nel referendum
di quattro anni dopo). L'accrescimento di consensi per
le sinistre nelle elezioni regionali del 1975 e in quelle
politiche del1976, nel quadro di un montante eurocomunismo
europeo, che naturalmente tuttavia allarma il governo
degli USA, ha tuttavia un esito che non va oltre, per
il PCI berlingueriano, il 'compromesso storico' (che durerà
fino al1979), nel timore che una gestione del potere da
parte delle sinistre attivasse, nella perdurante sovranità
nazionale limitata nel quadro 'atlantico', un processo
di colpo di stato reazionario, sul modello cileno. Cadute
d'altra parte le speranze di un interno rinnovamento democristiano
(egemone la DC dal 1948), interrotto dall'uccisione di
Moro nel 1978, nella quale le Brigate Rosse si fecero
strumento di convergenti opposti interessi politici locali
e internazionali. Responsabili le medesime (costituitesi
nel 1970) di un'impaziente attivazione della apparentemente
risolutiva lotta armata nella pratica del terrorismo di
sinistra. E il terrorismo a sua volta soffoca la maturazione
di base, al tempo stesso spingendo il PCI a prendere da
questa legalitariamente le distanze (il che risulta reciproco),
abbandonando dunque ogni possibilità di utilizzare politicamente
la spinta innovativa di tali forze. Divaricazione che
si registra nell'azione del movimento studentesco, nel
1977, a Roma e a Bologna. D'altra parte, conclusasi ormai
la favorevole congiuntura economica, in un negativo quadro
internazionale (con la forte svalutazione del dollaro
statunitense) l'economia italiana era stata particolarmente
colpita dalla crisi del 1973 (la più ampia a livello mondiale
dopo quella del 1929), conseguente alla guerra arabo-israeliana
e alla rivalutazione fortissima del prezzo internazionale
del petrolio. Con l'esito nefasto della crescita progressiva
del 'deficit' pubblico, e di un'inflazione lungo gli anni
Settanta la più alta nel mondo occidentale (anche se il
mercato dell'arte, quale bene rifugio, risulta ancora
piuttosto florido nei primissimi anni Settanta). Nonché
con il conseguente soffocamento del processo di modernizzazione
e consolidamento industriale in corso nel Paese; mentre
vi si andava sviluppando per compensazione il fenomeno
dell'economia sommersa." (in La pittura in Italia. Il
Novecento/3, op. cit., 1994, p. 147).
- 12. La pittura in Italia. Il Novecento/3,
op. cit., 1994, p. 20.
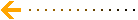

|
|