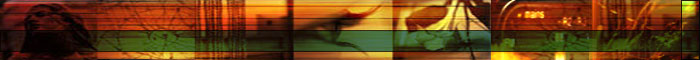| |
Introduzione
In Italia, come nel resto
d'Europa e in America, la produzione di videotapes d¹artista
è in qualche misura venuta a corrispondere con le
proposizioni "intermediali" ed "extramediali"
legate ai linguaggi concettuali e comportamentali che hanno
percorso e attraversato, pur nella molteplicità delle
sfumature, l¹intero arco degli anni Settanta(1).
Non che la produzione videoartistica si sia arrestata negli
anni Ottanta, come vorrebbe far credere una certa parte
della critica(2), ma semplicemente
essa ha subito un brusco rallentamento, dovuto in particolare
alla perdita di tensione delle proposizioni sperimentali
gravitanti nell'area di ricerca delle arti visuali(3),
che di fatto si è risolto in una progressiva e forte
ripresa del "mezzo" nel corso degli anni Novanta.
Il video come espressione
periferica, ma comunque attiva e propositiva, di tale ricerca
si è nutrito quindi della fenomenologia artistica
e dei modelli visuali allora correnti, nei quali ha trovato
una sorta di rifugio e complicità "secondo lo
schema di una immateriale concettualizzazione dell¹arte
e di una parallela espansione sociale"(4).
In una tale situazione
di vicinanza e dipendenza del video dalle arti plastiche
e visuali, possiamo dunque comprendere il calo, o addirittura
la cessazione, delle attività di produzione e diffusione
di opere video da parte di alcune gallerie quali la Galleria
d¹Arte del Cavallino a Venezia - che ha svolto un ruolo
fondamentale nella proposizione del video d¹arte e di ricerca
in Italia nella seconda metà degli anni Settanta
- agli inizi degli anni Ottanta.
Rappresentative, a questo
proposito, sono le parole di Paolo Cardazzo, direttore della
Galleria del Cavallino, riguardo al videotape: "Verso
il 1972 finalmente arrivò in Italia il portpack
[sic] e con questo nuovo strumento estremamente versatile
e facile da usare abbiamo realizzato i primi videotape strettamente
aderenti al nuovo linguaggio dell¹arte concettuale.
[...] Con l¹inizio degli anni Ottanta nuovi linguaggi venivano
a sostituire nelle gallerie quelli dell¹arte concettuale,
la quale aveva utilizzato all¹interno della sua variegata
articolazione mezzi diversi quali il cinema, la fotografia
e la televisione. Abbiamo sentito allora che era giunto
il momento di mettere fine alla nostra attività e
di ricondurre la sperimentazione nell¹ambiente più
congeniale dello studio televisivo"(5).
A parte l¹approssimazione
con cui si accostano, semplicisticamente, le realizzazioni
video al "nuovo linguaggio dell¹arte concettuale",
le parole di Cardazzo danno un¹idea abbastanza chiara della
situazione artistica all¹avvio dello scorso decennio, e
delle prospettive di allontanamento della sperimentazione
video dall¹ambito delle arti visuali.
L¹autonomia della ricerca
video e il suo distaccarsi dall¹area visuale, auspicata
dal critico Vittorio Fagone come condizione ottimale per
lo sviluppo di questo medium, ha dunque caratterizzato
buona parte della produzione videoartistica degli anni
Ottanta, ma soprattutto ha influito sulla distribuzione
e diffusione di tale produzione.
Per tutto l¹arco degli anni
Ottanta l¹arte video - nelle sue molteplici forme e sviluppi
¯ è stata per buona parte relegata in luoghi deputati
alla fruizione spesso specialistica, quali festival e rassegne
specifiche, anzi possiamo dire che si è nutrita quasi
esclusivamente di questa forma di distribuzione e diffusione(6).
Tale condizione ha comunque avuto il merito di preservare
e promuovere una continuità di ricerca e di sperimentazioni
nell¹ambito delle arti elettroniche, una sorta di incubazione
che ha evitato la probabile condanna al totale silenzio
delle opere video, e che nel corso degli anni Novanta ha
dato i suoi frutti maturi(7).
Sono attualmente tanti i
grandi complessi museali che dedicano se non una sezione
appositamente attrezzata, quantomeno un costante interesse
per le sperimentazioni nel campo delle arti elettroniche(8),
per non parlare dei piccoli musei o centri d¹arte contemporanea
che puntualmente hanno un televisore acceso e un¹oscura
stanza illuminata dal fascio di luce di un videoproiettore(9).
Dunque ai giorni nostri
è lecito constatare che non solo nei circuiti specializzati
dei festival e delle rassegne, come è accaduto in
buona parte per tutti gli anni Ottanta, è possibile
gustare (o semplicemente osservare) le video opere d¹arte
¯ nei suoi molteplici e variegati sviluppi ¯, ma che la
pratica delle arti elettroniche è un elemento costantemente
presente negli ambienti artistici ufficiali(10)
e non(11).
Possiamo assumere ciò
come dato di fatto, nonché come presupposto in cui
inscrivere il lavoro di ricerca da me svolto sul decennio
precedente la "lieve frattura" degli anni Ottanta.
Un¹ulteriore conferma del
suddetto spostamento di interesse da parte della ricerca
artistica (e di conseguenza di tutto l¹ambiente che gravita
attorno ad essa) nei primi anni Ottanta ci è fornita
dalle parole di Vittorio Fagone, uno dei critici che ha
seguito con maggiore attenzione le vicende della nascita
e sviluppo della "video arte", che così
scrive: "Il ritorno alla materialità delle immagini
dipinte che si ha alla fine degli anni Settanta e la perdita
di velocità delle ricerche immateriali e comportamentali
nell¹area visuale (si pensi al declino della performance)
coincidono con l¹abbandono del video da parte di alcuni
artisti e con una larga disaffezione da parte degli spazi
avanzati di promozione artistica. Questa situazione, che
stabilisce anche un naturale processo di selezione rispetto
a molte curiosità esterne e disinvolti opportunismi,
libera la ricerca video da una dipendenza troppo stretta
verso l¹area visuale"(12).
Parole, queste, che portano
ad una riflessione interessante: nella misura in cui Fagone
dà come condizione ottimale della ricerca video il
suo distaccarsi dall¹area visuale ne rivendica anche una
propria autonomia e dunque un¹identità separata,
una sorta di "arte a parte".
Tale autonomia, però,
se da una parte ha auspicato la liberazione del video dai
modelli linguistici e metalinguistici legati all¹arte concettuale,
minimale e alla performance, dall¹altra ha teso ad una eccessiva
separazione, specializzazione e conseguente marginalizzazione
del mezzo elettronico. Separazione, del resto, che anche
se è stata prova di un raggiunto specifico linguistico,
è stata altresì modalità operativa
e ideologica completamente opposta ai presupposti socio-culturali
da cui era nata l¹esigenza di utilizzo del video come mezzo
creativo.
Possiamo con una certa sicurezza
affermare che le origini della videoarte sono riscontrabili
nella pratica operativa - ma sarebbe più esatto parlare
di strategia - del movimento Fluxus(13),
da cui partirà la nostra analisi. Successivamente
rintracceremo quindi i rapporti che legano il video alle
pratiche artistiche presenti sul finire degli anni Sessanta,
ma anche quei movimenti di pensiero che si sono rivelati
determinanti, per vari motivi, nello sviluppo delle ricerche
video del decennio successivo. Presentando cioè il
clima artistico-culturale in cui è maturata l¹attenzione
a questo "nuovo medium", un clima che in qualche
modo ha accomunato molte delle ricerche artistiche, e più
in generale estetiche, le quali hanno teso, nella molteplicità
delle loro proposte, ad uno stesso obiettivo: la ridefinizione
del concetto di opera d¹arte, la sua smaterializzazione,
e l¹assunzione dell¹artisticità come elemento peculiare
della personalità dell¹operatore estetico.
In un tale clima, allora,
ciò che viene posto in evidenza è l¹importanza
del processo di produzione estetica e l¹analisi (e dunque
visione critica) di questo stesso processo, piuttosto che
la "forma chiusa" del prodotto finito. Ma la ridefinizione
dell¹opera d¹arte oltre ad avvenire attraverso la messa
in gioco del "processo", si attua anche attraverso
la riduzione agli elementi essenziali del fare artistico,
e di qui l¹attenzione all¹analisi delle caratteristiche
specifiche del mezzo, sia video che di altro tipo, attraverso
lo "smarginamento", sia nel senso dei mezzi che
nel senso degli ambiti disciplinari, e attraverso l¹introduzione
dell¹elemento politico ed ideologico nella pratica estetica
(riallacciandosi così all¹idea della fusione di arte
e vita auspicato dalle avanguardie storiche già dagli
inizi del secolo).
Analizzato quindi il fenomeno
"videoarte" in una dimensione globale di broblematiche
inerenti non solo l¹aspetto strettamente artistico, ma tenendo
in considerazione le motivazioni esistenziali, individuali
e collettive di continua ricerca e critica dei modi di produzione,
da quelli estetici a quelli economici, propria degli anni
Settanta, si comprende la condizione che porta al rifiuto
delle modalità operative tradizionali (pittura, scultura,
disegno) e la ricerca di un equilibrio che mescoli il desiderio
di partecipazione collettiva con l¹attivazione di processi
di sensibilizzazione verso determinati problemi di natura
politica e sociale. Come scrive Silvia Bordini: "il
suo contesto è quello degli orientamenti culturali
che non considerano più le opere come oggetti in
senso tradizionale, ma come situazioni, azioni, ricerche
di nuove e diverse modalità della comunicazione estetica"(14).
La seconda parte di questa
tesi si propone invece di effettuare una ricognizione sistematica
della situazione artistica italiana in rapporto al video,
ponendo come premessa che se è vero che in ambito
internazionale si sviluppa una ricerca videoartistica riconosciuta
ufficialmente e ormai formalizzata, è ugualmente
vero che in Italia, soprattutto nella prima metà
degli anni Settanta, si registra un clima di forte attenzione
alle applicazioni del video in arte, anche se spesso risoltosi
attraverso un uso sporadico e poco approfondito del mezzo.
Partendo quindi dalle prime manifestazioni, essenzialmente
teoriche, dell¹uso del video in arte, offerteci dalle riflessioni
di Fontana (e ancor prima dai Futuristi), passando per le
ricerche cinetiche e "programmate" (soprattutto
per le proposte metodologiche, per il rapporto intessuto
con le tecnologie moderne, e per la spazializzazione e dinamizzazione
dell¹opera attraverso l¹uso di ambienti e luci), attraversando
quindi l¹importante pratica del "cinema d¹artista",
e infine il complesso rapporto con la tecnologia rintracciato
nelle ricerche dell¹Arte Povera e "concettuale"
degli anni Settanta (con la dovuta attenzione alla "lezione"
Fluxus e alla pratica "comportamentale"), giungeremo
a quella particolare e complessa congiuntura artistico-operativa
che riconosciamo nella metodologia "extra media".
La situazione italiana del
video d¹artista si complica ulteriormente se si considera
che proprio negli anni Settanta si verifica quella fusione
della ricerca artistica con la dimensione politica e sociale
di cui ho detto prima, e che se questa ha condizionato in
generale la situazione artistica italiana, nel caso della
pratica video essa assume un carattere fortemente accentuato.
Per cui non possiamo non considerare che è esistita
una forte realtà di base, che ha fatto largo uso
del mezzo video, muovendosi in parte in una dimensione estetica
(sperimentando quindi anche le possibilità e specificità
del mezzo) e in parte in quella politica e sociale, con
ottimi risultati, ma che trova comunque una difficile e
problematica collocazione in ambito storico-artistico(15).
Tale situazione ha avuto un forte peso fino alla fine degli
anni Settanta, come è verificabile dalla mostra romana
Video ¹79: dieci anni di videotape, dove accanto
a lavori specificamente videoartistici sono presenti altri
più ambigui (e forse più interessanti) lavori
documentaristico-sociali(16).
Realtà questa che si è comunque protratta
fino ai giorni nostri, ma con una minore incisività,
dato che a partire dagli anni Ottanta si è sviluppata
una sistematica operazione di recupero-restaurazione delle
situazioni creative conflittuali, nonché un efficiente
lavoro di definizione degli ambiti operativi e ripristino
degli specialismi, in perfetta contraddizione con la pretesa
interdisciplinarietà, interattività e multimedialità
propostaci oggigiorno quali necessari aspetti del nostro
vivere quotidiano.

Note
- 1.Utilizzo i termini
"intermedia" ed "extra media" nell'accezione proposta
da Enrico Crispolti in Extra-media: esperienze attuali
di comunicazione estetica, Studio Forma, Torino, 1978,
e cioè rispettivamente "l'impiego di più 'media' nuovi
nel riscontro ad una 'coerenza' sostanzialmente di 'poetica'
e ideologica al di là dunque dei media stessi" o più semplicemente
come "trasferimento comunicativo attraverso 'media' diversi",
e "un modo attuale di utilizzazione molteplice, e del
tutto eterodosso rispetto agli orizzonti e ai canoni tradizionali,
di 'media' diversi appunto di comunicazione visiva di
connotazione estetica" ma "assunti nell'occasionalità
di uso di ciascuno di essi, secondo la necessità episodica
del voler dire, del voler fare, e dunque non privilegiandone,
non feticizzandone specificamente alcuno".
- 2. Mi riferisco in particolare
all'articolo di Barbara London in "Art Forum" (sett. 1980)
dal titolo Independent video in cui si registra la convinzione
che alla fine degli anni Settanta il video abbia concluso
la sua fase di crescita , ma soprattutto che abbia esaurito
le proprie possibilità espressive (informazione estratta
dall'incontro con Vittorio Fagone della Scuola di Specializzazione
in Storia dell'arte, alla certosa di Pontignano il 16/01/1992);
tale ipotesi presupporrebbe una totale dipendenza del
video dalle arti plastiche e visuali che gli sviluppi
nel campo della ricerca video degli anni Ottanta e soprattutto
di questi anni Novanta non hanno fatto altro che smentire.
- 3. Posizione, quest'ultima, sostenuta
dal critico Vittorio Fagone (cfr. L'immagine video, Feltrinelli,
Milano, 1990), ma anche dal critico Gillo Dorfles che
sul finire degli anni Settanta dichiara: "Non vorrei giungere
fino ad affermare che la Videoarte sia già giunta a una
fase di declino e di esaustione, ma è indubbio che si
assiste dopo un periodo di eccessiva divulgazione e di
accettazione indiscriminata di documenti quanto mai precari
e ambigui, a uno successivo di stanchezza e di diffidenza
da parte del pubblico. E' un fatto che molte delle illusioni
iniziali circa le possibilità offerte da questa nuova
forma espressiva sono state spazzate via, alla luce dei
prodotti ormai diffusissimi e degli innumerevoli incontri
ai quali abbiamo assistito" (in Le arti visuali e il ruolo
della televisione, Eri, Roma, 1978, p. 125); va comunque
sottolineato che tale posizione risente fortemente del
clima di "riflusso" dovuto alla particolare situazione
socio-politica ed economica della fine degli anni '70.
- 4.V. Fagone, L'immagine
video, Feltrinelli, Milano, 1990, p. 56.
- 5.A. M. Montaldo, P. Atzori (a cura di),
Artel. Media elettronici nell'arte visuale in Italia,
Ilisso, Nuoro, 1995, p. 113.
- 6. Nonostante qualche blando tentativo
di apertura e sperimentazione delle possibilità linguistiche
del video da parte della televisione, i risultati su questo
terreno si sono rivelati scarsi e senza una reale continuità
per la situazione italiana; un po' più interessanti si
sono rivelate le aperture della televisione belga, francese,
inglese e nordamericana, ma sempre all'interno di una
politica del "non disturbo" incompatibile con la sperimentazione
video. Per un maggiore approfondimento del rapporto video-televisione
negli anni Ottanta rimando al libro di Vittorio Fagone,
L'immagine video, op. cit., 1990, e ai cataloghi della
IV, V, VI, VII edizione della Rassegna Internazionale
del Video d'Autore, a cura di Valentina Valentini, Sellerio,
Palermo dal 1989 al 1992.
- 7.Per un approfondimento sul ruolo dei
festival rimando al saggio di Sandra Lischi, Dell'attenzione,
Riflessione in tre punti sui festival del video, in Video
d'Autore 1, a cura di V. Valentini, Gangemi, Roma, 1994.
- 8.A tale proposito basterà
ricordare la X Esposizione Internazionale Documenta di
Kassel del 1997, oppure, sempre nello stesso anno, la
Biennale Veneziana e la Biennale del Whitney di New York
e infine la Berlin Biennale di quest'anno; e tra i grandi
centri culturali possiamo ricordare il Musée National
d'Art Moderne presso il Centre Georges Pompidou di Parigi
e il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid.
- 9.Qui i riferimenti potrebbero essere
infiniti a partire dal Centro Arte Contemporanea del Palazzo
delle Papesse a Siena, nato da un paio di mesi (Nov. 1998)
e visitato qualche giorno fa, fino alla mostra La coscienza
luccicante svoltasi al Palazzo delle Esposizioni di Roma
dal 17 Settembre al 30 Ottobre 1998.
- 10.Per una veloce ricognizione italiana
ed europea della situazione attuale delle arti elettroniche
rimando a AA.VV., Generazione media, Triennale di Milano,
Milano, 1997; per uno spaccato della situazione internazionale
e per una buona ed aggiornata bibliografia rimando a La
coscienza luccicante, a cura di P. S. S. Zanetti, M. G.
Tolomeo, Gangemi, Roma, 1998.
- 11. La sperimentazione delle arti elettroniche
continua, comunque, ad avere anche un suo autonomo sviluppo,
rispetto alla produzione, alla distribuzione e ai luoghi
di fruizione dell'"arte ufficiale", nella scia di una
tradizione di produzione "alternativa" che affonda le
sue radici nella cultura "underground" degli anni Sessanta.
Mi riferisco in particolare alla polivalente e avanguardistica
attività del centro culturale indipendente Link Project
di Bologna, e all'attività, meno costante ma qualitativamente
buona, del C.P.A. di Firenze o del Leoncavallo di Milano.
- 12.M. M. Gazzano, A. Zaru (a cura di),
Il Novecento di Nam June Paik, Carte Segrete, Roma, 1992,
p. 25.
- 13.A tale proposito richiamo le parole
di Vittorio Fagone, che nel testo "Video d'Europa, origini
e tracciati", scritto per il catalogo della Rassegna "In
Video '90" di Milano, così scrive: "Quando Nam June Paik
e Wolf Vostell dichiarano che le chiavi per comprendere
ragioni e sviluppi della ricerca video vanno ricercate
nella complessa e libera poetica del movimento Fluxus,
danno una indicazione che difficilmente può essere messa
in discussione solo che si consideri l'indiscutibile e
fondamentale contributo dato da questi due autori alla
nascita, nei primi anni Sessanta, della videoarte o il
valore ridefinitorio del contagio tra diversi linguaggi
artistici e modelli della nuova comunicazione, sostenuto
e praticato, almeno nei primi anni di attività, da tutti
gli artisti del nuovo movimento".
- 14.S. Bordini, Videoarte e arte. Tracce
per una storia, Lithos, Roma, 1995, p. 19.
- 15.Il caso del gruppo Videobase di Anna
Lajolo, Alfredo Leonardi e Guido Lombardi, è solo l'esempio
più noto, al quale si potrebbe aggiungere il lavoro di
diversi collettivi di cinema militante, da quello di Milano
a quello di Bologna a quello di Torino, ma anche il lavoro
di artisti già riconosciuti quali l'Ufficio per l'Immaginazione
Preventiva (Benveduti, Falasca, Catalano), o le operazioni
di Ugo La Pietra e Fernando De Filippi.
- 16.Cfr. AA.VV., Video '79: dieci anni
di videotape, Kane, Roma, 1979.
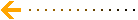

|
|