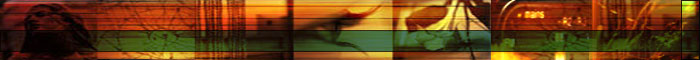| |
Le radici
storico-artistiche della "videoarte"
Il termine "videoarte"
viene convenzionalmente utilizzato per indicare tutti gli
aspetti della produzione artistica aventi a che fare con
il mezzo video. Tale produzione può, però,
essere suddivisa, per motivi di comodità e chiarezza,
in diverse categorie ognuna con delle sue caratteristiche
peculiari(17). Dunque
a seconda dell¹uso che si fa di questo medium è possibile
rintracciarne la propria radice storico-artistica e le connessioni
esistenti tra le diverse linee di sviluppo della produzione
videoartistica.
Accettando la suddivisione
proposta da Fagone(18)
avremo:
- Produzione videografica: la produzione
originale di opere appositamente concepite per il medium
video, in cui l¹immagine elettronica viene "lavorata"
e sollecitata in varie direzioni a seconda della specifica
personalità dell¹artista.
- Registrazioni: la registrazione di performance,
azioni ed eventi, spesso in tempo reale, la cui funzione
non è semplicemente documentaria, ma di partecipazione
al momento creativo e di possibilità di estensione
visiva e temporale del fenomeno indagato.
- Videosculture e videoenvironments: la
dislocazione in uno stesso spazio ambientale di diverse
strutture video, in cui nel primo caso l¹immagine elettronica
viene fatta slittare attraverso più monitor alla
ricerca di una più espansa strutturazione visiva;
mentre nell¹altro caso l¹attenzione è posta sull¹ambiente
in cui lo spettatore è invitato ad agire, anche
in modo interattivo, come dentro a un percorso da esplorare.
- Intermedia e videoinstallazioni: la combinazione
intermediale di dispositivi eterogenei, quali diapositive,
videotape, bande sonore, film, immagini plastiche e oggetti,
che creano una complessa e polimorfa struttura plastica
in grado di ridefinire i percorsi della visione e del
coinvolgimento dello spettatore.
- Multimedia e videoperformance: la coniugazione
multimediale di produzioni o riprese televisive con altre
tecniche e linguaggi quali la danza, il teatro o la performance,
in una prospettiva di specularità che agisce sul
rapporto fra la scena e il suo doppio dello schermo video.
Per ognuna di queste casistiche
è possibile rintracciare delle radici storico-artistiche,
sinteticamente divisibili nel seguente modo:
Per la produzione videografica
le origini sono rintracciabili nel lavoro di alterazione
del segnale televisivo (e quindi dell¹immagine) operata
da Nam June Paik già dal 1963 nella mostra di Wuppertal
e successivamente, nel 1970, con la creazione del videosintetizzatore
in collaborazione con l¹ingegnere Shuya Abe; ma anche nelle
prime sperimentazioni nel corso degli anni Settanta di Steina
e Woody Vasulka(19) sulla
costituzione e manipolazione delle immagini di sintesi (immagini
derivanti da elaborazioni matematiche, senza la necessità
di un referente reale). In questo caso molto è dipeso
anche dall¹accessibilità da parte degli artisti alle
strutture e apparecchiature necessarie alla realizzazione
di queste opere. Come vedremo, la situazione negli Stati
Uniti offrirà maggiori possibilità rispetto
a quella europea e diverso sarà anche l¹approccio
ai nuovi media(20).
Per la seconda casistica,
quella relativa alla registrazione, l¹attenzione va posta
sul clima di smaterializzazione dell¹arte avvenuto nella
seconda metà degli anni Sessanta. Le radici, dunque,
sono rintracciabili sia nel lavoro di prolungamento del
carattere comunicativo e percettivo delle azioni di Joseph
Beuys, ma anche nel progetto della videogalleria di Gerry
Schum, attraverso la presentazione delle prime due mostre
televisive "Land Art" e "Identification",
e cioè nell¹esigenza di documentazione ed espansione
del raggio d¹azione delle performance, delle azioni e degli
eventi di quegli artisti operanti sull¹ambiente naturale
o sociale.
La terza casistica fa riferimento
a quella linea di ricerca che si muove in direzione di un¹espansione
della spazialità interna all¹opera d¹arte visiva
(già investigata e sollecitata dal Futurismo e dal
Costruttivismo) sviluppatasi nella seconda metà degli
anni Sessanta, nel desiderio di abbandonare il campo convenzionale
e istituzionalizzato dell¹arte. Le sue radici sono rintracciabili
nella nuova concezione di opera d¹arte proposta dal Minimalismo
(nel senso del rapporto con lo spazio di percezione dell¹opera)
e successivamente sviluppata negli ambienti di Ira Schneider,
Bruce Naumann, Dan Graham e Nam June Paik.
La quarta e la quinta ipotesi
sono in parte riconducibili alla terza casistica, e per
l¹altra parte ricollegabili alla interdisciplinarietà,
alla commistione e interazione di più media, e allo
"smarginamento" operato da Fluxus (nel senso di
una espansione della pratica artistica). Punto di riferimento
inevitabile è Wolf Vostell e i suoi décollage.
Come vedremo tali categorie,
da noi fissate per motivi di comodità storiografica,
sono comunque relazionabili e spesso coagenti tra loro,
così come le loro radici ed origini, necessariamente
interconnesse dato che appartengono al medesimo clima artistico
e socio-culturale.
Nel rintracciare le linee
di ricerca in cui affondano le radici di una estetica video
ci soffermeremo, come prima tappa, su Fluxus e su alcuni
dei suoi protagonisti, quali Nam June Paik, Wolf Vostell
e Joseph Beuys, che, con modalità differenti, hanno
per primi esplorato le diverse possibilità di utilizzo
del video in "arte".

Note
- 17.In realtà già dai
primi anni Settanta si pone la questione di una precoce
e "necessaria" sistematizzazione della produzione video
entro categorie rigorose, quanto funzionali ad una definizione
conoscitiva e affermativa di tale pratica: cfr. la rubricazione
delle esperienze video proposta da R. Barilli in Video-recording
a Bologna, in "Marcatre", n. 58-60, Roma, 1970; oppure
la Classificazione dei metodi di impiego del videotape
in arte elaborata da L. Giaccari nel 1972 (pubblicata
in "BolaffiArte", n. 49, apr.- mag. 1975); fino alla classificazione
messa a punto dal Centro Video Arte di Ferrara, nel catalogo
della mostra Videoarte a Palazzo dei Diamanti (1973-1979),
a cura di Janus, Torino, 1980. Sull'argomento cfr. anche
Videotapes: arte, tecnica e storia, di S. Luginbuhl e
P. Cardazzo, Mastrogiacomo, Padova, 1980; e Memoria del
video. 1. La distanza della storia, a cura di M. Meneguzzo
e L. Giaccari, Nuova Prearo, Milano, 1987.
- 18. Cfr. V. Fagone, L'immagine video,
op. cit., 1990, pp. 36-39.
- 19.Cfr. M. M. Gazzano (a cura di), Steina
e Woody Vasulka. Video, media e nuove immagini nell'arte
contemporanea, Farenheit 451, Roma, 1995.
- 20.Cfr. AA.VV., Video '79: dieci anni
di videotape, Kane, Roma, 1979, p. 12.
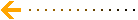

|
|