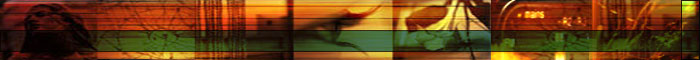| |
Fluxus: l¹espansione della
pratica artistica
La seguente operazione di
lettura e utilizzo storico del fenomeno Fluxus porta con
sé i limiti inevitabili della interpretazione a posteriori:
recupero, ricostruzione, distacco emotivo.
Ritengo necessario fissare
ciò come un presupposto fondamentale per un atteggiamento,
quale quello del Fluxus, che rifuggiva la storia per realizzarsi
e verificarsi di volta in volta nell¹hic et nunc del vivere
quotidiano. Voglio dire che la mia operazione non ha la
pretesa di trasmettere o rendere il senso profondo di tale
atteggiamento (che comunque non è mai una Œlettura¹,
ma semmai un Œmetodo¹), e quindi questa resta un¹operazione
alla seconda che non può spiegare, ma semplicemente
dare una vaga idea del pensiero poliforme e vivo dell¹organismo
Fluxus.
Per cominciare utilizzerei
le parole di Nam June Paik che, a proposito dell¹espansione
della pratica artistica Fluxus, afferma: "è
un modo di vita, non un concetto artistico"21.
Il gruppo Fluxus aggrega
agli inizi degli anni Sessanta una vasta area di artisti
interessati alle linee di ricerca non oggettuale e alle
pratiche performative, spesso coinvolti con il movimento
degli happening22 e con
le proposizioni neodadaiste, che in quel periodo stavano
attraversando lo scenario artistico contemporaneo.
La parola "Fluxus"
viene pronunciata per la prima volta nella primavera del
1961 da George Maciunas nella sua galleria di New York,
la A. G. Gallery, che in occasione di una serie di performances
chiede un contributo di 3 dollari in sostegno della rivista
"Fluxus". Sempre nello stesso anno Maciunas, con
l¹aiuto di La Monte Young e Jackson Mac Low, prepara il
libro "An Antology" che verrà pubblicato
solo nel 196323.
Il primo Fluxus Festival
viene proposto nel settembre del 1962 a Wiesbaden con il
titolo Fluxus Internazionale Festspiele Neuester Musik e
presenta una serie di azioni esemplari realizzate da George
Maciunas, Dick Higgins, Emmett Williams, Ay-O, Robert Filliou,
Nam June Paik, Daniel Spoerri, Wolf Vostell, Giuseppe Chiari,
Gianni Emilio Simonetti e altri.
Per via della "bizzarria"
e della carica distruttiva di alcune performances, quali
la frantumazione di strumenti musicali, gli esercizi di
rasatura o il tuffo in una vasca da bagno piena d¹acqua,
i media diedero a questo evento molto spazio, che ne facilitò
la diffusione secondo la "strategia del contagio sociale",
ma non gli impedì di essere osteggiato ed emarginato24.
Nel complesso, comunque,
"l¹evento fece capire la differenza tra ciò
che più tardi Maciunas avrebbe definito "flux-evento
neo-haiku monomorfico" e lo "happening neo-barocco
mixed-media", vale a dire che sebbene le performances
di Fluxus fossero intermediali ¯ nel senso che mettevano
in collegamento varie discipline come la musica e le arti
visive ¯ ogni "composizione" si concentrava su
un singolo evento isolato da qualunque altra azione, ed
era presentato come un iconoclastico scrutare nella stessa
natura della "realtà""25.
Quindi nelle operazioni fluxus l¹accento cadeva sulla semplicità
strutturale, collocabile nella tradizione dell¹"evento
naturale", degli scherzi e delle gags di origine Dada,
e nell¹esempio di Marcel Duchamp. Le partiture su cui si
basavano le performances erano spesso brevi, anche se la
durata dell¹esecuzione era indefinita, e la semplicità
di tali partiture poteva consentire a chiunque di eseguire
opere fluxus senza bisogno di esperienza, competenza o preparazione26.
Prima di sondare le radici
storiche di Fluxus diamo un¹occhiata veloce alle differenze
esistenti tra l¹evento Fluxus e lo Happening, seppure all¹interno
di modalità di operatività artistica essenzialmente
comuni.
In entrambi i casi la scelta
dell¹evento, dell¹azione effimera, vuole proprio spostare
il concetto di operazione artistica dal suo essere produzione
di oggetti a quello di produzione di esperienza, che si
sviluppa simultaneamente tra i due poli costituiti dall¹artista
e dal pubblico. Tale scelta di coinvolgimento e partecipazione
del pubblico, di uscita dal suo ruolo passivo impostogli
da anni di contemplazione dell¹opera d¹arte, è presente
anche nell¹Happening, ma tra questo e l¹evento Fluxus esiste
una qualche differenza.
Come scrive Achille Bonito
Oliva: "L¹happening è un accumulo quantitativo
di oggetti e gesti che trova attraverso la loro dissociazione,
il loro essere messi in relazione inedita, la sua qualità
estetica. Solo da questa dissociazione nasce l¹aspetto artistico",
mentre "L¹evento fluxus parte dalla coscienza situazionistica
che la realtà è già spettacolo. Ogni
oggetto o gesto quotidiano ha in questo la sua qualità,
la sua non necessità di essere relazionato in maniera
inedita. Nell¹evento fluxus ogni oggetto o gesto è
esibito in sé, nella sua grammatica elementare",
e dunque "L¹happening tende sempre a un¹espressività
della messa in opera del gesto, tende cioè a sottolineare
il passaggio dell¹oggetto o dell¹azione dal suo uso estetico
al suo uso artistico. L¹evento fluxus, invece, tende solo
a sottolineare il passaggio dell¹oggetto e del gesto da
un grado di esistenza all¹altro"27.
Anche se nato in America
e approdato rapidamente in Europa e in particolar modo in
Germania, dove Maciunas entra in contatto con Wolf Vostell,
Nam June Paik, Ben Patterson e Joseph Beuys, Fluxus si caratterizza
per un atteggiamento di rottura delle divisioni e delle
distanze geografiche e culturali, sia nel sistema dell¹arte
che in quello sociale più in generale28.
Come scrive sempre Bonito
Oliva: "L¹arte agisce all¹interno di un sistema, dove
le separazioni geografiche e le diverse matrici culturali
spesso determinano una frantumazione della comunità
artistica, anzi una comunità concentrata che si contrappone
al resto della società quanto a scelte ideologiche
e a comportamento individuale. Prima di Fluxus esistevano
una serie di comunità artistiche divise per poetiche
[Š] Fluxus è il primo movimento che supera tali steccati
[Š] Rinunciando a considerare la poetica come comune denominatore,
Fluxus ha chiamato a raccolta artisti di diversa estrazione
culturale e provenienti da poetiche diverse"29.
Dunque il principio fondante era la creazione di un¹unica
comunità in cui tutti gli artisti potessero entrare
ed uscire liberamente, comunità la cui base comune
non fosse di natura estetica ma etica, e cioè dare
all¹arte un contenuto rinnovato attraverso il quale ritrovare
un rapporto, non eccezionale, con la vita.
Così per l¹artista
Fluxus l¹arte diviene un luogo totale, disponibile ad accogliere
qualsiasi possibilità creativa, sia come proposta
diretta di se stesso, della propria fisicità, che
di quella degli oggetti impiegati nel rapporto comunicativo
con gli spettatori. Impossibile non richiamare l¹attenzione
sulle radici di Fluxus rintracciabili nel Futurismo, nel
Dadaismo, ma in particolare modo in Duchamp.
Le proposte di "sintesi
radiofoniche" di Marinetti o le ipotesi di espansione
dei limiti (spaziali e temporali) del quadro30
non erano certo estranee ad alcuni membri del gruppo Fluxus,
quali Cage e Kaprow31.
Anzi il critico Maurizio Calvesi ritiene determinanti certe
intuizioni del Futurismo per la nascita dei nuovi processi
di creazione artistica legati all¹Happening e a Fluxus32.
Anche Nam June Paik riconosce
l¹importanza del Futurismo (in particolare modo per la storia
del video) e osserva: "Il Futurismo l¹ho conosciuto
nel 1958, non prima. E¹ interessante perché fu il
primo movimento artistico che esprimeva la componente "tempo",
e il video è Immagine più Tempo. Così
il Futurismo è stato importante anche teoricamente.
Il tempo influenza l'arte; così nella storia del
video occorre ricordare il contributo del Futurismo";
e sempre Nam June Paik, riguardo le proprie influenze artistiche,
scrive: "La più grande influenza su di me l¹ha
avuta John Cage. Lui mi disse che si considerava una combinazione
di Dada e di filosofia Zen della "vacuità".
Per lui il Dadaismo fu importante. Così per me lo
furono il Dadaismo e Duchamp"33.
L¹esempio di Duchamp, difatti,
conta non solo per i procedimenti aleatori da questi utilizzati
in alcune opere, quali Stoppages-Etalon (1913/14), ma soprattutto
per l¹elezione ad opera d¹arte dell¹oggetto quotidiano praticata
nel ready-made. Rispetto all¹impostazione duchampiana, incentrata
su modalità radicalmente arbitrarie di ri-contestualizzazione
dell¹oggetto comune nel circuito artistico, Fluxus attua
però uno spostamento significativo, sostituendo all¹intenzionalità
forte ed ironica delle operazioni di Duchamp, un atteggiamento
fondamentalmente estatico (anche se mai trascendentale)
nella quale possono tornare in primo piano anche talune
qualità intrinseche dell¹oggetto34.
La caratterizzazione zen
delle operazioni degli artisti Fluxus - da cui deriva anche
la nozione di tempo come un susseguirsi incessante di attimi
che qualificano non solo gli accadimenti straordinari ma
anche quelli più anonimi e quotidiani, e che determina
nell¹evento Fluxus una temporalità in grado di raccordare
l¹elemento arte a quello della vita ¯ e l¹applicazione del
principio di indeterminazione alla sfera immateriale dell¹evento35,
distanziano in qualche modo queste esperienze anche dalla
poetica "merz" di recupero dell¹oggetto elaborata
da Schwitters in area Dada, e la cui influenza appare evidente
in molti ambiti di ricerca artistica degli anni ¹60 vicini
a Fluxus (ad esempio New Dada in America o Nouveau Réalisme
in Europa). Voglio dire che anche se si riconosce l¹importanza
del recupero dell¹oggetto quotidiano di ascendenza dalla
poetica "merz", questo non è mai sublimato,
e l¹azione stessa, per il suo statuto di forma d¹espressione
effimera che si esaurisce nell¹atto dell¹esecuzione, non
è finalizzata alla produzione di un¹opera-oggetto,
ma sottolinea la centralità dell¹esperienza percettiva
in sé stessa, oltre l¹oggetto e la sua sedimentazione36.
Il gruppo Fluxus, quindi,
si è mosso alla ricerca di una strategia globale
che spingeva alla riscrittura, anche a livello antropologico,
dell¹esperienza artistica, collocandosi in quella che Bonito
Oliva definisce "la linea sintetica dell¹arte",
che nasce dal dadaismo e si connota come opera di irruzione
nel presente quotidiano, al di fuori di qualsiasi struttura
di organizzazione del lavoro artistico.
L¹"arte sintetica"
oppone alla conoscenza specialistica e settoriale una coscienza,
appunto, globale e profonda che rompendo le specificità
del linguaggio artistico approda nel luogo totale della
creatività37. Quindi
arte come spazio non compartimentato in cui le varie discipline
(dalla musica al teatro, dalla pittura alla danza, dal cinema
alla poesia) smarriscono ogni rigidità categoriale,
assumendo una configurazione "non-ostruttiva",
incline anzi ad una reciproca interpenetrazione.
Così La Monte Young
scrive: "La parola Fluxus significa flusso, movimento
inarrestabile verso un impegno più etico che estetico.
Fluxus, sviluppatosi in America e in Europa, sotto lo stimolo
dell¹opera di Cage, non ha puntato sull¹idea di avanguardia,
come rinnovamento linguistico, ma su un uso diverso dei
canali ufficiali dell¹arte e sullo scardinamento di ogni
linguaggio specifico. Ha puntato cioè sulla interdisciplinarietà
e sull¹adozione di mezzi e materiali provenienti da differenti
campi. Il linguaggio non è il fine, ma il mezzo per
una nozione rinnovata di arte, come "arte totale""38.
Fluxus, così, partendo
da una piattaforma teorica in cui i rituali dell¹arte e
le sue istituzione vengono sistematicamente sottoposti a
un¹azione di derisione e demistificazione, giunge a una
ridefinizione del concetto stesso di opera d¹arte39.
La struttura dell¹opera d¹arte cambia totalmente in direzione
di un nuovo, ricercato rapporto con il pubblico nel segno
del coinvolgimento e della partecipazione atte a liberare,
in chi la vive, un "flusso di energie contro i vecchi
schemi di comportamento, in un clima ludico, libertario"40.
L¹attenzione è posta
non più sull¹oggetto e sul mercato che esso autorizza,
ma sull¹avvenimento che prende la forma dello spettacolo-manifestazione
multimediale, dal carattere ludico e indeterminato come
potrebbe esserlo la stessa vita quotidiana. Una tale espansione
dell¹opera d¹arte, accompagnata dalla critica al ruolo dell¹artista,
del quale se ne nega il professionismo, porta al delinearsi
di una sorta di consapevolezza dell¹arbitrarietà
del "fare artistico" (di ricordo, ancora una volta,
duchampiano) in cui qualunque cosa può sostituirsi
all¹arte e chiunque all¹artista41.
Musica, arti plastiche,
cinema, danza, poesia e nuovi media diventano quindi strettamente
legati dall¹apertura ad ogni possibile esperienza nel rapporto
arte-vita e dall¹uso di tutte le tecniche e di tutti i materiali
(con particolare attenzione ai materiali del mondo contemporaneo).
Come scrive Joseph Beuys, uno dei grandi protagonisti della
stagione Fluxus e della sperimentazione video: "Tutto
poteva venire accettato, dall¹atto di strappare un pezzo
di carta alla formulazione di idee tendenti a trasformare
la società"42.
Nell¹organizzare i materiali
della realtà per ridefinire l¹arte, fra gli sconfinamenti
sperimentati con frenetica attività vitalistica,
Fluxus ingloba anche il cinema e la dimensione televisiva.
Viene realizzata, nel 1966,
una Antologia dei Fluxfilm a cui partecipano numerosi artisti
tra cui Eric Andersen, Chicko Shiomi, John Cavannaugh, George
Brecht, John Cale, Albert Fine, Robert Watts, Pieter Vanderbeck,
Wolf Vostell, George Landow, Yoko Ono e George Maciunas,
che a New York era entrato in contatto con Jonas Mekas e
il cinema indipendente43,
e che spingeva gli artisti Fluxus a utilizzare il mezzo
cinematografico sia come memoria che come sperimentazione
della dimensione visiva.
Il programma di film Fluxus
si caratterizzava per una straordinaria violenza delle immagini,
banali ed eccessive, che si ponevano l¹obbiettivo di stravolgere
le abitudini della comunicazione quotidiana, di ostacolare,
o deviare il "flusso immobilizzante della visione convenzionale"44.
La pratica cinematografica
diviene quindi familiare e congeniale agli artisti Fluxus
che la utilizzano come un supporto mobile su cui segnare
spontaneamente il flusso di idee, gag, azioni, improvvisazioni
e provocazioni. Così nell¹Antologia dei Fluxfilm
del 1966: "Chieko Chiomi gira Fluxfilm N.4 e Disappearing
Music for Face, ripresa di un viso che passa da un¹espressione
a un¹altra a passo accelerato. Yoko Ono realizza sedici
film, ironiche analisi del comportamento quotidiano o attacchi
alla cultura ufficiale come in Fluxfilm 14: One, Emmett
Williams e Robert Filliou realizzano Double Happening, sequenza
di gag provocatorie, e una serie di cortissimi film, One
Minute Movies, raggruppati anche sotto il titolo di Omage
à Méliès, prochainement sur votre écran;
Lemaitre lavora su film della durata di pochi secondi, Sei
film infinitesimali; Filliou ironizza sul cinema porno con
Do It Yourself-Erotic Movie; Paul Sharits riprende pagine
di cataloghi (come i surrealisti), in Sears Catalogue 1-3,
o filma la parola "cinema" con diverse inquadrature
in Word Movie; Joe Jones filma a doppia velocità
il fumo di sigaretta in Smoke"45.
Per Lorenzo Taiuti il cinema
di Fluxus si connota come uno strumento di "liberazione"
della realtà, completamente slegato dalle ipoteche
estetiche della pittura46.
Per Fagone, invece, i Fluxfilm operano sulla esaltazione
delle caratteristiche percettive dell¹immagine cinematografica,
e sulla strutturazione in criteri di ordinamento non soggetti
al codice narrativo: "I procedimenti che il cinema
sperimentale impiega in questa prospettiva sono di due tipi:
raccoglie immagini quotidiane sviluppate per sequenze non
obbligate a uno svolgimento narrativo e le distorce nel
tempo accelerando o rallentando, sino a sfidare le soglie
della percezione del movimento, ogni dinamismo. Le immagini
distorte e violentemente accelerate, raccolte dentro una
temporalità artificiale, inducono una visione nuova
che colpisce chi guarda. [Š]Dentro il cinema sperimentale
sono ancora gli artisti a sollecitare analisi e scansioni
della possibilità di costituire e strutturare immagini.
La nascita delle prime esperienze video tiene conto della
realtà del cinema sperimentale alla metà degli
anni sessanta e, nella diversità dei linguaggi propria
ai due mezzi, cinema e video si confrontano acutamente"47.
Determinanti, quindi, risulteranno
le esperienze del già maturo cinema sperimentale
europeo e americano per la definizione di una estetica video48,
e oltre alle già citate proposte del cinema Fluxus
vanno menzionate anche le parallele, e per certi aspetti
opposte, ricerche di altri grandi artisti, quali Andy Warhol
o Michael Snow, che esploreranno molte delle possibilità
(ma anche dei limiti) offerte dall¹immagine cinematografica49.
E¹ in questo contesto di
esplorazione dell¹universo mediatico da parte degli artisti
che trovano posto le prime realizzazioni utilizzanti il
medium video, sia nella forma della produzione-destrutturazione
dell¹immagine televisiva che in quella della riproduzione
e decontestualizzazione di immagini in movimento, ma anche
come oggetto-contenitore nella costituzione di ambienti
e spettacoli-manifestazioni multimediali o su cui agire
simbolicamente nel segno della denuncia, attraverso la decostruzione
del linguaggio televisivo esterno, del suo messaggio.
Nam June Paik, Wolf Vostell
e più tardi Joseph Beuys si muoveranno per primi
in questa direzione integrando il video alle loro performances
e realizzando le prime videoinstallazioni50.

Note
- 21. Citato nel testo
di Anne-Marie Duguet, Dispositivi, in Video imago, "Il
Nuovo Spettatore", n. 15, a cura di A. Amaducci e P. Gobetti,
Franco Angeli, Milano, 1993, p. 187.
- 22. Il termine designa l'opera che non
punta più sull'oggetto, ma sull'evento. L'artista parte
da un progetto di azione, nella quale coinvolge attivamente
lo spettatore, che viene sottratto all'abituale ruolo
di passivo fruitore dell'opera, per essere immesso in
un rapporto attivo con l'evento artistico. L'Happening
può essere considerato un gesto d'irruzione nello spazio
quotidiano, organizzato in tempi e luoghi non necessariamente
deputati alla produzione artistica. L'azione avviene,
solitamente, in uno spazio ed in tempi definiti in cui
il risultato è costituito dall'esperienza collettiva e
i segni che ne restano (le fotografie, i video, i films)
sono i documenti-residui di un tempo e di una durata vissuti
nel contingente. Per un maggiore approfondimento rimando
a Michael Kirby, Happenings, New York, 1968; Adrian Henri,
Environments and Happenings, Thames e Hudson, Londra,
1974.
- 23.Oltre a questo testo, come riferimento
bibliografico fondamentale rimando a Harry Mahé, Fluxus:
the most radical and experimental art movement of the
sixties, Ed. A, Amsterdam, 1979; Achille Bonito Oliva
(a cura di), Ubi fluxus, ibi motus, Mazzotta, Milano,
1990.
- 24. Vittorio Fagone ritiene che Fluxus
negli Stati Uniti sia stata considerata una intellettualistica
manifestazione tardodadaista, incline a pericolose utopie
anarco-comuniste e per questo motivo emarginato e osteggiato
dagli ambienti artistici ufficiali. Anche Nam June Paik
a proposito del rapporto di Fluxus con l'Europa scrive:
"Rimasi molto colpito dall'importanza che veniva data
al nostro lavoro. Qui negli Stati Uniti invece non fu
mai accettato in questi termini" (in Il novecento di Nam
June Paik, op. cit., 1992, p. 29).
- 25. Stewart Home, Assalto alla cultura,
AAA Edizioni, Venezia, 1996, p. 70.
- 26.Ad esempio, in 'In Memoriam To Adriano
Olivetti' di Maciunas : "Ogni performer sceglie un numero
da un rotolo usato di carta da calcolatrice. Il performer
si esibisce ogni volta che il suo numero compare in una
riga. Ogni riga indica un battito di metronomo. Possibili
azioni da fare ad ogni apparizione del numero: 1) togliersi
o mettersi la bombetta. 2) fare suoni con bocca, labbra,
lingua. 3) aprire e chiudere ombrelli etc.". Quasi tutte
le documentazioni delle performances sono state raccolte
da Maciunas in Fluxus. An Anthology, a cura di La Monte
Young, New York, 1963.
- 27.A. B. Oliva, ubi Fluxus ibi motus,
in Catalogo della XLIV Biennale di Venezia, a cura di
Marie-George Gervasoni, La Biennale di Venezia, Venezia,
1990, p. 94.
- 28.Nonostante che Fluxus si sia mosso
come un "fronte mobile di persone" va riconosciuta, comunque,
una diversa caratterizzazione nella pratica artistica
e politica del gruppo americano rispetto a quello europeo;
ciò è dovuto alle diverse radici e ai diversi, ma paralleli,
sviluppi della ricerca artistica e culturale degli degli
svolgimenti europei rispetto a quelli propri dello scenario
newyorkese in cui matura Fluxus. Sarebbe interessante
approfondire questo particolare aspetto dell'organismo
Fluxus, questa sua capacità di arricchirsi attraverso
la differenza anziché isolarsi in una "poetica", senza
comunque rinunciare ai tratti essenziali della propria
multi-identità, ma per ciò rimando ai pochi accenni in
Fluxus o del principio di indeterminazione, catalogo della
mostra, Ed. Studio Leonardi / Caterina Gualco, Unimedia,
Genova, 1988; mentre per quanto concerne il diverso atteggiamento
politico e sociale di Fluxus in America rispetto al suo
gemello europeo (che affonda le sue radici in gruppi del
genere di CoBrA e dell'Internazionale Situazionista) rimando
a Assalto alla cultura, op. cit., 1996, cap. 1-10.
- 29.Catalogo della XLIV Biennale di Venezia,
op. cit., 1990, p. 92.
- 30. "Nel film futurista entreranno come
mezzi di espressione gli elementi più svariati: dal brano
di vita reale alla chiazza di colore, dalla linea alle
parole in libertà, dalla musica cromatica e plastica alla
musica di oggetti. Esso sarà insomma pittura, architettura,
scultura, parole in libertà, musica di colori, linee e
forme, accozzo di oggetti e realtà caotizzata. Offriremo
nuove ispirazioni alle ricerche dei pittori i quali tendono
a sforzare i limiti del quadro" (Manifesto della cinematografia
futurista, firmato da F. T. Marinetti, B. Corra, E. Settimelli,
A. Ginna, G. Balla, R. Chiti, 11 sett. 1916, in Ricostruzione
futurista dell'universo, a cura di E. Crispolti, Torino,
1980, p. 199).
- 31. In una recente dichiarazione di George
Segal si può leggere: "Nel 1958-1959, Kaprow ed io restavamo
alzati fino alle due o alle tre del mattino a discutere
di estetica. Kaprow era brillante nel trasmettere idee
d'avanguardia del Dadaismo, del Surrealismo e del Futurismo,
specialmente del futurismo. Ad esempio, le composizioni
radiofoniche di Marinetti erano per noi di grande interesse.
La combinazione di parole e suoni e rumori prodotti da
oggetti qualsiasi, fu chiaramente una ricca fonte per
John Cage. [Š]La loro estetica collegata alla vita nelle
città moderne, io credo che sia ancora oggi degna di essere
esplorata" (AA.VV., George Segal, Lorenzelli Arte, Milano,
1994, cit. in La coscienza luccicante, op. cit., 1998,
p. 56).
- 32.Cfr. Documenti di un percorso di Maurizio
Calvesi, in La coscienza luccicante, op. cit., 1998, p.
55.
- 33.Il Novecento di
Nam June Paik, op. cit., 1992, p. 29.
- 34. E' nell'attenzione alla dimensione
comunicativa dell'oggetto (o dell'azione) che si realizza
il recupero delle qualità intrinseche dell'oggetto stesso,
comunque ripulito dell'aura di unicità ed assunto nel
flusso del quotidiano.
- 35. Il principio di indeterminazione
di Heisenberg viene formulato nel 1927 in questa forma:
"una particella può avere posizione o può avere velocità,
ma non può in nessun senso preciso avere l'una e l'altra",
e cioè all'aumentare della determinazione di una variabile
corrisponde il progressivo allontanarsi dell'altra. Tale
principio, posto come 'categoria' e chiave di lettura
della Seconda Avanguardia nella mostra Luoghi della Seconda
Avanguardia 1958-1970, a cura di Chiara Guidi, Massa Carrara,
1987 (Cfr. il catalogo), è alla base delle "ricerche sulla
configurazione imprevedibile dell'assemblaggio suono-immagine"
e del concetto di indeterminato di John Cage, che a sua
volta influiranno su buona parte delle ricerche del gruppo
Fluxus e sulla nascita di un'estetica video: "Paik ha
più di una volta dichiarato che senza Cage, la ricerca
video non avrebbe potuto realizzarsi. [Š]Cage ha sicuramente
dimostrato la possibilità di un diverso atteggiamento
nei confronti di elementi disomogenei che possono tuttavia
essere orientati verso una particolare congruenza e organizzazione
linguistica. [Š]Certa è anche l'influenza delle sonorità
concrete, e alla lettera 'attive' di Cage, che poi la
ricerca video ha utilizzato in un crossing altamente ridefinitorio
tra immagini e azioni performative. Il valore della sezione
sonora dell'audiovisuale elettronico è il risultato esaltato
da questa precisa consapevolezza" (Il Novecento di Nam
June Paik, op. cit., p. 23).
- 36.Cfr. G. Zanchetti, Appunti di storia
Fluxus, in AA.VV., Milano-poesia, Nuova Intrapresa, Milano,
1989, p. 153.
- 37.Cfr. Ubi fluxus, ibi motus, a cura
di Achille Bonito Oliva, Mazzotta, Milano, 1990.
- 38.Anthology of, 1963, in http://www.sapienza.it/magam/glossario/fluxus.html.
- 39.Fluxus, recita un manifesto, "nega
la distinzione fra arte e non-arte, nega l'indispensabilità,
l'esclusività, l'individualità e l'ambizione dell'artista,
nega ogni aspirazione di significato, varietà, ispirazione,
perizia tecnica, complessità, profondità, grandezza, ogni
valore istituzionale e di mercato" (citato in Per complicare
l'intreccio, di Sandro Ricaldone, http://www.geocities.com/Paris/Rue/4853/fluxus.html).
- 40.Silvia Bordini, Videoarte e arte.
Tracce per una storia, Lithos, Roma, 1995, p. 32.
- 41. "L'artista Fluxus, scrive Maciunas
(Fluxus Manifesto 1965 e 1966), deve essere "non professionale,
non parassita, non elitario, [Š] deve dimostrare che ogni
cosa può sostituire l'arte e che ognuno la può fare""
(in Silvia Bordini, Videoarte e arte. Tracce per una storia,
op. cit., 1995, p. 32).
- 42.Citato in Dispositivi di Anne-Marie
Duguet, in Video imago, a cura di A. Amaducci e P. Gobetti,
op. cit., 1993, p. 188.
- 43.Cfr. A. Aprà (a cura di), New American
Cinema. Il cinema indipendente americano degli anni Sessanta,
Ubulibri, Milano, 1986.
- 44.Cfr. L'immagine video, op. cit., 1990,
p. 28.
- 45. Lorenzo Taiuti, Arte e media, Costa
& Nolan, Milano, 1997, p. 93.
- 46.Lorenzo Taiuti, Arte e media, op.
cit., 1997, p. 92.
- 47. L'immagine video, op. cit., 1990,
p. 29.
- 48. Cfr. Ventiquattro fotogrammi al secondo
+ uno, di Bruno di Marino, in Videoarte e arte. Tracce
per una storia, op. cit., 1995, pp. 95-107; o il capitolo
Dal cinema sperimentale all'arte video, in L'immagine
video, op. cit., 1990, pp. 50-53.
- 49.Tratterò con maggiore attenzione il
"cinema degli artisti", e le differenze di quest'ultimo
con il cinema sperimentale, nel capitolo seguente dato
l'alto numero di artisti italiani cimentatisi in questa
pratica e l'importanza che avrà per la nascita della videoarte
in Italia. Per il momento mi limito a sottolineare l'importanza
del cinema di Warhol per l'arte video, e in particolare
per la produzione videografica, infatti come scrive Gianfranco
Mantegna nel testo Il gergo e la funzione del video: "Se
il movimento di Arte e Tecnologia sta alla base del video,
Warhol, non solo con le sue idee, ma anche col suo specifico
tipo di immagine pittorica, effimera, artificiale e disastrosa,
si deve considerare il padre putativo del video" (in Cinema
off e videoarte a New York, a cura di Ester De Miro, Bonini,
Genova, 1981, p. 174), ma anche l'opposta concezione di
artista e di prodotto artistico rispetto all'ambiente
Fluxus.
- 50.Va comunque ricordato che parallelamente
alle ricerche di questi pionieri del video, anche alcuni
artisti pop americani, quali Robert Rauschenberg, Tom
Wesselman e Jasper Johns, riconoscono il valore di massa
del televisore e lo inseriscono come oggetto nelle proprie
opere o "pitture combinate".
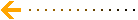

|
|