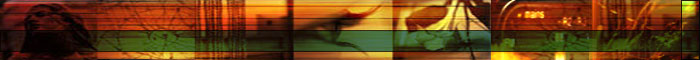| |
Le prime realizzazioni
Convenzionalmente la data
d¹inizio della "videoarte" si fa coincidere con
l'esposizione, dal titolo Exposition of music-electronic
television, tenutasi alla Galerie Parnass di Wuppertal
nel marzo del 196351.
E¹ presente alla mostra Nam June Paik, artista coreano,
con la videoinstallazione (se già si può utilizzare
questo termine che avrà solo negli anni Ottanta una
corretta definizione52)
13 Distorted TV-sets e cioè 13 diversi monitor
sintonizzati su trasmissioni televisive e collegati a dispositivi
elettronici in grado di disturbarne la ricezione dell¹immagine
video variandone l¹intensità luminosa, creando interferenze,
distorcendola53. Ma leggiamo
cosa scrive Fagone a questo proposito: "L¹obiettivo
destrutturante dell¹operazione è chiaro. L¹immagine
elettronica è esaltata nella sua qualità luminosa
primaria ma, alla lettera, contrastata nella sua
apparenza televisiva di immagine assolutamente veridica
e quindi unica"54.
Mentre d¹altro canto Marco Maria Gazzano, riconoscendo la
priorità delle proposizioni di Paik, lo inserisce
nella scia del Modernismo55
scrivendo: "E¹ stata questa l¹intuizione di Paik, l¹atto
di nascita delle arti elettroniche, nel 1962-65: la capacità
di riportare le nuove tecniche audiovisive nell¹ambito della
tradizione più avanzata del Moderno, quella che ha
esplorato ¯ radicalizzandone le potenzialità ¯ i
linguaggi espressivi, per cogliere ciò che stava
dietro l¹apparenza, l¹"oltre", il di là
da se stessi"56.
Sempre nello stesso anno
Wolf Vostell presenta alla Smolin Gallery di New York i
suoi Tv Dé-coll/age, in cui accumula sistematicamente
gli effetti di disturbi e interferenze: "Egli "scolla"
e registra una qualsiasi trasmissione televisiva e si propone
di ripresentarla con tre minuti preliminari di disturbi"57.
Mentre Paik programma il disturbo e la distorsione agendo
direttamente sul dispositivo, sulla macchina, Vostell lavora
sul riferimento alla normale programmazione televisiva,
fondando la sua prassi di intervento sull¹alterazione-denuncia,
sottraendo così al flusso continuo della televisione
le immagini e la sua forza pervasiva: "L¹attitudine
destrutturante è forse ancora più netta nell¹opera
di Wolf Vostell, anch¹egli tra gli artisti dell¹esposizione
alla Galerie Parnass [Š], che nei TV de-coll/age
interviene violentemente nella decomposizione-ricomposizione
di immagini estrapolate da programmi televisivi di larga
diffusione"58.
La pratica del dé-coll/age59,
utilizzata da Vostell per le sue operazioni di sottrazione,
aveva già dalla fine degli anni Cinquanta inglobato
l¹uso del televisore: "Nell¹allestimento del ciclo
delle Schwarzes Zimmer (Berlino, 1958-59) i televisori
trasmettevano i loro normali programmi ma incastonati tra
oggetti e fotografie dei campi di sterminio di Treblinka
e di Auschwitz, con l¹evocazione drammatica del fantasma
irrisolto del passato nazista accostata all¹altrettanto
drammatica indifferenza delle emissioni commerciali della
televisione. Nel TV De-coll/age (1958) Vostell propone
una grande tela incolore, lacerata in vari punti da cui
si intravedono altrettanti occhieggiamenti di schermi, con
le loro emissioni assurdamente decontestualizzate, ridotte
a residui e metafore inquietanti"60.
Fagone, però, fa
giustamente notare che anche se nelle esposizioni di Wuppertal
sono presenti delle opere in cui appare l'apparecchio televisivo,
o in cui appaiono delle immagini modificate elettronicamente,
è solamente nell¹ottobre del 1965 che sarà
usato uno strumento per la registrazione su nastro magnetico
(il Portapack della Sony, uscito sul mercato statunitense
a prezzo accessibile quello stesso anno) con intenzionalità
estetica . E' solo con la registrazione, significativamente
chiamata Café Gogo, 152 Bleeker Street, October
4 and 11, 1965, presentata da Nam June Paik al Cafè
a Go Go e alla Galleria Bonino di New York, che un'artista
sperimenta le potenzialità di questo nuovo medium
fin dalla sua fase di costituzione. Siamo di fronte alla
creazione del primo videotape d¹arte.
Come scrive Maria Grazia
Tolomei: "Paik sarà il primo di una serie di
artisti che faranno del reportage amatoriale un evento artistico
effettuando una ripresa in esterni e mostrandola la sera
stessa in una galleria privata". Paik con la realizzazione
di questa semplice registrazione della realtà e con
la ricontestualizzazione della stessa in un luogo deputato
alla fruizione dell¹arte si ricollega alla lezione duchampiana
dell¹ "objet trouvé" , ma espandendone
la portata, e cioè trasferendo il concetto di ready-made
dall¹oggetto all¹evento61.
Diversamente, per una parte
della critica62 la videoarte
comincia nel 1969 con la mostra televisiva Land Art
di Gerry Schum63 e con
la mostra TV as a Creative Medium, alla Howard Wise
Gallery di New York, la prima rassegna di arte video alla
quale partecipano molti dei nomi che già avevano
sperimentato il mezzo televisivo in anni precedenti, quali
Frank Gillette e Ira Schneider, Nam June Paik e Charlotte
Moorman, Eric Siegel, Aldo Tambellini e altri64.
Va comunque ricordato che
il problema delle date di inizio di un fenomeno come la
videoarte è sempre un po¹ ostico da risolvere per
i motivi già indicati nel corso di questo elaborato,
e cioè le diverse radici e possibilità di
utilizzo del mezzo video.
In realtà, quindi,
queste date verranno assunte solo per ragioni di comodità
storiografica, sapendo benissimo che ogni fenomeno artistico
trae le proprie origini da una molteplicità di eventi
ed avvenimenti concatenantisi, e tenendo ben presente che
non ci troviamo di fronte ad un movimento artistico (con
tanto di manifesto programmatico) ma ad un fenomeno che
racchiude in sé una buona parte degli aspetti socio-culturali
e politico-economici dei paesi in questione.
Ma continuiamo. In tutt¹altra
prospettiva si muove invece il lavoro di Joseph Beuys nel
suo rapporto con il video. Dal 1964 in poi moltissime delle
sue azioni vengono filmate, riversate in video, registrate
direttamente su nastro magnetico o realizzate appositamente
per (contro) il medium televisivo.
Particolare è la
posizione di Beuys sia nel contesto di Fluxus (di cui è
attivo organizzatore per l¹ambiente europeo), sia per l¹uso
che ne fa del mezzo televisivo65.
All¹interno della pratica sperimentale e provocatoria di
Fluxus, Beuys sviluppa la sua dimensione di espansione del
discorso artistico, politico e ideologico con una certa
attenzione all¹aspetto di allargamento comunicativo consentito
dai media e in particolare dagli strumenti audiovisivi.
I primi esempi di registrazioni audiovisive applicate da
Beuys alle proprie azioni, sono rintracciabili nella performance
fluxus Kukei, akopee-Nein!, del 1964, e sempre nello
stesso anno, sfruttando l¹uso della diretta, nell¹azione
Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überwertet
66.
L¹esplorazione del video
nella funzione di registrazione delle azioni e azioni per
la televisione, si pone come obbiettivo non tanto l¹analisi
delle caratteristiche specifiche del mezzo o la costituzione
di particolari ambienti estetico-percettivi, quanto la possibilità
di lasciare aperto un canale dell¹informazione e della comunicazione
avviata proprio con la performance. In una tale modalità
operativa Beuys non pone più alcuna differenza tra
il mezzo video e quello cinematografico, essendo entrambi
disponibili all¹uso da lui richiesto. Il video (così
come anche il film) diventa allora uno strumento intermediario,
capace di attivare uno scambio di informazioni, ma anche,
per la sua natura immateriale e fluida, capace di realizzare
"quella "plastica sociale" che assume il
pensiero come scultura immateriale, infiltrata e circolante
tra materie e situazioni catalizzati dalla presenza dell¹artista"67.
Continuando con Silvia Bordini:
"Tuttavia è chiaro che Beuys è lontano
dalle problematiche specifiche sia del film d¹artista sia
della videoarte; Beuys adopera il film e il video per i
propri scopi, semplicemente come ulteriore strumento per
comunicare; per prolungare il senso del discorso. E¹ interessato
a continuare non a conservare le opere registrandole e memorizzandole,
(come invece fa Schum); non intende calarsi totalmente all¹interno
del mezzo per sviscerare e reinventare le sue molteplici
potenzialità linguistiche (come Paik); e anche la
denuncia e la contestazione dell¹oggetto e del potere televisivo
(così centrale in Vostell e, con un uso ancora diverso
in una ampia frangia di video espressamente politici come
quelli del gruppo Guerrilla Television) rimangono
marginali nelle sue intenzioni"68.
Bisogna comunque riconoscere
che l¹azione proposta da Beuys a Copenhagen nell¹ottobre
del 1966, con il titolo Fliz TV, e riproposta in
studio, nel 1970, per la video-mostra Identifications
a cura di Gerry Schum, si inserisce perfettamente in quel
clima di forte opposizione e denuncia dell¹apparato televisivo
e dei suoi portati. In questo caso il confronto critico
con la televisione diventa confronto diretto ed esplicito
con l¹oggetto televisione in una sorta di rito ironico ed
assurdo dalle molteplici ipotesi interpretative69.

Note
- 51.Vorrei sottolineare
che questo evento già pone un primo problema di esattezza
storico-filologica: L'esposizione di Wuppertal è stata
una personale di Nam June Paik o una mostra collettiva
in cui era presente anche Wolf Vostell con i suoi de-collage?
Le posizioni della critica a questo riguardo sono molto
disparate. Da una parte si sostiene che i due artisti
abbiano esposto insieme alla Galleria Parnasse di Wuppertal
nel marzo 1963, e tra questi V. Fagone (Il Novecento di
Nam June Paik, L'immagine video), A. Amaducci (L'immagine
scatenata, in Video imago), F. Popper (L'art à l'âge électronique),
L. Taiuti (Arte e Media), D. Bloch (Video-installazioni,
in Metamorfosi della visione). Dall'altra parte invece
si sostiene che si sia trattata di una personale di Nam
June Paik e che Vostell esponesse quasi contemporaneamente
alla Smolin Gallery di New York, posizione questa di M.
M. Gazzano (Il Novecento di Nam June Paik), G. Celant
(Offmedia), S. Bordini (Videoarte e arte. Tracce per una
storia), Anne-Marie Duguet (Vedere con tutto il corpo,
in Metamorfosi della visione), M. G. Tolomeo (La coscienza
luccicante) e di S. Luginbuhl e P. Cardazzo (Videotapes:
arte, tecnica, storia).
- 52.Un'esauriente classificazione dei
termini e delle etichette via via comparse a definire
questo nuovo mezzo di comunicazione estetica è stata operata
da Vittorio Fagone in L'immagine video, op. cit., 1990.
- 53. "Paik propone uno sfregio visivo
che permette, per la prima volta, una 'risposta' del pubblico
al linguaggio unidirezionale della televisione" (in Lorenzo
Taiuti, Arte e media, op. cit., 1997, p. 96).
- 54.Vittorio Fagone, Video d'Europa. Origini
e tracciati, in In Video '90, a cura di Sandra Lischi
e Felice Pesoli, Ergonarte, Milano, 1990, p. 104.
- 55. "Questo segna l'apparecchiatura video
come un contributore unico a quel che si può vedere non
come postmodernismo, ma come il progetto non ancora completato
del modernismo. Perché se una delle impetuose aspirazioni
del modernismo nelle arti fu quello di creare forme artistiche
capaci di rispondere ai mutamenti dinamici dell'industrializzazione,
sia come celebrazione sia come critica, il video allora
interiorizza profondamente questa vocazione e a un ben
maggiore livello della fotografia e del film, arti che
hanno anch'esse una componente modernistica nella loro
struttura fondamentale". Tratto dal breve ma interessante
saggio di Maureen Turim, La logica culturale del video,
in Illuminating Video, Aperture Bauc, 1990, tradotto in
italiano in Video imago, op. cit., 1993, pp. 171-176,
che affronta in modo chiaro il rapporto dell'estetica
video con il modernismo e il postmodernismo; problematica
questa affrontata anche in Electra Myths: Video, Modernism,
Postmodernism di K. Dieckmann, in "Art Journal", vol.
45, n. 3, 1985, pp. 195-203.
- 56. M. M. Gazzano, A. Zaru (a cura di),
Il Novecento di Nam June Paik, Carte Segrete, Roma, 1992,
p. 16.
- 57. L'implosione nel campo dei colori
di Florence de Méredieu in A. Amaducci, P. Gobetti (a
cura di), Video imago, "Il nuovo Spettatore", n.15, Franco
Angeli, Milano 1993, p. 90.
- 58. M. M. Gazzano, A. Zaru, Il Novecento
di Nam June Paik, op. cit., 1992, p. 24.
- 59. Il termine dé-coll/age, anche se
sottolinea il riferimento alla pratica dadaista del collage,
non è aggiungere, ma bensì sottrarre, e come spiega Vostell:
"rinvia a un principio della negazione estetica, o a un'estetica
della negazione: a forme di distruzione, volontaria o
involontaria, per opera dell'uomo o del destino. [Š]Il
processo del dé-coll/age, che deforma l'oggetto, è anche
un evento, un avvenimento, una azione che ha la stessa
importanza del risultato estetico" (catalogo della mostra
Hors Limites, a cura di J. De Loisy, Centre G. Pompidou,
Parigi, 1994, cit. in Videoarte e arte. Tracce per una
storia, op. cit., 1995, p. 32.
- 60. Videoarte e arte. Tracce per una
storia, op. cit., 1995, p. 34.
- 61. E in questo caso John Cage fa da
tramite avendo per primo trasferito il concetto di ready
made nel suono ready-made, e cioè dalla sfera materiale
dell'oggetto a quella immateriale della musica. Cfr. Ubi
fluxus, ibi motus, a cura di A. B. Oliva, op. cit., 1990.
- 62. Mi riferisco, ad
esempio, a Maurizio Calvesi che scrive: "La video-art,
nata nel 1969, è figlia dei "film di artista" che avevano
cominciato a circolare dalla metà degli anni Sessanta"
(in La coscienza luccicante, op. cit., 1998, p. 55); oppure
ad Alessandro Silj, curatore della mostra Video '79: video-
the first decade, a Roma nel 1979, che nel catalogo scrive:
"La prima mostra di arte video fu organizzata a New York,
nel 1969, da Howard Wise".
- 63. Il "film televisivo" di Gerry Schum
sarà trasmesso dalla Sender Freies Berlin nel 1969 con
il titolo Land Art; per un maggiore approfondimento rimando
al paragrafo Land Art di questo stesso capitolo.
- 64.Questa mostra sarà la prima di una
serie di eventi fondamentali per il riconoscimento della
videoarte all'interno del panorama artistico ufficiale,
quali Vision and Television, all'inizio del 1970, al Rose
Art Museum a Waltham, Massachusetts, curata da Russell
Connor che più tardi dirigerà la sezione dedicata ai nuovi
media del New York State Council on the Arts; nel 1971
il Finch College Museum di New York invita dieci artisti
a creare dei videotape nel museo stesso dove verranno
presentati il mese successivo; nello stesso anno anche
il Whitney Museum con lo Special Videotape Show si interesserà
alle produzioni video; e ancora nel 1971 nascerà all'Everson
Museum di Syracuse, New York, la prima sezione video.
- 65.Organizzatore del Festum Fluxorum
Fluxus a Dusseldorf nel febbraio del 1963, per cui realizza
una importante azione, Sibirische Symphonie, I Satz, in
cui appaiono alcuni dei simboli e degli elementi che diverranno
ricorrenti nel suo lavoro, Beuys si caratterizza per una
sua personale pratica performativa: "Attratto dalla comune
propensione interdisciplinare ed all'uso non convenzionale
dei significati, Beuys dal canto proprio ha dispiegato
nelle performance una cadenza ritualistica, un senso metaforico
dei materiali, simboli ed iconologie complesse che lo
spingono lungo la direttrice di una palingenesi culturale
non precisamente omogenea all'attitudine ludica del nucleo
Fluxus originario" (in Per complicare l'intreccio, di
Sandro Ricaldone, op. cit.).
- 66. Cfr. F. Hergott (a cura di), Joseph
Beuys, Films et vidéos, Centre G. Pomidou, Parigi, 1994.
- 67.Videoarte e arte. Tracce per una storia,
op. cit., 1995, p. 46.
- 68.Videoarte e arte. Tracce per una storia,
op. cit., 1995, p. 46.
- 69.Germano Celant interpreta la "lotta"
di Beuys contro la televisione come il riscatto della
degradazione personale: "Nella sua trasmissione impersonale,
Beuys richiama il personale e l'emotivo, il violento ed
il maldestro dell'individuo contrario all'ammorbidimento
ovattato della televisione" (in Offmedia, di G. Celant,
Dedalo, Bari, 1977, p. 51); per le altre ipotesi cfr.
Videoarte e arte. Tracce per una storia, op. cit., 1995,
p. 48.
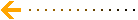

|
|