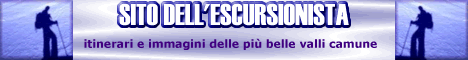
 |  |
|
DESCRIZIONE
La
migliore descrizione che ho trovato è nel volume "Escursioni nel Parco dell'Adamello"
di S. Frattini - C. Contino - Edizioni CIERRE -1995-
"La Valle dell’Avio, con ben 5 km
di larghezza alla testata, è la più ampia valle del Parco. "La valle ha almeno otto spiccati gradini (scriveva nel 1908 il famoso geologo Wilhelm Salomon) che, ad eccezione del primo, presso Malga Caldea, sono autentici bacini rocciosi: il secondo è il Laghetto, il terzo il Lago d’Avio, il quarto l’estinto lago di Malga di mezzo, il quinto l’estinto lago di Malga Lavedole, il sesto il quasi Lago del Venerocolo nella diramazione orientale della valle, il settimo a 2200 m di altezza nel ramo principale della valle, l’ottavo il cosidetto Pantano d’Avio". "Era ancora bellissima e selvaggia la Valle dell'Avio in quei primi anni del Novecento, e sulla "Provincia" dei 18 luglio 1904 si scriveva che “... Quando si giunge ai terrazzi entro i quali stanno i laghi d’Avio e di Mezzo si rimane incantati da tanta magnificenza di natura. Essi nell’ora propizia del giorno, dispiegano all’occhio estatico di chi li ammira tutto un arazzo di colori fulgidi, una gara di tinte superbe, turbate solo dai salti a fior d’acqua delle numerose trote che li popolano. Quattro spumeggianti, perenni cascate fanno risonare e vibrare tutto questo bacino di un rombo spettacoloso”. Tanto che nel suo Camunni, del 1886, il Favallini ci informa che la Valle l’Avio “..vien denominata appunto Valle dei Diavoli pei grandiosi fenomeni, che vi campeggiano”. Con i suoi imponenti anfiteatri di cime e con i suoi ghiacciai del Venerocolo e dell’Avio, è ancora grandiosa l’antica Valle di Diavoli. Ma le sue cascate più suggestive non ci sono più, e ben cinque degli otto pianori (con o senza laghetti naturali) sono stati trasformati in serbatoi idroelettrici. Tra le vallate che convergono verso il cuore dell’Adamello è oggi la più frequentata: offre infatti ampie possibilità escursionistiche e alpinistiche, favorite anche dalla presenza del Rifugio Garibaldi, che sorge nei pressi del Lago Venerocolo, al cospetto della parete nord dell’Adamello. Lo raggiungiamo risalendo tre successivi gradini e costeggiando, per tutta la loro lunghezza, tre laghi artificiali (Laghetto dell’Avio, Lago d’Avio, Lago Benedetto). Poi, per il ritorno, è consigliabile allungare di circa un’ora il percorso e, con una facile panoramica traversata alla base dell’Adamello, sfiorare la fronte del Ghiacciaio del Venerocolo per raggiungere il Lago Pantano. Qui inizia la discesa verso Malga Lavedole, dove si torna sulla via seguita all’andata e dove si trova una interessante zona umida torbosa. Interessanti sono inoltre i vasti ma radi popolamenti di pino cembro sparsi per l’alta valle, in cui spiccano alcuni vetusti esemplari. |
NOTE STORICHE
Il nome Val d'Avio deriva da Valle
dei Diavoli. ...del
Favallini nella sua pubblicazione
"Il Vallone
dell'Avio elevasi imponente e selvaggio a 1923 m coi laghetti,
sempre torbidicci pel fosfato di calce che che tengon disciolto; a 2130 m col piano Lavedole,
donde gettansi due simmetriche cascatelle; a 2560 m col lago interrato dei Fopponi, donde la
testata a semicerchio è sormontata dalle punte vertiginose dell'Avio, Venerocolo, Baitone,
Premassone, Miller, Adamello (3652 m) che presentasi quale elevatissimo dirupo a due facce,
dalle quali traboccano i sempiterni ghiacciai.
.....del
Capitano Adami, come pubblicato nel bollettino CAI del 1875:(1)
".....la salita per la Val d'Avio, lunga e faticosa, in compenso era piu "amena, dilettevole e variata". E così aveva proseguito: "Il modo più opportuno si è quello di partire da Edolo con vettura verso le ore 2 antimeridiane, e, giunti al ponte dell'Avio, prendere la strada di quella valle che, superando successivi terrazzi, porta alla Malga Levedole in circa 4 ore, senza calcolare le fermate. Lungo la via si può, osservare, prima di giungere alla Malga Caldea, il passaggio dallo schisto alla tonalite, l'imponenza dei rocciosi versanti e delle enormi frane, i gradini dei terrazzi rotondati dall'azione dell'antico ghiacciaio, le cascate che precipitano da queste, e il lago d'Avio sempre torbido e squal lido; ma soprattutto meritano attenzione le belle cascate sotto Malga Levedole che vanno a confondere le loro acque nel piano interrato sottostante, fondo certamente d'antico lago. Giunti a Levedole è quivi assolutamente maestosa la vista delle creste che cingono la testata di val d'avio a guisa di anfiteatro, colle principali sue vette emergenti, quali sono il Corno dell'Avio, il Baitone, Premassone, il Plem, il Miller, l'Adamello, nonchè i Corni del Confine che scendono a picco verso questa valle, e per le cui fessure si vedono le nevi che orlano la vedretta di Mandron. Gli ultimi pini si trovano a circa 1000 m a monte della Malga. L'Adamello si presenta in questa valle come un elevatissimo dirupo tagliato quasi a picco, le cui due facce quasi ad angolo retto formano due pareti assolutamente inaccessibili, alla cui cima vedesi un'orlatura di candida neve. Si vede la sua cima fin dalla strada postale presso il ponte; ma gli abitanti raramente conoscono il suo nome, mentre in val Salarno, dalla quale non lo si pub vedere, è desso a tutti noto. Al piede nord della morena destra si trova uno stretto ma lungo bacino lacustre, pressoché tutto interrato; al quale si ascende da Levedole per comodo sentiero, del quale sopra nessuna carta si vede traccia. I su questo bacino che converrebbe passare la notte per guadagnar tempo per la salita del domani. Potendo salirvi i muli vi si può condurre quanto occorre per accamparsi comodamente, e questa sarebbe una località opportuna per erigere una capanna. È alto 2560 m" (1)
Martinelli - Adamello - il tempo dei pionieri - 1992 - |
|
| UTILIZZO IDROELETTRICO
Fin dal 1905 vennero inoltrate domande di concessione
per l'utilizzo dell'acqua della Val D'Avio e per la trasformazione in serbatoio del lago d'Avio,
ma il progetto esecutivo fu presentato solo nel 1920, dopo che la concessione divenne proprietà della
Società Generale Elettrica dell'Adamello.(SGEA) La SGEA in quel periodo era già una affermatissima società elettrocommerciale con il bacino dei propri clienti soprattutto nell'area di Milano, oltre che specializzata nel fornire energia pregiata, nei mesi invernali, a parecchie società distributrici del nord d'Italia. Aveva allora l'esigenza di trasmettere a Milano il maggior quantitativo di energia possibile, per cui il nuovo impianto di Temù fu concepito tecnicamente all'avanguardia, con i singoli gruppi che elevavano la tensione direttamente a ben 120.000 Volts per poterla trasmettere a grandi distanze. L'impianto venne costruito utilizzando come bacino di carico l'esistente laghetto naturale dell' d'Avio che venne sopraelevato con una modesta diga, una galleria in pressione lo collegava al monte Calvo, da dove, mediante due condotte forzate, l'acqua perveniva alla centrale di Temù. In centrale vennero installati cinque gruppi per una potenza complessiva di quasi 50 MW, che, per quel tempo era una potenza molto elevata. Successivamente anche il lago Avio, o lago Grande, come veniva chiamato allora, venne trasformato in serbatoio costruendo sul suo incile una grande diga, e scavando una galleria di presa al di sotto del livello normale del lago di ben 17 metri. A seguito della eccezionale bassa idraulicità degli anni 1922 - 23 nel lago d'Avio vennero installate anche delle pompe di svaso, venne costruito un fabbricato sommergibile nei pressi dell'opera di presa, e nei mesi invernali (febbraio-marzo) venivano calate mediante un piano inclinato delle pompe mobili, con le quali si sollevava l'acqua del lago naturale da quote inferiori, fino all'imbocco della galleria di presa. In questo modo potevano utilizzare qualche milione di metri cubi in più di acqua, proprio nei mesi di magra. Nel decennio successivo, sempre per incrementare la capacità produttiva di energia invernale, venne ideato e realizzato il progetto "Ferdinando Benedetto" vale a dire svuotare, idraulicamente e quindi economicamente, la piana alluvionale della Malga di Mezzo, scaricando la sabbia nel lago d'Avio, al di sotto della presa, e costruirvi una diga di sbarramento, in modo da ottenere un ulteriore serbatoio di accumulo stagionale: il lago Benedetto. Nell'immediato dopoguerra anche la parte alta della Val d'Avio venne utilizzata a scopi idroelettrici: fu costruita la centrale di Pantano d'Avio, sulla riva del lago Benedetto, alimentata dai laghi di Pantano e di Venerocolo, dove furono costruite le rispettive dighe e realizzati i serbatoi stagionali. Succesivamente nel lago Benedetto vennero convogliate anche le acque del torrente Narcanello, realizzando un'opera di presa a quota 2000 m s.l.m. circa in alta Val Sozzine, che attraverso una galleria di circa otto km raggiunge il lago Benedetto, dopo aver raccolto anche le acque della valle Seria, dei Buoi, del Salimmo e delle valli incavate. Negli anni sessanta venne ammodernata la centrale, riducendo i gruppi da cinque a tre e la potenza a 33 MW ; negli anni settanta venne automatizzata e reso possibile il suo funzionamento in telecomando da Cedegolo. Nel 1984 cessò il servizio in quanto entrò in servizio il nuovo impianto di generazione e pompaggio di Edolo. L'impianto di Edolo fu costruito dall'Enel negli anni 1977 - 1984, con un investimento di circa 1000 miliardi; continua ad utilizzare le acque che affluiscono naturalmente in Val d'Avio, quelle derivate dal Narcanello attraverso una galleria di circa 8 Km che sbocca nel lago Benedetto, oltre a quelle pompate dalla vasca di valle. Ha come bacino di monte direttamente il lago d'Avio (le acque del laghetto vengono "pompate"in Avio).
Per ulteriori informazioni sulla centrale di Edolo: visitatela |
|
Dal volumetto "VALLE DELL'AVIO" - passeggiate e ascensioni nel Parco Naturale dell'Adamello di Walter Belotti ediz. Nordpress 1995
|
APPUNTI GEOLOGICI
La Val d’Avio, per la dimensione del suo bacino complessivo e in particolare per la sua lunghezza, è la più importante delle valli del versante settentrionale del gruppo montuoso dell’Adamello. Sotto il profilo geologico essa presenta una serie di fenomeni di alto rilievo, sia sotto il profilo morfologico che in rapporto ai caratteri strutturali e in particolare ai tipi di rocce che vi affiorano. Sin dal secolo scorso la Val dAvio è stata oggetto di esplorazioni e pubblicazioni geologiche, soprattutto da parte di studiosi di lingua tedesca. E’ certamente il caso di ricordarne uno in particolare W. Salomon che le dedicò numerosi saggi, in seguito ripresi e approfonditi nella sua monumentale opera sulla geologia del gruppo dell’Adamello. Risalendo la Val d’Avio lungo la strada che da Temù porta al breve falsopiano della Malga Caldea, lungo entrambi i versanti affiorano i micascisti e talora gli gneiss del basamento cristallino delle Alpi meridionali, rocce denominate dai geologi “Scisti di Edolo”. E’ su questo basamento che si erige infatti tutto l’edificio delle Alpi a sud della grande dislocazione della “Linea del Tonale”, relativamente coincidente con il corso dell’Alta Valle Camonica. Queste rocce, in origine erano costituite da depositi di sedimenti marini, almeno in prevalenza, successivamente coinvolti in complessi quanto drammatici sommovimenti della crosta terrestre e si collocano tra le rocce più antiche del territorio bresciano. La Valle dei Buoi, sulla destra idrografica della Val d’Avio, e quella di Mezzodì, sul versante opposto, segnano l’inizio degli affioramenti rocciosi appartenenti alla serie dei corpi magmatici di origine intrusiva (e quindi non sedimentaria) che formano il massiccio delI’Adamello. Nella media e nell’alta Val d’Avio sono presenti sia quarzodioriti biotitiche che tonaliti vere e proprie. Esse sono inquadrabili in un periodo della storia geologica caratterizzato da fenomeni distensivi che interessarono la crosta terrestre in questa regione delle Alpi. A causa della distensione tra le rocce della crosta terrestre i corpi magmatici, dalle temperature originarie molto elevate, si inserirono nella struttura superiore, raffreddandosi e solidificandosi. L’età delle rocce magmatiche affioranti nella media e alta Val d’Avio è compresa tra 33 e 32 milioni di anni fa. Nel corso del sollevamento e quindi della formazione della catena alpina, le rocce magmatiche del massiccio dell’Adamello - inizialmente coperte da migliaia di metri di rocce in gran parte sedimentarie - furono portate allo scoperto. Proprio in alta Val d’Avio, e più precisamente nella zona compresa tra Cima Lavedole, il Forcellino del Giuello e l’omonima cima a nord del Forcellino, sono rimasti alcuni lembi della originaria copertura costituita da rocce sedimentarie: vi affiorano infatti le arenarie (antiche sabbie continentali) della Formazione del Verrucano, caratterizzate dal vivace color rosso, mentre la cresta del Corno del Giuello è costituita da bancate verticali di calcari grigio-biancastri. Il sollevamento del massiccio dell’Adamello non fu certamente un evento privo di fasi drammatiche, come viene testimoniato dalla presenza di frequenti fratture; quella di maggior rilevanza - anche perchè attraversa buona parte dell’alta Val d’Avio, da ovest a est - è stata denominata “Faglia delle Gole Larghe”. La dislocazione della frattura, che inizia poco a oriente del rifugio Aviolo, è responsabile dell’origine del Passo delle Gole Larghe e ha causato il ripido vallone che scende in VaI d’Avio all’altezza dei ruderi della Malga di Mezzo. Un’altra dislocazione - probabilmente una continuazione di quella della Gole Larghe - si sviluppa fino alla vetta del Monte dei Frati intagliandone il versante occidentale: n’è derivato il marcato, ripidissimo canalino che inizia nei pressi della Bocchetta Alta. Il contributo dei ghiacciai al modellamento del paesaggio della Val d’Avio costituisce uno dei fattori più importanti tra tutti quelli che hanno concorso a definire i caratteri morfologici della valle. I modesti residui di quella che fu la vasta e potente copertura glaciale sono attualmente rappresentati dalle vedrette dell’Avio e del Venerocolo. E’ tuttavia possibile ricostruire il “passaggio” dell’era glaciale basandoci soprattutto sulle testimonianze che sono rimaste: rocce levigate o talora anche fortemente striate consentono di valutare quale fosse lo spessore delle masse di ghiaccio in movimento, capaci di incidere con forza le solide superfici rocciose. Uno degli elementi di maggior rilevanza morfologica, in gran parte riconducibile al modellamento glaciale, è costituito dalla serie di “soglie” che intersecano la Val d’Avio: tra le principali sono da indicare la zona della Malga Caldea, il Lago d’Avio e il Lago Benedetto, la vasta zona planiziale di Malga Lavedole, il Pantano d’Avio oltre naturalmente la zona che ospita il bacino del Lago Venerocolo. In corrispondenza di queste soglie non è difficile immaginarci una successione di più o meno ampie “seraccate”. Le morene glaciali - ovvero i depositi di materiali eterogenei trasportati dai flussi glaciali - rappresentano un altro importante “documento”: tra le più significative sono da ricordare quella che affianca il Lago Venerocolo, di fronte al Rifugio Garibaldi e la morena che scende nel bacino del Pantano, completatasi nel corso del secondo ventennio di questo secolo. I laghi alpini sono, com’è noto, da ricondursi quasi totalmente all’era glaciale. Molti di essi, in Val d’Avio, sono stati trasformati in bacini idroelettrici: ma nella Valle dei Frati che sale ripida verso Cima Calotta e il Monte dei Frati, sulla destra idrografica della Valle, è possibile ammirare due stupendi laghetti, rimasti allo stato naturale. Il maggiore di essi, a quota 2605 metri, ha una lunghezza di oltre 150 metri, largo 100 metri circa, con una profondità che sfiora i 6 metri: il pendio che sale ai iaghetto dei Frati è, come s’è detto, piuttosto ripido ma il blu intenso del colore delle acque del lago ripaga la fatica.
|
CENNI STORICI E GEOGRAFICI
La Val d’Avio è sicuramente una delle più affascinanti vallate alpine laterali al fiume Oglio. Situata sulla sponda orografica sinistra dell’Oglio, a sud dell’abitato di Temù, si sviluppa in direzione nord-ovest/sud-est, ad una altitudine variabile tra i 1.120 metri del ponte in località Segheria ai 3.539 metri della vetta del Monte Adamello. Una strada asfaltata la percorre nei primi 5 chilometri fino alla località Fondovalle dove è collocata la stazione di partenza della funivia dell’ENEL che sale ai Laghi d’Avio. Una strada sterrata, dal bivio in località Bedolina, raggiunge la Malga Caldea; qui la strada prosegue in parte ancora asfaltata e in terra battuta fino ai Laghi d’Avio ma è chiusa al transito veicolare. Lungo la spianata dei Laghi d’Avio, la sponda orografica sinistra è percorsa da una strada sterrata che prosegue fino allo sbarramento della diga del Lago Benedetto. Il torrente Avio percorre per tutta la sua lunghezza la valle, alimentato dall’acqua rilasciata dalle dighe sovrastanti e da quella che affluisce dalle laterali Valle di Salimmo, Valle dei Buoi e Valle di Mezzodì. L’itinerario CAI N. 11 segnala il tracciato per percorrere l’intera vallata fino al Rifugio Garibaldi. La valle è racchiusa tra due dorsali: quella sulla sinistra oro-grafica, che la separa dalla Val Paghera di Vezza d’Oglio, che si estende dal Monte di Mezzodì, al Corno di Mezzodì, al Monte Avio, al Passo delle Gole Larghe, al Passo degli Alpini, alla Cima Gabriele Rosa, al Passo delle Gole Strette, al Corno del Giuello, alle Cime Lavedole nord e sud, al Passo del Canalone Ghiacciato, alla Cima Lastè, alla Cima Wanda per terminare al Corno Baitone; quella sulla destra orografica, che la separa dalla Val Seria, spazia dal Corno Marcio, alla Bocchetta e Monte Casola, al Monte Castablo, alla Punta dei Buoi, alla Bocchetta dei Buoi, alla Cima Salimmo, alla Bocchetta di Calotta, alla Cima Calotta, al Monte dei Frati, al Passo e Cima del Venerocolo. Sulla testata la valle è chiusa dalla dorsale che la divide dal Pian di Neve, con la Cima Venerocolo, il Passo e la Cima Garibaldi, il Monte Falcone, il Monte Adamello, la Cima del Laghetto, la Punta Gianni, la Punta Prina, il Passo Prudenzini, la Punta Alessandro, la Cima Plem e il Passo di Premassone. Ben 5 laghi artificiali sono disseminati nell’ultimo tratto della valle: per primo si incontra il minuscolo Laghetto d’Avio, quindi il Lago d’Avio, e il Lago Benedetto. A due diverse altezze sono invece incastonati il Lago Venerocolo e il Lago Pantano. Tutti questi invasi d’acqua, realizzati a partire dagli anni ‘20, convogliano le loro acque (circa 50 milioni di mc.) nella galleria che, scavata nelle viscere della montagna, raggiunge il Monte Colmo sopra l’abitato di Edolo e con l’immissione delle acque del Lago d’Aviolo alimentano la grande centrale idroelettrica di Edolo. Altri due pittoreschi laghetti sono collocati nella Valle dei Frati sul versante orografico destro e un minuscolo laghetto, formatosi da pochi anni, brilla ai piedi della parete nord della Cima Plem. Per la sua ricchezza d’acqua la valle è stata sfruttata fin da tempi remoti per l’alpeggio di bovini ed ovini; ne sono testimonianza le varie malghe che ancora si possono ammirare lungo il suo percorso. Anche se territorialmente gravante sull’abitato di Temù, la parte alta della valle, a partire dal laghetto d’Avio, è compresa all’interno del confine amministrativo del Comune di Edolo. Pertanto anche le malghe sono sempre state di proprietà del Comune di Mù (anticamente comune a sè ed ora frazione del più grande Comune di Edolo). Può darsi che il nome di Temù tragga proprio le sue origini da queste malghe: ‘le malghe de Mù”; da “demù” in “Temù”. Con legge regionale n. 79 del 19 Settembre 1983, l’intera Val d’Avio è stata inserita nel perimetro del Parco Naturale dell’ Adamello. Anche se non si sono ancora potuti vedere appieno i frutti della istituzione del parco, si deve constatare che la Val d’Avio si è arricchita di tutta la grossa fauna alpina: cervi, caprioli, camosci e stambecchi. I camosci sono sparsi un po’ dovunque sulle vette; cervi e caprioli prediligono i boschi attorno alla Malga Caldea, le abetaie sotto il Monte Calvo e le radure tra Cavadolo e Santa Giulia. Gli stambecchi, introdotti nel 1995 in Val Malga, hanno superato le creste di Premassone e sono passati nella Val d’Avio alla ricerca di un posto di loro gradimento. A tutt’ oggi non si hanno notizie di una loro permanenza stabile nella valle ma comunque il percorso per arrivarci l’hanno imparato. Dal lato storico, la Val d’Avio è legata agli avvenimenti della “Grande Guerra”. Divenuto, all’inizio delle ostilità, il punto di partenza di tutti i rifornimenti per il fronte dell’Adamello, Temù e di conseguenza la Val d’Avio, assunsero un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione logistica di buona parte delle linee avanzate del fronte. Dalla Val d’Avio saliva
tutto il materiale necessario alla vita di ogni giorno per centinaia di soldati
attestati sulle vette e sui ghiacciai dell’Adamello. Fino alla Malga Caldea il trasporto avveniva lungo la strada militare, poi un primo tronco di teleferica consentiva di superare il ripido strapiombo della “Sigosta” fino ai Laghi d’Avio. Da qui, una decauville trasferiva il materiale fino in fondo alla piana dei laghi per poi essere ancora caricato nuovamente su teleferiche che lo convogliavano al Rifugio Garibaldi e ai passi Venerocolo e Garibaldi. Tale organizzazione consentiva al materiale più vario di raggiungere il ghiacciaio del Pian di Neve in brevissimo tempo partendo da Temù. La Val d’Avio è inoltre entrata nella storia della “Guerra bianca” per un particolare evento militare: il trasporto del famoso cannone da 1491G ora sistemato a Cresta Croce. Il pezzo, monumento nazionale e monito contro ogni guerra, pesava oltre 80 quintali e per il suo trasporto vennero impiegati oltre 200 uomini. Partito da Temù il 9 febbraio 1916, raggiunse, dopo varie peripezie la sua prima destinazione, il Passo Venerocolo, il 27 aprile 1916 dove potè contribuire, con l’efficacia dei suoi colpi, alle azioni della primavera del 1916 che portarono alla conquista delle linee nemiche avanzate del Lares-Cavento e della Lobbia-Monte Fumo. Sul versante orografico destro della valle, ai piedi della Val Signora, sopra l’abitato di Pontagna, anche una bella fornace utilizzata fino a 50 anni fa per la cottura della calce , ci riporta lontano nel tempo. La “calchera” era infatti utilizzata ai primi dell’ottocento, così come è riportato in documenti d’epoca e come ci confermano alcune testimonianze orali, quale forno fusorio per la cottura del minerale di ferro estratto in una vena posta più a monte nello stesso avvallamento. Nel tempo poi, la sua utilizzazione ha subito trasformazioni divenendo più importante la produzione della calce ai fini edificatori. Gli abitanti di Temù chiamano la Vai d’Avio con l’appellativo dialettale di “Val di diàuli” (Valle dei diavoli). Si può ritenere che tale toponimo derivi dai tremendi boati provocati dal trascinamento a valle, soprattutto durante i temporali e prima che fossero realizzati i grandi sbarramenti dell’ENEL, di enormi quantità di massi granitici. Nelle notti buie e tempestose, questi rumori ossessionanti devono aver alimentato la fantasia popolare tanto da ritenere che la valle fosse popolata dai diavoli che si scatenavano paurosamente verso i poveri montanari. |