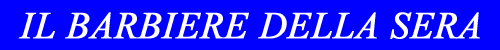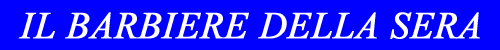
Shiatsu (o Shatzu?)/2
di Fiorello
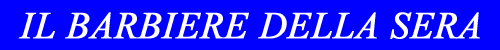
|
Come al solito, in piena liberta'. |
Il quesito d’altri tempi è stato posto in occasione dell’ingresso in Borsa della società i cui titoli, da lunedì scorso, sono scambiati a Piazza Affari. La Cattolica è una cooperativa con un peculiarità statutaria che la distingue da tutte le altre società italiane. Per poter divenire soci è necessario dichiarare di professare la fede cattolica. L’hanno fatto in 28mila. Fino ad oggi, però, la platea dei soci era composta soltanto da persone fisiche. Con la Borsa sarà diverso perché anche investitori istituzionali ed altri soggetti giuridici saranno liberi di acquistare le azioni della società. E se dovessero chiedere l’iscrizione al libro soci, come si potrebbe misurarne il tasso di religiosità? Lo studio di Marchetti ha escluso che possa essere chiesta una dichiarazione di fede ad una società per azioni. Forse nel ‘600, all’indomani del concilio di Trento, ma al giorno d’oggi si finirebbe per essere considerati un po’ strani. Si è così escogitato di porre una "clausola negativa". Il Cda ha stabilito che, nel caso di società, si terrà conto di quanto scritto negli statuti sociali e di eventuali comportamenti "inequivocabilmente" contrari alla religione cattolica. In pratica non saranno giudicate ammissibili allo status di socio - è stato chiarito dagli amministratori di Cattolica durante la conferenza stampa che ha preceduto lo sbarco in Borsa - soltanto le imprese che, negli statuti o nei loro comportamenti, dovessero promuovere religioni diverse dalla cattolica o svolgere attività contrarie alla Chiesa di Roma. Per attenersi a questa regola, però, non è necessario
essere cattolici. E’ sufficiente essere atei. Perché allora
la Cattolica continuerà a invece a richiedere alle persone fisiche
un comportamento "militante"? In attesa che si compia la complessa
marcia di secolarizzazione della compagnia di Camadini rimane
un ultimo quesito. Ora che è in Borsa c’è da chiedersi come
si comporteranno i suoi azionisti nei confronti dei propri amministratori
Forse non si accontenteranno che vadano a messa tutte le domeniche ma che
facciano profitti almeno nei giorni feriali.
I suoi sette componenti (3 rappresentanti dei ministeri vigilanti, un pubblicista e 3 professionisti eletti dalla categoria) percepiscono nel complesso emolumenti per 430 milioni l’anno. Il dato si ricava dal bilancio assestato dell’ente relativo al 2000, approvato nei giorni scorsi dal Cda. Per avere un termine di paragone si può sfogliare l’ultima relazione annuale della Consob, pubblicata nel marzo scorso. In essa la commissione di controllo fa presente che nelle maggiori società italiane (Generali, Fiat, Telecom, per intenderci) i compensi per i sindaci, composti quasi sempre da tre membri, sono pari a 400 milioni di lire all’anno. Ciò che fa lievitare i conti dell’istituto previdenziale è il numero sproporzionato dei membri dell’organo di controllo, stabilito per legge. Ma non solo. All’Inpgi è in vigore uno strampalato sistema di doppia retribuzione. I sindaci provenienti dai ministeri percepiscono un emolumento di circa 70 milioni annui. I rappresentanti della categoria (purchè non in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati) hanno un compenso dimezzato. Il taglio è stato deciso dal Cda come gesto di autoeresponsabilizzazione della categoria in occasione dell‘ultima "limatura" alle pensioni dei giornalisti. I ministeriali non sono stati invece toccati. L’esitazione
dell’ente è comprensibile. A dispetto della privatizzazione, i suoi
atti sono sottoposti al vaglio dei ministeri. Il sistema dei controlli
fa in particolare capo a Michele Daddi, al tempo stesso direttore
generale della Previdenza e presidente del collegio sindacale dell’Inpgi.
Un
bell’esempio di conflitto d’interesse. Daddi infatti vigila sui comportamenti
di amministratori e sindaci dell’ente. Quindi anche su se stesso e sui
suoi emolumenti.
Ma da quando, nel ’93, è stata varata una legge che consente più facilmente agli investitori di ricorrere al giudice quando sono stati violati i loro diritti, qualcosa è cambiato. Le cause societarie, quasi sconosciute in passato, sono circa 200 l’anno. I risultati si vedono. Recentemente il tribunale di Osaka ha condannato 11 amministratori esecutivi di Daiwa Bank a pagare 685 milioni di dollari agli azionisti per aver mal controllato le attività di un broker spregiudicato che ha fatto perdere alla banca un miliardo di dollari. In Italia, dove la struttura del governo societario mostra le stesse debolezze, non c’è neppure la "speranza" rappresenta dal ricorso ai giudici. Chi dovesse promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori, ad esempio, per i diritti violati dei piccoli azionisti in una fusione, dovrebbe aspettare una decina d’anni per la pronuncia definitiva del tribunale. Nel frattempo la società potrebbe aver cambiato nome, essere stata scalata da qualcuno e gli amministratori essere già andati in pensione. E che dire del falso in bilancio che alimenta discussioni e scontri senza fine? Se viene accertato dopo un inter giudiziario di anni, che si fa, si cambiano le poste contabili di tutti gli esercizi successivi, già approvati dagli azionisti e sui quali si sono già pagati i dividendi? La riforma del diritto societario in discussione in Parlamento (il cosiddetto progetto Mirore) si propone tra l’altro di migliorare l’efficacia della giustizia economica istituendo sezioni specializzate nei principali tribunali. Ma l’iter della legge sconta l’ostruzionismo del Polo e degli stessi magistrati (con le sezioni specializzate molte circoscrizioni giudiziarie perderebbero potere). Le possibilità che passi sono ridotte al lumicino. Fiorello
Shiatsu 1 |