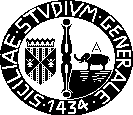 |
GMT 1996
MEDICINA INTERNA
PER ONCOLOGIA CLINICA
INTRODUZIONE e GUIDA ALLO STUDIO, PROGRAMMA
ED ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE
anno accademico 1996-1997
Oncologia Clinica: problemi di Medicina Interna.
® GMT 1996
INTRODUZIONE
Questo corso di medicina interna per oncologia clinica si svilupperà in 24 ore di lezione, integrate con il corso di chirurgia.
Gli orari sono 11.30-14.30 di otto mercoledì successivi (5,12,19,26 marzo e 2, 9,16 e 23 aprile).
Per la parte teorico-pratica verrà svolto anche un programma di approccio col malato; tale programma è minimale, ma orientato agli obiettivi, con accesso coordinato a piccoli gruppi in ambiente clinico.
Il programma del corso include tre parti strettamente interdipendenti:
A) definizione degli obiettivi inerenti i problemi di epidemiologia, prevenzione e diagnosi in oncologia;
B) elementi di classificazione generale, di nosologia, di diagnostica strumentale e di terapia;
C) approfondimento di aspetti particolari .
Valutazione iniziale, in itinere e finale del livello di conoscenza, di apprendimento e di orientamento critico sulla impostazione generale della materia e sugli specifici problemi clinici.
Definizione degli obiettivi inerenti i problemi
di epidemiologia, prevenzione e diagnosi in oncologia
Obiettivo fondamentale del corso è quello di consentire allo studente di sesto anno, già ampiamente informato sulla nosologia delle principali patologie oncologiche e sugli elementi di semeiologia fisica e strumentale,
individuare di fronte al paziente, o al problema clinico simulato, gli elementi di sospetto diagnostico per malattia neoplastica
imparare a procedere per successivi problemi clinici con scelte orientate di diagnostica, non invasiva e invasiva, e di terapia.
Le conoscenze di epidemiologia dei tumori possono essere di aiuto, specie affrontando il problema per gruppi omogenei di popolazione (per esempio nel caso di gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi ambientali).
Le conoscenze in tema di prevenzione (o meglio, di diagnosi precoce, o pre-clinica), oltre che nel caso precedente, rivestono grande importanza in molti settori di patologia, ma specialmente nel caso di patologie neoplastiche con componente ereditaria o con forte caratteri di aumentata incidenza in popolazioni o nuclei familiari.
Inoltre, e non secondariamente, questo corso si propone l’obiettivo di insegnare a riconoscere le modalità di valutazione e di discriminazione tra complicazioni di malattia e patologie associate. In tale contesto, è importante sforzarsi di valutare come tali interferenze possano influire sulla storia naturale della malattia oncologica, sulle scelte diagnostiche e terapeutiche, sulla indicazione a eventuali consulenze specialistiche aggiuntive.
Vengono inclusi quindi i problemi che derivano dalla esecuzione di manovre diagnostiche invasive, da interventi chirurgici, da radioterapia, da chemioterapia, da terapie endocrine e/o immuno-modulanti.
Le interazioni medico-paziente, con la rete di problemi psicologici, sociali ed economici derivanti dai rapporti con famiglia, struttura sanitaria, ambiente di lavoro sono anch’essi parte integrante del complesso di conoscenze e competenze professionali.
Verranno quindi proposte, per esemplificazioni e modelli, in maniera da dare un contributo alla formazione dello studente di medicina riguardo al difficile apprendimento dei modelli di comportamento. A questo riguardo una attenzione particolare viene posta a un esplicito obiettivo:
il paziente con neoplasia (accertata o, peggio, solamente sospettata) in fase avanzata, per metastasi, malattie associate (p.es. cardiopatie) e/o gravità di stadio (p.es. Istologico) di malattia, non va mai considerato un paziente incurabile. Qui e oggi, altrove e/o già domani, la nostra personale ignoranza su un approccio clinico utile al paziente implica, eticamente e legalmente, che la possibilità di una terapia massimalmente adeguata deve sempre essere presa in considerazione, ricercando nella maniera più tempestiva aggiornamenti, pareri, consulenze, anche contro il possibile e frequente atteggiamento fatalista o rinunciatario del paziente, della famiglia, dell’ambiente medico di propria appartenenza. Gli esempi possibili sono troppi, e di alcuni viene data una sintetica descrizione.
Il compito del medico, anche in questo campo, non si esaurisce nella diagnosi, ma deve implicare indicazioni e orientamenti specifici su ambienti specialistici adeguati, e, non infrequentemente, su possibili opzioni di scelta.
Tutto ciò va discusso con il paziente e I familiari più direttamente coinvolti e responsabili, mettendo in bilancio i problemi complessi presenti.
Il giovane medico modificherà e, sperabilmente, perfezionerà tali modelli, sulla base dela propria personalità e delle proprie esperienze: deve comunque avere la consapevolezza che, in questo corso, deliberatamente, viene fatto uno sforzo per analizzare, spiegare e giustificare i modelli proposti, così da potergli fornire gli elementi per pensare ed agire in maniera anche totalmente diversa, ma comunque in piena responsabilità.
Elementi di classificazione generale,
di nosologia, di diagnostica strumentale e di terapia
Questa parte viene qui di seguito sintetizzata come un vero e proprio programma del corso: la nosologia dei tumori viene appresa in maniera sistematica nel corso di Anatomia Patologica, inclusa la classificazione col sistema TNM, che verrà quindi utilizzata.
I) La semeiologia fisica generale, comune a tutta la medicina, si applica ugualmente, e va applicata, al paziente oncologico o con possibile patologia neoplastica.
Elementi di diagnosi precoce, per intervento del medico, sono infatti una anamnesi e una visita condotte in maniera accurata e senza fretta, con l’obiettivo di conquistarsi la disponibilità (del paziente e di eventuali congiunti presenti) a rivelare, o semplicemente a ricordare, elementi spesso utili per un adeguato indirizzo diagnostico.
II) Non infrequentemente, sono altri i motivi che indirizzano il medico, di fronte al paziente, ad approfondimenti diagnostici che conducono alla individuazione di una malattia neoplastica.
1) Diagnostica di grande diffusione come routine o per altre patologie:
esami emato-chimici, esami delle feci e delle urine, esami endoscopici, radiografie ossee o del torace, ecografia internistica, visite oculistiche, etc.
2) Aspetti epidemiologici: fumo, alcol, tossici ambientali, radioattività, farmaci, dieta e nutrizione, inquinamento ambientale, agenti infettivi, suscettibilità genetica.
3) Marcatori tumorali e altri esami di screening; a questo proposito, vengono fornite e discusse le raccomandazioni della Società Americana di Oncologia.
4) Sindromi paraneoplastiche
5) Manifestazioni strettamente endocrine delle neoplasie
6) Effetti neurologici e dermatologici non metastatici in corso di patologie neoplastiche
III) Una trattazione sintetica viene proposta su principi generali di nutrizione, terapia farmacologica e radioterapia, e su aspetti particolari di terapia del dolore e di medicina riabilitativa.
Tempi, modalità e tecniche di approccio chirurgico, e comunque invasivo (radiologia interventistica, anche palliativa, chemioterapia e radioterapia loco-regionale) vengono rimandati, ovviamente, alla trattazione delle competenze chirurgiche e radiologiche di questo corso integrato, anche se, occasionalmente, ne viene fatto cenno, a completamento del quadro complessivo di specifici problemi o argomenti clinici.
IV) Argomenti specifici di trattazione sono invece:
1) Principi generali di terapia farmacologica in oncologia;
2) Effetti sfavorevoli legati alla terapia oncologica
3) Emergenze oncologiche
4) Malattia metastatica a sede primitiva sconosciuta
5) Problemi oncologici in gravidanza
V) Alcune forme neoplastiche di maggiore prevalenza nella nostra popolazione vengono trattate in maniera specifica, con approccio clinico orientato alla sintomatologia di esordio
1) masse superficiali,
2) anemia,
3) dimagramento,
4) stipsi-diarrea e altri disturbi digestivi,
5) tosse,
6) febbre,
7) dolore viscerale, osseo o cefalea,
8) disturbi endocrini,
9) ematuria,
10) meno-metrorragie.
Tali quadri sintomatologici pongono spesso difficili problemi di diagnosi differenziale, con frequenti ingiustificati allarmi; ma , altrettanto spesso, la sintomatologia può essere sottovalutata o ricondotta a interpretazioni diagnostiche per banali patologie, con ritardi nella diagnosi e condizionamento sfavorevole della prognosi.
In maniera coordinata e sintetica vengono riproposti:
1) Neoplasie del colon-retto
2) Masse neoplastiche del torace
3) Neoplasie renali
4) Neoplasie di pertinenza ginecologica
5) Carcinoma mammario
6) Carcinoma prostatico
7) Neoplasie gastriche e pancreatiche
8) Tumori tiroidei
9) Linfomi, plasmocitomi e neoplasie ossee
10) Neoplasie ipofisarie e cerebrali.
A questa introduzione seguono i quesiti di autovalutazione, a risposta multipla, finalizzati a una verifica delle conoscenze di base dello studente; fanno riferimento esplicito alla trattazione schematica dell’argomento che li ha preceduti, ma spesso implicano un utilizzo di conoscenze derivanti da altri corsi e altri manuali di studio.
Parte di questi quesiti sono presentati e discussi una prima volta insieme; successivamente, in alcuni casi con piccole modifiche, venono messi a disposizione di ogni studente per un’autovalutazione che deve servire come traccia per uno studio degli argomenti.
L’iterazione dei quesiti e la sequenza con cui vengono proposti non è casuale nè frutto di disattenzione: implica invece l’intenzione a indirizzare la logica di chi vi studia, cercando anche di correggere alcune forme di coazione a pensare - e in futuro ad agire - che non sono in accordo con lo stato attuale delle conoscenze.
Non viene fornita una chiave di risposte corrette perchè gli obiettivi di questi esercizi sono: a) sollecitare la riflessione e il recupero delle conoscenze già acquisite; b) rivedere i capitoli pertinenti; c) stimolare a una discussione tra colleghi di studio; d) scoraggiorne un utilizzo competitivo.
Non si tratta infatti di pacchetti di domande per esami, ma, al contrario, di gruppi di affermazioni e di concetti abbastanza pertinenti e da riorganizzare nell’ambito delle proprie conoscenze.
A questo proposito lo studente può e deve utilizzare i capitoli pertinenti dei manuali di medicina interna (Rugarli, Harrison, Teodori), anatomia patologica (Robbins, Anderson, Lanza), farmacologia, radiologia ma, soprattutto, chirurgia (Dionigi, Sabiston), che tradizionalmente trattano più in esteso la materia.
Utilizzi comunque i libri su cui ha già studiato, che sicuramente conservano anche delle nicchie pertinenti per questo corso di oncologia clinica, a suo tempo poco esplorate dallo studente.
Per chi fosse interessato a un più approfondito studio, invece, i trattati di riferimento per questo corso sono Kelley e Cecil per la medicina interna e DeVita, Holland e Bonadonna per l’oncologia medica.
Infine, per chi fosse già abituato a un approccio di studio multimediale, nella parte teorico-pratica vengono fornite informazioni utili per un approfondimento di studio in rete.
Si segnalano qui di seguito alcuni siti di interesse oncologico, a carattere divulgativo-didattico, ma anche scientifico, in italiano
http://sos.unige.it/irccs/oncolist.html
http://sos.unige.it/sosita/soconco.html
http://www.cro.ets.it/main/itaindex.htm
I siti di interesse oncologico in lingua straniera sono assai numerosi. Si segnalano qui quelli che al momento attuale appaiono più utili e vicini agli interessi degli studenti di questo corso, cominciando però da un sito francese
e continuando con i siti propriamente americani, alcuni dei quali di riviste specialistiche che mettono in rete gli articoli in esteso
http://www.webmedlit.com/topics/OncoLit.html
Journal of the National Cancer Institute
http://www.infobiogen.fr/agora/journals/cancer/homepage.htm
The Cancer Journal. Offre editoriali e rassegne in campo oncologico in esteso
Questa Istituzione offre un interessante servizio oncologico
Interessanti sono anche i siti
http://daisy.moffitt.usf.edu/cancjrnl/ccj.html
del Cancer Control Journal
La cosiddetta medicina "palliativa", cioè quel complesso di competenze e disposizioni professionali rivolte ai pazienti con malattie assai gravi, avanzate e terminali, specie oncologiche, è tuttora carente nelle professionalità, nelle norme istituzionali e, forse soprattutto, nell’iter formativo dei medici. Alcuni di questi siti, spesso riccamente "ipertestuali" possono fornire un’utile introduzione al problema:
http://www.edifolini.com/BOLL.ONCO/bollettino_onco.html
http://www.asap-care.com/home.htm
http://www.ejpc.co.uk/ejpc.online
http://www.medicineau.net.au/clinical/palliative/home.html
http://www.palliative.org/pc_home.html
http://www.palliative-medicine.org/links
QUESITI E PROBLEMI A SCELTA DI RISPOSTA MULTIPLA
A] Scegli tra i seguenti quesiti la singola risposta più appropriata:
1) Quale è il numero di cellule tumorali che determina un volume di solito già apprezzabile clinicamente?
a) 109
b) 1010
c) 1011
d) 1012
e) 1015
quanto peserebbe, approssimativamente, una massa tumorale, in rapporto al numero di cellule?
2) Quale dei seguenti agenti infettive non è associato alla insorgenza di neoplasie
a) epatite B e C
b) Aspergillus Flavus
c) virus di Epstein-Barr
d) Helicobacter Pylori
e) Enthamoeba Histolytica
come approfondiresti la diagnostica strumentale di fronte al riscontro occasionale di un nodulo epatico di 10-30 cc?
3) Quale dei seguenti farmaci non è riconosciuto come carcinogenico nell’uomo
a) azatioprina
b) fenacetina
c) contracettivi orali (estrogeni+progesterone)
d) estrogeni coniugati
e) dietilstilbestrolo (DES)
quale è il farmaco oggi più importante nel trattamento dei pazienti trapiantati?
B] associa nella maniera più pertinente possibile le condizioni di seguito elencate
4) a) dermatomiosite d) carcinoma renale
b) eritrocitosi e) tutte le neoplasie
c) ipercalcemia f) carcinom di colon, rene, polmone, mammella
5) a) Ca-125 d) carcinoma prostatico
b) Ca 19-9 e) carcinoma ovarico
c) PSA f) carcinomi del colon
6) a) Tamoxifene d) carcinoma renale
b) Flutamide e) carcinoma prostatico
c) interleuchine f) carcinoma mammario
7) a) Radon e) carcinoma vescicale
b) Asbesto/amianto f) adenocarcinomi naso e seni paranasali
c) polvere di legno g) neoplasie pleuro-polmonari
d) benzidina, -naftil-amine,
4-amino-bifenile
Scegli la risposta più appropriata a proposito di neoplasie metastatiche a sede primitiva sconosciuta e che resta tale a successivi controlli:
8) la frequenza tra tutte le malattie neoplastiche è
a) 3-12%
b) 0.5-2%
c) 10-30%
9) tra questi pazienti, in quale percentuale non si rivela neanche all’autopsia la sede di origine?
a) 1%
b) 16%
c) 30%
10) in quale pecentuale si riscontrano tipi rari di neoplasie, melanomi neuroblastomi etc ?
a) 5%
b) 20%
c)30%
11) la localizzazione metastatica viscerale nelle forme di carcinoma scarsamente differenziato è frequente (85% dei pazienti):
a) la terapia attualmente ancora più adottata è la chemioterapia con cisplatino
b) la radioterapia full-body dà i risultati migliori
c) una laparotomia esplorativa è spesso la scelta diagnostica e terapeutica più vantaggiosa
Un paziente di 63 anni, normopeso, longilineo, si presenta in ambulatorio per astenia, tosse secca, febbricola da due settimane, dolore all’emitorace dx.
a) alla visita non si apprezza nulla di significativo in torace
b) l’epigastrio è dolente e avete l’impressione di una resistenza profonda
c) non vi è evidente anemizzazione
d) il paziente è fumatore
12) quali di questi esami non fate eseguire in prima istanza:
a) broncoscopia
b) esame delle feci
c) crioglobulinemia
d) CEA
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
nello stesso paziente:
13) un aumento della gamma-GT >100 UI vi suggerisce un approfondimento diagnostico o una domanda specifica, quale?
a) TAC del torace
b) prova da sforzo elettrocardiografica
c) il paziente fa uso di alcolici ?
d) il paziente è diabetico ?
nello stesso paziente:
14) quale dei seguenti elementi successivi vi indirizza alla opportunità di una pan-colonscopia
a) positività per adenocarcinoma delle linfoghiandole laterocervicali
b) leucocitosi neutrofila
c) ipoalbuminemia
d) ves aumentata
nello stesso paziente:
15) una immagine ecografica o tac di irregolarità o incremento di dimensioni a livello delle surrenali indica sempre:
a) metastasi da neoplasia polmonare
b) sindrome diCushing
c) il reperto può non essere indicativo di neoplasia
d) localizzazione linfomatosa
nello stesso paziente:
16) la presenza di versamento pleurico quale esame suggerisce di eseguire:
a) ecocardiografia
b) biopsia pleurica
c) scintigrafia total-body
d) ago-aspirato tiroideo
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
nello stesso paziente:
17) quale di questi test non ha pertinenza nella diagnostica delle opacità polmonari
a) test di Kveim-Siltzbach
b) anticorpi anti-micoplasmi
c) test di Ghedini-Weinberg
d) PSA
18) quale di queste condizioni può dare una sindrome da malassorbimento con ipoalbuminemia
a) carcinoma renale con trombosi venosa
b) linfomi
c) epatocarcinoma
d) poliposi del colon
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
A proposito di carcinoma mammario
19) oltre l’80% dei casi si verifica dopo i 40 anni o in menopausa
a) vero
b) falso
20) la parentela di primo grado (sorelle-figlie) aumenta il rischio relativo di 1.6-6 volte
a) vero
b) falso
21) il 90% delle pazienti hanno una familiarità positiva per ca mammario
a) vero
b) falso
22) mutazioni specifiche nei cromosomi 17 e 13 predispongono a un rischio del 50-80% oltre i 50 anni di età
a) vero
b) falso
23) la terapia estrogenica a basso dosaggio per il trattamento dell’osteoporosi aumenta il rischio di ca mammario del 50-100%
a) vero
b) falso
24) dolore e tensione sono quasi sempre presenti a livello dei noduli mammari neoplastici
a) vero
b) falso
25) il 30% delle donne con ca mammario pur senza coinvolgimento dei linfonodi ascellari vanno incontro, nel tempo, a metastasi a distanza
a) vero
b) falso
26) la presenza di recettori per gli estrogeni è più frequente nelle donne in post-menopausa e ne migliora la prognosi
a) vero
b) falso
27) il pamidronato è un farmaco particolarmente indicato nel trattamento delle ipocalcemie secondarie
a) vero
b) falso
28) il taxol è un recente e utile farmaco per il trattamento del carcinoma mammario
a) vero
b) falso
29) il trattamento con doxorubicina determina nel 10% e più dei pazienti miocardiopatie dilatative
a) vero
b) falso
A proposito di neoplasie polmonari
30) i peptidi bombesino-simili e altri fattori di crescita autocrini inibiscono la crescita dei ca polmonari
a) vero
b) falso
31) se il tempo di duplicazione di una massa polmonare è molto rapido (minore di sei settimane) o molto lento (maggiore di 18 mesi), il sospetto per una lesione polmonare maligna è molto alto
a) vero
b) falso
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
32) la presenza di calcificazioni nel contesto di una lesione polmonare suggerisce la diagnosi di malattia più benigna
a) vero
b) falso
A proposito di neoplasie intestinali
33) le neoplasie più comuni del colon sono gli adenomi benigni o polipi adenomatosi
a) vero
b) falso
34) la maggior parte degli adenomi del colon evolvono in carcinomi entro cinque anni
a) vero
b) falso
35) un follow-up endoscopico dopo polipectomia colonscopia è sempre indicato a intervalli di 1-3 anni
a) vero
b) falso
36) la maggior parte dei pazienti con poliposi familiare sviluppano un carcinoma del colon
a) vero
b) falso
37) circa il 70% dei carcinomi colo-rettali coinvolgoo il colon sinistro , il sigma o il retto
a) vero
b) falso
38) le modifiche dell’alvo, con stipsi, e presenza di sangue rosso nelle feci sono frequenti nel carcinoma del colon destro
a) vero
b) falso
39) l’iposideremia, con o senza anemia, in soggetti oltre i 60 anni, richiede sempre una attenta valutazione per neoplasie gastro-intestinali
a) vero
b) falso
40) i livelli di CEA possono elevarsi prima che siano evidenti sintomi o anormalità di altri esami di laboratorio in pazienti con cancro del colon metastatico
a) vero
b) falso
41) le neoplasie del tenue costituiscono 1-2% di tutte le neoplasie gastro-intestinali
a) vero
b) falso
42) i pazienti con malattia celiaca , Crohn o AIDS hanno un rischio maggiore (x10-x20) per linfomi
a) vero
b) falso
43) un segno clinico frequente nelle neoplasie intestinali sono gli edemi discrasici
a) vero
b) falso
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
44) la febbre non è mai presente nelle neoplasie gastro-intestinali
a) vero
b) falso
a proposito di neoplasie renali:
45) i carcinomi renali vengono più frequentemente diagnosticati tra i 60 e i 70 anni
a) vero
b) falso
46) il rapporto maschi/femmine è di 1/2
a) vero
b) falso
47) la triade ematuria, dolore e presenza di massa addominale palpabile si osserva in oltre il 50% dei pazienti
a) vero
b) falso
48) febbre, calo ponderale, anemia o policitemia, ipercalcemia, segni di insffucenza epatica non metastatica sono tutti segni che assai frequentemente si manifestano in pazienti con carcinoma renale e possono restare abbastanza a lungo l’unico sintomo.
a) vero
b) falso
a proposito di neoplasie renali:
49) i sintomi sistemici non possono essere eliminati con l’ablazione del tumore primitivo
a) vero
b) falso
50) l’invasione delle vene renali per se , anche con trombosi cavale sovra-diaframmatica, influenza sfavorevolmente la prognosi
a) vero
b) falso
Una donna di 35 anni, in sovrappeso, ma con recente calo ponderale, si presenta alla visita con dolore epigastrico, a tratti lancinante, diffuso a tutto l’addome e posteriormente, alleviato dalla posizione fetale; vomito biliare e mucoso, ipotensione arteriosa, sudorazione algida. Assenti febbre, ittero e anemizzazione.
51) A una urgente richiesta di esami di laboratorio di routine, quale esame non associate:
a) trigliceridemia
b) amilasemia
c) cpk
d) Waaler-Rose
nella stessa paziente:
52) quale quadro ecografico addominale si addice meno alla descrizione clinica
a) dilatazione gastrica
b) ingrandimento della loggia pancreatica
c) litiasi biliare
d) aneurisma dell’aorta addominale
53) un prolungamento del tratto QT all’elettrocardiogramma non concorda con
a) avvelenamento da digitale
b) ipocalcemia
c) necrosi pancreatica
d) ischemia miocardica
54) quale delle seguenti condizioni e sindromi cliniche non si associa a un aumentato rischio di carcinoma del pancreas
a) pancreatite cronica
b) pancreatite acuta
c) età superiore ai 40 anni
d) sesso maschile
55) alcuni di questi segni, tranne uno, sono sintomi assai frequenti nel carcinoma del pancreas
a) dolore addominale anche notturno prolungato, persistente, modificato dai decubiti
b) ittero
c) precoce perdita di peso e malassorbimento
d) ipoglicemia
56) nella stadiazione di un carcinoma pancreatico potenzialmente operabile, dopo la valutazione ecografica, vanno eseguiti tutti questi esami tranne uno
a) esame citologico per ago-aspirato - agobiopsia -
b) colangiopancreatografia endoscopica retrograda
c) TAC e RMN
d) ecografia endoscopica
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
57) quale di queste condizioni può fare erroneamente sospettare un carcinoma del pancreas, e reciprocamente:
a) depressione psichica
b) ulcera duodenale o gastrica
c) colonpatia irritabile
d) rene policistico
58) il dolore nelle neoplasie pancreatiche viene usualmente trattato con fans e/o oppiacei (codeina morfina); l’effetto di tali analgesici può essere potenziato dai seguenti farmaci, tranne:
a) antistaminici
b) amitriptilina
c) ace-inibitori
d) amfetamine
A proposito di neoplasie epatiche
59) gli angiomi sono i più frequenti tumori epatici, rilevabili ecograficamente nel 4-8% della popolazione adulta
a) vero
b) falso
60) si tratta invariabilmente di forme benigne, asintomatiche, che non comportano alcun rischio per chi ne è affetto
a) vero
b) falso
perchè (commento sintetico)_________________________________
_______________________________________________________________
61) gli adenomi epato-cellulari sono 10 volte più frequenti tra gli uomini rispetto alle donne
a) vero
b) falso
62) i carcinomi epatocellulari di solito si osservano in fegati cirrotici
a) vero
b) falso
A proposito di neoplasie gastriche
63) come per il colon, 90-95% delle neoplasie gastriche sono benigne
a) vero
b) falso
64) i linfomi tipo Hodgkin rappresentano il 5-10% di tutte le neoplasie maligne dello stomaco
a) vero
b) falso
65) in quale romanzo italiano esiste la descrizione puntigliosa della storia naturale di una neoplasia gastrica
a) I vicerè
b) Mastro don Gesualdo
c) Il Gattopardo
d) Il sorriso dell’ignoto marinaio
e) nessuno
66) quale/i di questi segni è sempre presente nei pazienti con carcinoma gastrico prima della diagnosi di certezza endoscopica e biopsica
a) sangue occulto nelle feci
b) massa epigastrica
c) CEA e/o Ca19-9 elevati
d) nessuno
67) attualmente la chirurgia, anche estesa all’omento, ai linfonodi peri-portali, al pancreas e alla milza fornisce la sola forma di terapia nei carcinomi dello stomaco
a) vero
b) falso
68) già la presenza di metastasi ai linfonodi perigastrici riduce la sopravvivenza a 5 anni a meno del 15%
a) vero
b) falso
69) i carcinomi gastrici sono altamente radiosensibili
a) vero
b) falso
70) la resezione di carcinomi gastrici, limitati alla mucosa e alla sottomucosa, senza interessamento dei linfonodi perigastrici, può rivelarsi curativa in oltre 80% dei pazienti.
a) vero
b) falso
perchè (commento sintetico)______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
A proposito di tumori ossei
71) Il coinvolgimento dell’osso da parte di malattie neoplastiche è di solito dovuto a metastasi da altre sedi primitive
a) vero
b) falso
72) prostata e seno producono di solito lesioni miste, litiche e blastiche, mentre le lesioni da metastasi da rene e polmone danno lesioni osteolitiche
a) vero
b) falso
73) gli osteosarcomi metastatizzano precocemente in altre parti dello scheletro
a) vero
b) falso
74) negli osteosarcomi si osserva un incremento della fosfatasi alcalina
a) vero
b) falso
75) Il sarcoma di Ewing, anche se altamente maligno, risente favorevolmente di chemioterapia e resezione chirurgiche , sino a una frequenza di trattamenti risolutivi favorevolmente di oltre 50%
a) vero
b) falso
76) Il sarcoma di Ewing, a più elevata prevalenza in età pediatrica e giovanile, si manifesta con sintomi locali e generali (malessere, febbre, brividi) che possono molto ritardare un corretto orientamento diagnostico.
a) vero
b) falso
a proposito di carcinoma ovarico
77) i carcinomi ovarici sono, tra le neoplasie ginecologiche, quelle a prognosi più infausta
a) vero
b) falso
78) l’uso di contracettivi orali e la multiparità ne aumentano il rischio
a) vero
b) falso
79) nella maggior parte delle pazienti una diffusione metastatica addominale è già presente al momento della diagnosi
a) vero
b) falso
80) elevati livelli di CA-125 non sono indicativi di sospetto diagnostico per carcinoma ovarico nelle donne in menopausa
a) vero
b) falso
81) un clisma opaco e/o una colonscopia sono quasi sempre indicate anche se la diagnosi di carcinoma ovarico è già confermata
a) vero
b) falso
82) pur in rapporto allo stadio della malattia, un approccio chirurgico radicale ed esteso (utero, annessi, segmenti del colon) implica una prognosi migliore, soprattutto come qualità di vita
a) vero
b) falso
83) la chemioterapia con carboplatino, spesso associata o doxorubicina, o con taxol o con taxotere, mostra una risposta favorevole in 1/3-2/3 delle pazienti
a) vero
b) falso
Quale/i delle neoplasie sottoelencate va indagata per prima, e come, in pazienti che presentano le sintomatologie o le caratteristiche descritte
84) lenta velocità di accrescimento, mortalità associata a insufficenza cardiaca e/o epatica, crisi di malessere generale, talvolta con lacrimazione ed edema periorbitale, diarrea cronica, ipoalbuminemia
a) linfoma gastrico
b) poliposi del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
85) astenia generalizzata,dimagramento, occasionalmente episodi di broncocostrizione, fehato da stasi, reazioni eritematose scatenate dai pasti e, soprattutto, da alcolici
a) linfoma gastrico
b) poliposi del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
86) occlusione intestinale, soffio sistolico sulla tricuspide, teleangectasie cutanee nella regione mandibolare, epatomegalia dolente
a) linfoma gastrico
b) poliposi del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
87) ipoalbuminemia, dolore lombare, anemia, lombosciatalgia
a) linfoma gastrico
b) poliposi del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
88) anemia ipocromica, stipsi cronica, coliche addominali
a) linfoma gastrico
b) poliposi/carcinoma del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
89) febbricola, dolore alla spalla, dimagramento, dolore epigastrico, parestesie periferiche
a) linfoma gastrico
b) poliposi del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
90) marcata astenia, paralisi flaccida, insufficenza renale, evidenza di metastasi epatiche, acidosi metabolica, iperglicemia
a) neoplasia pancreatica
b) carcinoma del colon
c) adenocarcinoma bronchiale
d) sindrome da carcinoide
e) carcinoma renale
quale/i esami faresti eseguire_______________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
91) il concetto di "maligno" per le neoplasie cerebrali è legato alla sede anatomica e alla possibilità di completa exeresi chirurgica
a) vero
b) falso
92) i segni non focali di aumentata pressione intracranica - cefalea, nausea, vomito, confusione mentale, alterazioni comportamentali, stato soporoso) sono spesso gli unici presenti, persino con neoplasie di notevoli dimensioni, per localizzazioni in sede frontale o parietale - zone silenti -
a) vero
b) falso
93) la comparsa improvvisa di crisi convulsive in un adulto non è un segno di possibile neoplasia cerebrale
a) vero
b) falso
94) Carcinoma renale e carcinoma polmonare non a piccole cellule tendono a dare metastasi cerebrali multiple "miliari"
a) vero
b) falso
95) Più alti livelli di CEA non indicano che la neoplasia possiede maggiori invasività e capacità di dare metastasi
a) vero
b) falso
96) un declino dei livelli di CEA con la terapia indica generalmente una risposta favorevole
a) vero
b) falso
97) nelle pazienti con carcinoma ovarico il mancato ripristino di valori normali di CA-125 con chemioterapia indica una patologia farmaco-resistente
a) vero
b) falso
98) un incremento di CA 15-3 in pazienti con carcinoma mammario è di valore assai limitato per monitorizzare recidive, metastasi e carcinomatosi peritoneale
a) vero
b) falso
99) la diagnosi precoce di carcinoma prostatico con dosaggio di PSA non ha avuto alcun effetto sulla mortalità per tale patologia
a) vero
b) falso
100) livelli di PSA ancora dosabili due mesi dopo terapia chirurgica indicano la persistenza della malattia
a) vero
b) falso
101) la presenza di hCG e/o di -fetoproteina , pur a livelli discretamente elevati, nell’uomo o nella donna non gravida, non indica spesso la presenza di una neoplasia
a) vero
b) falso
102) i dosaggi di albumina e di 2-microglobulina sono di grande importanza nella valutazione della prognosi dei pazienti con mieloma.
a) vero
b) falso
prova a commentare la tua risposta prendendo in considerazione le complicazioni legate alla storia naturale di questa malattia.
103) la lattico-deidrogenasi (LDH) ha importanza nella diagnostica della cardiopatia ischemica acuta, ma non in oncologia
a) vero
b) falso
104) neoplasie non APUD sono più spesso associate con la produzione di peptidi (PTH-RP, PLP) che determinano alterazioni della omeostasi calcica
a) vero
b) falso
105) la produzione ectopica di ormoni da parte di molte neoplasie è frequente, ma la incidenza di sindromi paraneoplastiche clinicamente apprezzabili è rara o assai tardiva
a) vero
b) falso
commenta:
106) nel carcinoma polmonare a piccole cellule ipokalemia e alcalosi, astenia generale, edemi declivi si associano a livelli assai elevati di ACTH e di coritisolo,
a) vero
b) falso
107) i pazienti con ipercalcemia secondaria a neoplasia hanno quasi sempre bassi livelli di PTH e di AMPc urinario
a) vero
b) falso
108) molti tumori mesechimali - emangiopericitoma e leiomiosarcomi, fibrosarcomi retroperitoneali, carcinomi cortico-surrenali ed epatomi - determinano una sindrome iperglicemica legata alla produzione di ILG-II
a) vero
b) falso
commenta:
109) la SIADH non ha alcuna importanza clinica, ma è solo un segno minore in molte neoplasie; non richiede alcun trattamento
a) vero
b) falso
commenta:
110) una sintomatologia neurologica che insorge in un paziente oncologico è di regola dovuta a metastasi cerebrali, e quindi l’approccio diagnostico e, se possibile, terapeutico (chemioterapia, irradiazione, chirurgia) deve essere rapido
a) vero
b) falso
VALUTAZIONE FINALE - ESAME DI PROFITTO -
Per quanto si possa ironizzare sulla tendenza degli studenti a scambiare l’università per un esamificio, è implicazione profonda di ogni impegno didattico la massima disponibilità a una verifica del livello di conoscenze e professionalità acquisite con l’impegno di studio personale da parte del singolo studente.
Ciò significa che i quesiti proposti come test di autovalutazione sono esattamente esercizi di studio, per stimolare curiosità, dubbi e capacità di critica.
Troppe volte, se non sempre, il medico è solo di fronte al paziente e alla malattia, mentre in un colloquio d’esame studente e docenti sono uniti in una solidarietà d’intenti per contribuire a un lavoro di formazione professionale.
Le conoscenze elementari di medicina interna per oncologia clinica vanno espresse in sede di colloquio formale, essenzialmente seguendo questo schema di esposizione:
A) definizione (cenni di quadri istologici)
B) approccio col malato (sintomatologia di presentazione, eventuali segni fisici)
C) priorità e sequenzialità di diagnostica di laboratorio e strumentale
D) orientamenti generali di priorietà e sequenzialità di terapia.
E) orientamento generale sulla prognosi di pazienti trattati in maniera adeguata -
possibilità nel trattamento di forme già in stadio avanzato.
Non si richiede cioè nè l’esposizione di un protocollo chemioterapico, e men che meno la descrizione di una tecnica chirurgica, ma piuttosto se e quando attuare una o più modalità terapeutiche (medica, chirurgica, radioterapica, analgesica etc) in quel particolare contesto.
Gli argomenti di esame, in parte già discussi all’inizio, vengono qui ordinatamente riproposti:
1) Principi generali di terapia farmacologica in oncologia;
2) Effetti sfavorevoli legati a terapie oncologiche
3) Emergenze oncologiche
4) Malattia metastatica a sede primitiva sconosciuta
5) Problemi oncologici in gravidanza
6) masse superficiali
7) anemia
8) dimagramento
9) stipsi-diarrea e altri disturbi digestivi
10) tosse, raucedine, disfonia, disfagia, disturbi vestibolari e/o uditivi
11) febbre
12) dolore viscerale, osseo e cefalea
13) disturbi endocrini
14) ematuria
15) meno-metrorragie.
16) Neoplasie del colon-retto
17) Masse neoplastiche del torace
18) Neoplasie renali
19) Neoplasie di pertinenza ginecologica
20) Carcinoma mammario
21) Carcinoma prostatico
22) Neoplasie esofagee, gastriche , pancreatiche e apudomi
23) Neoplasie epatiche e delle vie biliari
24) Tumori tiroidei
25) Linfomi, plasmocitomi e neoplasie ossee
26) Neoplasie ipofisarie e cerebrali.
27) Melanomi e neoplasie cutanee
28) Terapia del dolore
GMT 1996
CALENDARIO DELLE LEZIONI E ARGOMENTI (2000-2001)
elenco studenti in corso e CALENDARIO DEGLI ESAMI 2000-2001
PROGRAMMA della MEDICINA INTERNA VI anno , 2001-2002
CALENDARIO DELLE LEZIONI E ARGOMENTI (2000-2002)
elenco studenti in corso e CALENDARIO DEGLI ESAMI 2000-2002
RIMANDI
© GMT 2001 Guglielmo M.Trovato, Docente di Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Catania